"Secret life": la scienza deve essere morale?
TORINO – Il dubbio è amletico e senza soluzione: alla scienza e al progresso possono essere applicabili norme morali, comportamenti etici, etichette e patenti di giusto o sbagliato? Oppure l'Uomo può, e deve forse, cercare di studiare come poter superare i propri limiti, applicare intelligenza e strumentazioni per gettare uno sguardo sul domani, sul futuro, creare qualcosa che non esiste, sbirciare verso l'ignoto dello sconosciuto per renderlo, appunto, conosciuto e fruibile? L'uomo è fatto e composto di curiosità, senza queste caratteristiche si inaridisce, muore, si secca come un albero senz'acqua. Al tempo stesso qualcuno ci spiega che gli scienziati dovrebbero studiare e inventare e ingegnarsi solo nelle scoperte “buone” per l'umanità, scoperte pure che portino soltanto benefici. Ma chi è che decide e controlla la  bontà di queste innovazioni? Non esistono cose né parole né oggetti buoni o cattivi, esiste solamente il contesto, il come, la loro applicazione nel reale. Se costruisco un'arma, quella stessa non sparerà da sola. Un'arma è un pezzo di ferro che può portare alla morte solo se un umano premerà il grilletto. Quindi il libero arbitrio è il cardine ma l'uomo crede sempre, per assicurarsi un alibi buono per ogni stagione, di essere troppo debole e che davanti ad una pistola sicuramente, prima o poi, sarà portato dagli eventi (non dalla sua coscienza e scelta intima) a schiacciare il grilletto rimandando la responsabilità del proprio gesto all'oggetto invece che sul soggetto (lui stesso) che ha compiuto l'atto.
bontà di queste innovazioni? Non esistono cose né parole né oggetti buoni o cattivi, esiste solamente il contesto, il come, la loro applicazione nel reale. Se costruisco un'arma, quella stessa non sparerà da sola. Un'arma è un pezzo di ferro che può portare alla morte solo se un umano premerà il grilletto. Quindi il libero arbitrio è il cardine ma l'uomo crede sempre, per assicurarsi un alibi buono per ogni stagione, di essere troppo debole e che davanti ad una pistola sicuramente, prima o poi, sarà portato dagli eventi (non dalla sua coscienza e scelta intima) a schiacciare il grilletto rimandando la responsabilità del proprio gesto all'oggetto invece che sul soggetto (lui stesso) che ha compiuto l'atto.
Il regista Manfredi Rutelli ed i suoi LST Teatro scelgono sempre testi con ampie finestre di riflessione, propongono un teatro che tra le righe, negli anfratti delle pieghe, dentro le parole riesca ogni volta a scardinare crepe, aprire spiragli, non dare verità ma concedere il beneficio del dubbio, socchiudendo parentesi dentro le quali approfondire, ascoltare più campane, instillare punti interrogativi di una dialettica mai fine a se stessa ma che spazi all'interno di un ventaglio di possibilità oltre l'ideologia, oltre il pensiero unico, al di là di indottrinamenti e prese di posizione tanto nette quanto ottuse.  In questo “Secret Life”, testo dell'inglese David Byrne mai proposto né tradotto in Italia prima di questa versione a cura della compagnia chiancianese (presentato all'interno del composito Earthink Festival, rassegna dedicata ad ambiente e sostenibilità, per la direzione artistica di Serena Bavo, dal 9 al 17 settembre in vari spazi torinesi, dall'Atelier Spazio Fisico allo Spazio Kairos, dallo Spazio Cecchi all'Imbarchino del Parco del Valentino fino all'Off Topic e alla Cascina Filanda) attraverso felici incastri temporali si dialoga proprio sul filo flebile e tremolante della scienza che ha sempre il cannocchiale spostato su ciò che non c'è e la morale che tenta non tanto di comprendere il reale ma piuttosto di normarlo, controllarlo, assoggettarlo a regole politiche. Quindi se da un lato lo scienziato studia il possibile, la morale del presente tenta di tirare le redini, frenare, fermare o soltanto rallentare un processo comunque inevitabile e ineluttabile. Non puoi dire all'uomo di non “aprire quella porta” sul futuro, sarà la prima cosa che tenterà di fare.
In questo “Secret Life”, testo dell'inglese David Byrne mai proposto né tradotto in Italia prima di questa versione a cura della compagnia chiancianese (presentato all'interno del composito Earthink Festival, rassegna dedicata ad ambiente e sostenibilità, per la direzione artistica di Serena Bavo, dal 9 al 17 settembre in vari spazi torinesi, dall'Atelier Spazio Fisico allo Spazio Kairos, dallo Spazio Cecchi all'Imbarchino del Parco del Valentino fino all'Off Topic e alla Cascina Filanda) attraverso felici incastri temporali si dialoga proprio sul filo flebile e tremolante della scienza che ha sempre il cannocchiale spostato su ciò che non c'è e la morale che tenta non tanto di comprendere il reale ma piuttosto di normarlo, controllarlo, assoggettarlo a regole politiche. Quindi se da un lato lo scienziato studia il possibile, la morale del presente tenta di tirare le redini, frenare, fermare o soltanto rallentare un processo comunque inevitabile e ineluttabile. Non puoi dire all'uomo di non “aprire quella porta” sul futuro, sarà la prima cosa che tenterà di fare.
Fondamentale, a livello scenico ma anche drammaturgico, è stata la scelta di applicare alla scena dei grandi pannelli che hanno una doppia intelligente resa meccanica: possono infatti essere retroilluminati e proporre un'aura, una parvenza, un'essenza che arriva da un altro tempo sperso nell'Universo, ectoplasmi provenienti da altre dimensioni, defunti che dialogano e interagiscono nella linea del presente, oppure ruotare su se stessi, come porte di un saloon, aprendo sliding doors sconosciute, spalancando nuove idee o soltanto mostrando plausibili verità nascoste o anche, come il titolo ci suggerisce, vite segrete. Possiamo suddividere “Secret Life” in tre trance temporali: il professore Bronowsky, personaggio realmente esistito, scienziato e divulgatore (una sorta di Piero Angela, affabile, preciso, didattico e didascalico e al tempo stesso figura positiva entrata in tutte le case grazie ai documentari BBC con il suo fare amichevole e accogliente, spiegando argomenti complicati con un linguaggio semplice e adatto a tutti), la moglie vissuta per quarant'anni dopo la scomparsa del coniuge, il nipote al giorno d'oggi.
Bronowsky è Gianni Poliziani, presenza predominante, imponente e importante, voce calda e profonda (ci ha ricordato quella del doppiatore dell'uomo d'affari John Hammond ideatore di Jurassic Park), perno dell'affabulazione sul quale ruota tutta la piece, il nipote invece è Alessandro Waldergan nella sua fisicità dinoccolata gioca il suo lato da Paperino, tra lo scoordinato e l'ingenuo, attirando le simpatie della platea, Francesco Pompilio è una valida spalla, il collaboratore dello scienziato, la professoressa è Enrica Zampetti, veramente convincente, una sorta di presentatrice che introduce prima per poi entrare in scena, sempre lucida in questo dentro e fuori, vero ago della bilancia dei vari posizionamenti sul palco, infine la moglie è Clara Galante, precisa, dà colore e pienezza, oltre che ironia.
Si ride di noi, del genere umano, di quello che eravamo e di quello che siamo diventati, da cacciatori sanguinari ad inventori fino ai giorni nostri dove al massimo (non) riusciamo ad aprire una scatoletta o siamo imbambolati tutto il giorno davanti a video di gattini. Anche la decelerazione è un'accelerazione, negativa ma pur sempre un'accelerazione, come a dire che l'evoluzione può avere anche momenti dove sembra che non si stia andando avanti mentre qualcuno sta comunque lavorando per proporre sistemi alternativi, non sempre migliorativi dello status quo ma pur sempre tentando (spesso, forse sempre, per fini commerciali e non per il benessere dell'uomo o del Pianeta, sia chiaro) di cercare altre vie, nuove strade per affrontare il domani nebuloso, a tratti confondendolo ancora di più.
 I pannelli in trasparenza, quasi dissolvenza cinematografica, creano un gap sia temporale che spettrale sia nel differenziare i personaggi in vita, davanti, rispetto a quelli che parlano dal loro passato. Brunowsky era un uomo irreprensibile, onesto, benvoluto e stimato da tutti, collaboratori e telespettatori (un nostro Enzo Tortora, per intenderci) mentre lo scandagliare dentro le sue stanze segrete, portando alla luce i suoi studi sulla bomba potenzialmente devastante per l'Umanità, potrebbero distruggerne l'immagine. Un testo che ci parla di sociologia e antropologia ma anche di quanto siamo disposti a scommettere sul futuro dell'Uomo, di quanta fiducia abbiamo in lui e nelle istituzioni che ci governano e sull'annosa questione del “chi contro
I pannelli in trasparenza, quasi dissolvenza cinematografica, creano un gap sia temporale che spettrale sia nel differenziare i personaggi in vita, davanti, rispetto a quelli che parlano dal loro passato. Brunowsky era un uomo irreprensibile, onesto, benvoluto e stimato da tutti, collaboratori e telespettatori (un nostro Enzo Tortora, per intenderci) mentre lo scandagliare dentro le sue stanze segrete, portando alla luce i suoi studi sulla bomba potenzialmente devastante per l'Umanità, potrebbero distruggerne l'immagine. Un testo che ci parla di sociologia e antropologia ma anche di quanto siamo disposti a scommettere sul futuro dell'Uomo, di quanta fiducia abbiamo in lui e nelle istituzioni che ci governano e sull'annosa questione del “chi contro lla i controllori”. Una drammaturgia che ci porta dentro gli studi sull'umanità e sulla nostra evoluzione, che procede a strappi e ad elastico, “il progresso corre che noi umani si sia pronti o meno”. Ma se si ha paura del futuro e dei suoi inevitabili cambiamenti allora vivremo nel terrore, impantanati nel fango dell'immobilismo, stretti e costretti dentro comfort zone sempre più asettiche e senza ossigeno. Se consideriamo anche la guerra come un frutto dell'ingegno umano (anche Leonardo da Vinci la studiava per rendere possibile la vittoria per i propri committenti) allora anche gli studi di Einstein o Enrico Fermi sulla bomba atomica (in questo ci ha ricordato la piece “Copenhagen” di Michael Frayn) devono essere visti e considerati in quest'ottica. Anche perché l'evoluzione dell'Uomo è andata di pari passo con distruzioni e guerre, l'annientamento dei nemici, l'estinzione di popoli (la storia la scrivono i vincitori) ed “essere umani vuol dire essere dannosi, distruttori e fare di tutto per sopravvivere”, anche attaccare altre nazioni: “Ad Auschwitz e Nagasaki non è stato il gas, sono stati i matematici”. Poi arriva la stilettata finale, vera e preoccupante, più realistica che pessimistica: “Andremo avanti fin quando non arriverà qualcosa che ci farà fermare come specie”. Un testo necessario (ben recitato, il che non guasta) sul nostro passato e sul nostro futuro. Sul presente invece siamo troppo invischiati e coinvolti per poterne fare un affresco super partes.
lla i controllori”. Una drammaturgia che ci porta dentro gli studi sull'umanità e sulla nostra evoluzione, che procede a strappi e ad elastico, “il progresso corre che noi umani si sia pronti o meno”. Ma se si ha paura del futuro e dei suoi inevitabili cambiamenti allora vivremo nel terrore, impantanati nel fango dell'immobilismo, stretti e costretti dentro comfort zone sempre più asettiche e senza ossigeno. Se consideriamo anche la guerra come un frutto dell'ingegno umano (anche Leonardo da Vinci la studiava per rendere possibile la vittoria per i propri committenti) allora anche gli studi di Einstein o Enrico Fermi sulla bomba atomica (in questo ci ha ricordato la piece “Copenhagen” di Michael Frayn) devono essere visti e considerati in quest'ottica. Anche perché l'evoluzione dell'Uomo è andata di pari passo con distruzioni e guerre, l'annientamento dei nemici, l'estinzione di popoli (la storia la scrivono i vincitori) ed “essere umani vuol dire essere dannosi, distruttori e fare di tutto per sopravvivere”, anche attaccare altre nazioni: “Ad Auschwitz e Nagasaki non è stato il gas, sono stati i matematici”. Poi arriva la stilettata finale, vera e preoccupante, più realistica che pessimistica: “Andremo avanti fin quando non arriverà qualcosa che ci farà fermare come specie”. Un testo necessario (ben recitato, il che non guasta) sul nostro passato e sul nostro futuro. Sul presente invece siamo troppo invischiati e coinvolti per poterne fare un affresco super partes.
Tommaso Chimenti 16/09/2022
Foto: Luca Matassoni
Garibaldi di Kaemmerle e Rutelli: simbolo di libertà e giustizia
SANTA MARIA A MONTE – Tutti noi pensiamo di conoscere bene la figura di Garibaldi. L'eroe dei Due mondi, Anita, i Mille, l'Obbedisco, le mille targhe viste in ogni città dove sta scritto “Qui ha dormito”. Eppure c'è molto da dire, da tirare fuori dalle pastoie del tempo, da quello che superficialmente crediamo o abbiamo letto di sfuggita senza approfondire. Nozionismo da cruciverba più che altro, al quale la presenza di Andrea Kaemmerle (che il phisique du role per interpretarlo a dir la verità ce lo ha sempre avuto) e la penna fine di Manfredi Rutelli hanno deciso di porvi finalmente rimedio in equilibrio tra la loro inconfondibile ironia, sagacia senza forzature, e una storiografia documentaristica, mai pedante ma preziosa e precisa, delineando un personaggio tout court che non può essere definito se non compreso nella sua interezza, senza limiti, soprattutto in relazione ai tempi in cui ha vissuto. Una vita eccezionale, fuori dagli schemi, per forza leggendaria, sopra le righe, eccentrica, altissima, morale. (Un intermezzo fuori dal coro e fuori dal contesto: “Garibaldi” era anche il soprannome che Maria Cassi dava al suo (e nostro) caro cuoco/chef/scrittore Fabio Picchi, ideatore e curatore del Teatro del Sale e del Cibreo di Firenze, da poco scomparso, che ci manca e che non dimenticheremo). E poi vogliamo ricordare la canzoncina (vagamente canzonatoria) ritornello-stornello “Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda, che comanda i bersaglier”, declinando tutte le parole con le cinque vocali per far ridere i bambini?
Ecco da qui il sottotitolo, “Garibaldi, su una gamba”. Garibaldi colpito da fuoco amico nell'agosto del 1862. Ma la vita di GG è per sua stessa natura eroica, convulsa, piena di accadimenti irripetibili, unici, a tratti impossibili: decine di giri del mondo, viaggi in Giappone, ha abitato a Instambul come a New York, tre mogli, infiniti amori, quindici figli ufficiali, arresti e sempre fughe ed evasioni rocambolesche, parlamentare in cinque Stati sovrani diversi. La coppia Kaemmerle e Rutelli decidono per la via non temporale, non progressiva, non didascalica, senza date né appigli né punti di riferimento nel classico incedere, sua firma e cifra, dell'attore che, nella sua corpulenza che si fa parola e carne, gesti e mani a prendere  e calcare e tenere e abbracciare tutta la platea, farla propria, un cunto (tutto toscano) che diventa cascata e valanga a strapiombo fin quando non ti sommerge, ti ingloba, fin quando non si fagocita il pubblico. Ha questo potere Kaemmerle di essere esplosivo, di cullare e mordere, di carezzare per infine stilettare con forza, dolce e rude sembra di sentire la tridimensionalità delle sue parole come polpastrelli rustici su gote vergini. Il pubblico ne è travolto, sempre, e lo lascia fare come un turbinio, come un vortice, come una tromba d'aria in mezzo al mare che tutto trancia portando con sé. Raccontare la vita di Garibaldi è impossibile, una volta capito questo assunto la strada è già in discesa.
e calcare e tenere e abbracciare tutta la platea, farla propria, un cunto (tutto toscano) che diventa cascata e valanga a strapiombo fin quando non ti sommerge, ti ingloba, fin quando non si fagocita il pubblico. Ha questo potere Kaemmerle di essere esplosivo, di cullare e mordere, di carezzare per infine stilettare con forza, dolce e rude sembra di sentire la tridimensionalità delle sue parole come polpastrelli rustici su gote vergini. Il pubblico ne è travolto, sempre, e lo lascia fare come un turbinio, come un vortice, come una tromba d'aria in mezzo al mare che tutto trancia portando con sé. Raccontare la vita di Garibaldi è impossibile, una volta capito questo assunto la strada è già in discesa.
Ma questo “Garibaldi” procede in una triangolazione originale: non è il Garibaldi narrato dall'autobiografia vergata da Alexandre Dumas né quello tratteggiato dalla coppia di divulgatori Piero Angela-Alessandro Barbero, ma quello che emerge dal ritratto che ne fa Luciano Bianciardi, altro caposaldo della cultura kaemmerliana. La genesi del play è di ritrosia e di disamore: Kaemmerle, che ama e idolatra Bianciardi, crede che lo scrittore toscano, anarchico e polemico, abbia fatto il generale in camicia rossa letterariamente a pezzi. Invece si ritrova le pieghe delle pagine grondanti di stima, di rispetto per l'uomo, per le idee, per il suo lascito. Quello che colpisce non è tanto la sua lezione in vita, che qualcuno potrebbe paragonare ad un Che Guevara più romantico e un po' più annacquato, ma quanto nel tempo, dopo la sua morte, ad ogni latitudine, si sono prodigati, promossi e moltiplicati i movimenti garibaldini e i garibaldinismi che continuano a tramandare quei valori tutt'oggi, in vario modo, a vario titolo. Garibaldi che in vita era una vera rockstar, un semidio intoccabile e le cui gesta, in un mondo senza grandi mezzi di comunicazione, erano seguite grazie a dispacci e bollettini da più parti del mondo. Era un simbolo indomito, di libertà, di potere è volere, repubblicano, anticlericale, senza posa, senza padroni né padrini.
L'inizio è accattivante con una sorta di confessione di un imputato che, davanti alla Storia, di profilo e con la voce artefatta di un'eco taroccata e meccanica, esprime il suo disappunto di fronte a questo personaggio che realmente nessuno di noi conosce ma del quale abbiamo soltanto qualche piccola nozione sparsa. Ed è vero quello il testo ci dice: “Le statue di Garibaldi ti guardano dall'alto in basso come a dirti Ho fatto l'Italia vedi di non sporcarmela”. Garibaldi, che si è speso e battuto contro il Potere, è diventato nell'immaginario comune, per nostra assoluta ignoranza, il Potere stesso in una traslitterazione che confligge con la realtà degli accadimenti. Kaemmerle, grazie anche all'escamotage del personaggio inesistente, la madre di GG con la quale dialoga, ora è il narratore adesso è lo stesso capitano di ventura: il più grande navigatore, più di Marco Polo, più di Cristoforo Colombo. Il suo primo viaggio per mare, a poco più di vent'anni, è da Marsiglia a  Odessa in barca a vela per caricare del vino. La sua iconografia grafica ci ricorda un po' Gesù, un po' Sandokan e un po' Marx, abbracciando gli estremi, facendo toccare gli antipodi in un unico simbolo. Personaggio mosso da istinti semplici ma proprio per questo il suo messaggio è arrivato in ogni Continente ed è sentito uno del popolo in ogni Nazione nella quale ha messo piede. La Regina Vittoria, così come Marx, non lo vorrà incontrare perché Garibaldi aveva la peculiarità di mettere in ombra chiunque talmente la sua popolarità era ingombrante. Le sue innumerevoli spedizioni vennero foraggiate tra gli altri anche da Verdi, conobbe Victor Hugo, a New York lavorava per Meucci mentre Abramo Lincoln gli scrisse una lettera per assoldarlo come generale nella guerra civile tra Nordisti e Sudisti. Questo “Garibaldi” è una sorta di Zibaldone dove le notizie vengono sparate come pallettoni di carabine e ognuna sembra inverosimile, quanto meno strana o irreale. Una vita avventurosa è il minimo che si possa dire per descrivere quella del Giuseppe Nazionale. Bene hanno fatto Kaemmerle e Rutelli nel riscoprire questa sua imponente figura (teatralmente quasi non affrontata) che tutti crediamo di conoscere (qui la falla della scuola) ma che soltanto pochi hanno percezione della straordinarietà della sua vita sempre in viaggio, sempre in battaglia, sempre pronto all'azione, senza mai tirarsi indietro davanti a nessuna causa, sempre moralmente coerente con i propri valori.
Odessa in barca a vela per caricare del vino. La sua iconografia grafica ci ricorda un po' Gesù, un po' Sandokan e un po' Marx, abbracciando gli estremi, facendo toccare gli antipodi in un unico simbolo. Personaggio mosso da istinti semplici ma proprio per questo il suo messaggio è arrivato in ogni Continente ed è sentito uno del popolo in ogni Nazione nella quale ha messo piede. La Regina Vittoria, così come Marx, non lo vorrà incontrare perché Garibaldi aveva la peculiarità di mettere in ombra chiunque talmente la sua popolarità era ingombrante. Le sue innumerevoli spedizioni vennero foraggiate tra gli altri anche da Verdi, conobbe Victor Hugo, a New York lavorava per Meucci mentre Abramo Lincoln gli scrisse una lettera per assoldarlo come generale nella guerra civile tra Nordisti e Sudisti. Questo “Garibaldi” è una sorta di Zibaldone dove le notizie vengono sparate come pallettoni di carabine e ognuna sembra inverosimile, quanto meno strana o irreale. Una vita avventurosa è il minimo che si possa dire per descrivere quella del Giuseppe Nazionale. Bene hanno fatto Kaemmerle e Rutelli nel riscoprire questa sua imponente figura (teatralmente quasi non affrontata) che tutti crediamo di conoscere (qui la falla della scuola) ma che soltanto pochi hanno percezione della straordinarietà della sua vita sempre in viaggio, sempre in battaglia, sempre pronto all'azione, senza mai tirarsi indietro davanti a nessuna causa, sempre moralmente coerente con i propri valori.
Tommaso Chimenti 12/09/2022
Gli Oracoli di Garzella: corpi di fango e materia celeste
COLTANO – Metti un Armistizio che alle nostre latitudini stiamo ancora aspettando in maniera completa, metti la sopraggiunta e improvvisa morte della Regina Pop per eccellenza, metti un'inflazione galoppante e i tassi d'interesse europei aumentati, metti una campagna elettorale estiva acida e rancorosa in atto, metti una guerra evitabile e al tempo stesso banale e preventivabile ed ecco, nel flusso inconscio, concatenarsi questa colata di “Oracoli”, caravanserraglio-presepe e metafora viaggiante dove camminare, correre, perdersi cercando la luce, annusando i bagliori, profumando  le epifanie di lampi in questa notte pesta dell'Umanità. Alessandro Garzella (autore e regista) e i suoi Animali Celesti abitano, smuovono e spostano e fanno loro lo spazio di legno e stalle, di fieno e Far West, di staccionate e zoccoli nella Pineta di Coltano (dalle parti di Pisa) dove sopra passano aerei rancidi con le loro ali molli e il becco a punta verso destinazioni sconosciute nei loro gridi di kerosene e carburanti pompati sulle nuvole innocenti. Qui si recuperano cavalli e asini che hanno subito maltrattamenti, abusati, vilipesi, torturati, bestie bellissime e vederle nel chiaroscuro della notte, mentre la performance rumorosa continua il proprio giro e compie il proprio gioco e giogo, ha un sapore di favola riuscita, di capolavoro risolto, di chiusura del cerchio, la Natura che ha preso nuovamente per mano l'Uomo e insieme hanno portato a compimento l'avventura della salvezza. In questo bosco pare che Pinocchio si mischi a Moby Dick e l'Utopia di Don Chisciotte si possa finalmente toccare, mordere, lisciare. C'è il sogno ma anche la tangibilità delle pozzanghere, l'alta sfera della poesia sparsa, tra capezzoli al vento
le epifanie di lampi in questa notte pesta dell'Umanità. Alessandro Garzella (autore e regista) e i suoi Animali Celesti abitano, smuovono e spostano e fanno loro lo spazio di legno e stalle, di fieno e Far West, di staccionate e zoccoli nella Pineta di Coltano (dalle parti di Pisa) dove sopra passano aerei rancidi con le loro ali molli e il becco a punta verso destinazioni sconosciute nei loro gridi di kerosene e carburanti pompati sulle nuvole innocenti. Qui si recuperano cavalli e asini che hanno subito maltrattamenti, abusati, vilipesi, torturati, bestie bellissime e vederle nel chiaroscuro della notte, mentre la performance rumorosa continua il proprio giro e compie il proprio gioco e giogo, ha un sapore di favola riuscita, di capolavoro risolto, di chiusura del cerchio, la Natura che ha preso nuovamente per mano l'Uomo e insieme hanno portato a compimento l'avventura della salvezza. In questo bosco pare che Pinocchio si mischi a Moby Dick e l'Utopia di Don Chisciotte si possa finalmente toccare, mordere, lisciare. C'è il sogno ma anche la tangibilità delle pozzanghere, l'alta sfera della poesia sparsa, tra capezzoli al vento  e una band malinconica sospesa tra matrimoni e funerali, questi pini marittimi che illuminati prendono forme e sembianze, diventano alti giganti e i loro rami braccia e le loro chiome teste di Jimi Hendrix che puntano a leccare queste nubi grigio scure gonfie e cariche ma calde, scenografiche, fondali pannosi spessi ovattati come cuscini di un Alice nel Paese delle Meraviglie scomposto, scoordinato, disunito.
e una band malinconica sospesa tra matrimoni e funerali, questi pini marittimi che illuminati prendono forme e sembianze, diventano alti giganti e i loro rami braccia e le loro chiome teste di Jimi Hendrix che puntano a leccare queste nubi grigio scure gonfie e cariche ma calde, scenografiche, fondali pannosi spessi ovattati come cuscini di un Alice nel Paese delle Meraviglie scomposto, scoordinato, disunito.
Wunderkammer come ogni passaggio e step e passo dentro questa avventura (della durata di due ore), un vagabondare andante di anime dantesche con candele in mano ad incontrare strumenti stonati e spaventapasseri inquietanti, ma soprattutto ombre a disegnare un terreno che perde contorni e si sfalda, si sfarina, si appropria di altri sensi e significati, si trascina, tracima, si amplia, si sgranchisce, si snocciola. Un asino raglia, un cane abbaia lontano: è la vita che ci riporta con i piedi per terra e ci fa sentire piccoli e inutili in mezzo a questo grande deserto che stiamo attraversando fatto di vicoli e radure, di strade strette tra i rovi per poi aprirsi nel grande circo di corse sudate e manichini antropoformi, di statue e sculture cesellate dalla fiochezza della Luna nascosta nel tambureggiante della nebbia che distorce, nasconde, cela. Il cammino è un andare incontro alle proprie paure e sentimenti, andare in faccia, a specchio, a verità elargite da un guru sotto ad un albero, un Maestro che sembra fuso con i suoi arti tra le radici di questo antico fusto sopra il quale scimmiescamente si aggrovigliano e salgono,  s'arrampicano e s'accapigliano anime come liane, personaggi letterari tra sibille e ballerine, misteri animaleschi al ritmo di trombettisti e fanfare. Gli oracoli declinano ed elencano i Miracoli, possibili, eventuali, potenziali, pirotecnici, futuribili, di Vita, Morte e Dio a miscelarsi, creare amalgama, una pasta solida inscindibile. Questo “Oracoli” è un play teatrale che prende forza grazie al pubblico che si lascia guidare, si lascia condurre in questo spazio magico, fuori dal tempo, una sospensione fortunata, una parentesi tutta da cogliere e respirare.
s'arrampicano e s'accapigliano anime come liane, personaggi letterari tra sibille e ballerine, misteri animaleschi al ritmo di trombettisti e fanfare. Gli oracoli declinano ed elencano i Miracoli, possibili, eventuali, potenziali, pirotecnici, futuribili, di Vita, Morte e Dio a miscelarsi, creare amalgama, una pasta solida inscindibile. Questo “Oracoli” è un play teatrale che prende forza grazie al pubblico che si lascia guidare, si lascia condurre in questo spazio magico, fuori dal tempo, una sospensione fortunata, una parentesi tutta da cogliere e respirare.
E' un continuo colorato portarsi via carnasciale, di corpi infusi d'eros, di canti tra il proibito e la preghiera e nel naso l'odore dell'erba bagnata, il profumo dell'umido della notte di fine estate e quella patina di rugiada che imperversa, attinge e fa cappa alle suole delle scarpe come al respiro confuso da tanto nuovo vergine ossigeno. Bisogna lasciare andare gli occhi senza soffermarsi sugli incroci e sugli incastri, sul fluire dei passaggi, sulle trame e le frontiere, accogliere i sensi senza doversi spiegare versi e concatenazioni talmente è l'ammasso e il flusso di coscienza che esonda felice nelle performance (dieci musicisti e una ventina di performer tra i quali spiccano Ilaria Bellucci, Satyamo Hernandez, Sara Capanna, Chiara Pistoia, Carlo Gambaro,  Francesca Mainetti) che diventano atto in una sovrabbondanza, caustica e ricca, di parole, mo(vi)menti, tentativi. Ti puoi soffermare su una sorta di sposa-Marilyn, ti puoi far catturare e affascinare dalle campane della Chiesa che rintoccano e ti svegliano dal torpore, puoi rimanere invischiato nel riflettere se, come dice la domanda in loop, nella tua vita “sei vittima o boia”. La comunicazione è aperta, i sensi dosano la loro forza cercando anche i dettagli inesistenti in una piena condivisione tra attori e pubblico e Luogo e Natura. Le parole non sono compartimenti stagni (né patimenti) ma hanno facce e volti e sostanza e riesci a vederle tridimensionali, ora Angeli, adesso Demoni, ora carezze, adesso bestemmie. Siamo innocenti e siamo allo stesso tempo anche Orchi che cercano il loro posto nel mondo, la strada per raggiungersi, per ricongiungersi.
Francesca Mainetti) che diventano atto in una sovrabbondanza, caustica e ricca, di parole, mo(vi)menti, tentativi. Ti puoi soffermare su una sorta di sposa-Marilyn, ti puoi far catturare e affascinare dalle campane della Chiesa che rintoccano e ti svegliano dal torpore, puoi rimanere invischiato nel riflettere se, come dice la domanda in loop, nella tua vita “sei vittima o boia”. La comunicazione è aperta, i sensi dosano la loro forza cercando anche i dettagli inesistenti in una piena condivisione tra attori e pubblico e Luogo e Natura. Le parole non sono compartimenti stagni (né patimenti) ma hanno facce e volti e sostanza e riesci a vederle tridimensionali, ora Angeli, adesso Demoni, ora carezze, adesso bestemmie. Siamo innocenti e siamo allo stesso tempo anche Orchi che cercano il loro posto nel mondo, la strada per raggiungersi, per ricongiungersi.
“Oracoli” non può che essere un grande rito collettivo d'iniziazione, grandemente architettato, supportato, gestito, dove vengono snocciolati i Miracoli (dopotutto siamo vicini a Pisa e al suo Campo dei Miracoli) che, negli interstizi tra Cielo e Terra, tra le pieghe della Realtà, tra le righe del mondo e dei suoi abitanti, capitano, occorrono, si palesano, si manifestano oppure solamente avrebbero potuto e invece non sono stati capaci di materializzarsi. Le luci che si innalzano da terra in questo bosco sembrano esplosioni cosmiche, aurore boreali verdi e blu in cerca di un abbraccio accogliente e incandescente. “Cogli l'attimo” ci grida un urlo evergreen che ridesta le nostre priorità tra i rumori accordati e armoniosi di una sega suonata con l'archetto, in questi spiazzi di polvere che sanno di sale e Apocalisse, di Luna piena e di Luna Park, di balle di fieno e di balle di fiele. Immersi in questa festa-concerto gitano non possiamo far altro che seguire la corrente come salmoni, attratti dalla luce, dallo sbocco sul fondo, rincorriamo la triste euforia, la ricerca della grazia, della gabbia come della malinconia, la liberazione, la santità e la pazzia, la cura e la malattia, l'inizio e la fine. Siamo le carte degli Oracoli, siamo gli Ultimi da salvare. Meno male che ci sono ancora gli Animali Celesti, anime della Volta Celeste, spazio di manovra, pensiero libero.
Tommaso Chimenti 10/09/2022
Fotografie di Michele Lischi
Festival dei Due Mondi: ottimo Lidi, entusiasmanti Rezza/Mastrella, controverso Ostermeier
SPOLETO – Difficilmente, in un festival teatrale italiano, è possibile trovare tanta qualità nella stessa giornata in tre spettacoli differenti per concezione, idea, messinscena ma ugualmente illuminati, densi, pieni di riverberi e riflessioni. A Spoleto anche le pietre parlano, i vicoli con gli archetti ti abbagliano, le giraffe installate in città ti danno il benvenuto, il Duomo ci scuote, le affascinanti chiese aprono i loro portoni, i giardini che sorgono in mezzo all'arte e all'architettura ci accolgono. A Spoleto, al “Festival dei Due Mondi”, si è fatta (e si continua a fare) la grande storia teatrale del nostro Paese.
E allora respiriamo, prendiamo a pieni polmoni le atmosfere cechoviane de “Il Gabbiano” (prod. Teatro Stabile Umbria, ERT/Teatro Nazionale, Teatro Nazionale Torino), curato e maneggiato con classe, padronanza ed eleganza da Leonardo Lidi, sempre idee più fervide e mature, che ha creato un dispositivo semplice e leggero quanto efficace con uno spazio vuoto e aperto, scarno in un teatro dal palco divelto, come se non restasse più niente apocalitticamente, con una panchina sullo sfondo dove i personaggi stanno prima di affrontare la loro scena (quindi sempre presenti e visibili) e una panca da giardino in prima battuta dove effettivamente i dialoghi si accendono e si spengono, dove gli addii si sprecano per poi non andarsene più, dove i mai e i purtroppo si sprecano e l'indomani tutto resta com'è senza nessun sussulto.
Tre i punti da sottolineare: in primis la griglia delle luci che prima sta in alto, a metà spettacolo scende a limitare la visuale e a fare da cappa claustrofobica a questo manipolo di pseudofelici che boccheggiano di speranza di vita e novità, e infine la stessa griglia che si poggia a terra, fine delle illusioni, fine delle luci per illuminare il domani, diventando a sua volta sedia dove posarsi oppure ostacolo da saltare. Secondo step: il ballo finale con la musica che lentamente rallenta e gracchia e allo stesso tempo le coppie nella danza si raggomitolano, si raggrinziscono, si ingobbiscono, diventano ad ogni giro di valzer sempre più anziane e vecchie e decrepite in un ballo lunghissimo durato tutta la vita cominciato da giovani e finito tra le rughe senza nel mezzo ricordarsi cosa è successo, cosa abbiamo fatto se non perdere tempo. Terzo ma più importante, un cast d'eccezionale performatività che gioca tutto il suo stato di grazia tra un profondo scollamento dalla realtà, in questo parallelismo della finzione teatrale metafora dell'esistenza dove si entra in scena e si recita un soggetto e un ruolo, e un'ironia volutamente caustica. Dieci attori mirabili, dai movimenti misurati, dagli sguardi centellinati, dalle voci che ti entrano dentro, passi bilanciati in un equilibrio impossibile tra esistenze da trapezisti dove cercare di non cadere (invece che tentare di volare) rimane l'unico vero compito da portare faticosamente, sfibrante, a termine.
Detto che tutti e dieci creano un tessuto e un clima netto e sicuro, tenace e rassicurante, dobbiamo necessariamente sottolineare Massimiliano Speziani – lo scrittore Trigorin, folgorante nelle impercettibili mosse di cuore e intonazione, Francesca Mazza – l'attrice Irina, in perenne ambivalenza tra la durezza e la ricerca di comprensione, Ilaria Falini – Masa, luttuosa depressa che suscita vicinanza, si muove sul filo dell'incomprensione e dell'infelicità, Christian La Rosa - Konstantìn Gavrìlovič, ancora una splendida prova ottenuta con una fitta tela di passaggi portati sulle tavole con una semplicità disarmante, Giuliana Vigogna – Nina, grande forza e delicatezza, sensibilità e compassione. Un cast felice e solare dove sono tutti sull'orlo di un burrone, tentano di salvarsi ma inesorabilmente sono nuovamente attratti come magneti da quel cornicione, da quel limite che sanno di non dover superare senza però nemmeno allontanarsene, non riuscendo a respingere da sé tutto quello che gli sta facendo male anzi riproponendolo meccanicamente per poi lamentarsene. Un vorrei ma non posso all'ennesima potenza, da mancanza di ossigeno, da sentirsi impotenti per l'impossibilità di cambiare il corso delle cose.
E'  la metafora del gabbiano che potrebbe librarsi alto, simbolo della libertà, e che invece finisce per farsi uccidere (volontariamente, forse non soppesando i rischi) dalla noia. Tutti insoddisfatti per motivi diversi, ognuno di loro che ci parla, oggi, a suo modo, ognuno di essi che ci guarda dall'abisso del tempo chiedendoci se siamo felici, se stiamo facendo qualcosa per esserlo, chiedendoci se stiamo vivendo o se è la vita che ci sta passando addosso come un carrarmato. La seconda ipotesi è sempre la più facile, quella di non prendersi la responsabilità della propria soddisfazione, potendo sempre contare sull'alibi di addossare le colpe del proprio insuccesso al Fato, al Destino gramo, agli Dei, ai comportamenti degli altri. Quando il dramma ha una punta di (auto)ironia è ancora più feroce e brutale.
la metafora del gabbiano che potrebbe librarsi alto, simbolo della libertà, e che invece finisce per farsi uccidere (volontariamente, forse non soppesando i rischi) dalla noia. Tutti insoddisfatti per motivi diversi, ognuno di loro che ci parla, oggi, a suo modo, ognuno di essi che ci guarda dall'abisso del tempo chiedendoci se siamo felici, se stiamo facendo qualcosa per esserlo, chiedendoci se stiamo vivendo o se è la vita che ci sta passando addosso come un carrarmato. La seconda ipotesi è sempre la più facile, quella di non prendersi la responsabilità della propria soddisfazione, potendo sempre contare sull'alibi di addossare le colpe del proprio insuccesso al Fato, al Destino gramo, agli Dei, ai comportamenti degli altri. Quando il dramma ha una punta di (auto)ironia è ancora più feroce e brutale.
Si parla ancora di insoddisfazioni personali nel nuovo lavoro di Rezza/Mastrella, “Hybris” (prod. Rezza/Mastrella, La Fabbrica dell'Attore-Teatro Vascello; coprod. Spoleto Festival dei Due Mondi, Teatro di Sardegna) che risente assolutamente del clima di lockdown e privazioni, di costrizioni dentro le quattro mura domestiche. Oggetto feticcio centrale è una porta, con tanto di stipite, che Antonio Rezza, sempre più funambolo e Puk, in piena forma smagliante, atletico e ruspante, muove e posiziona davanti agli altri malcapitati attori-performer, manichini in carne ed ossa, spalle per far esplodere l'eccentricità disarmante e deflagrante del capocomico felicemente accentratore di parole e movimenti e attenzioni. Come una calamita tutto parte da lui e tutto a lui è rivolto, ogni gesto, manifestazione, angolazione da qui nasce e cresce. Il testo è una sottolineatura, una reiterazione, un loop dove proprio il ripetersi si fa mantra, ci affascina il suono, ci culla per poi, infine, deliziarci provocatoriamente con il suo scatto lessicale ferino, i suoi scarti linguistici selvaggi, la sua semantica intelligente e tagliente.
La porta, in questa riflessione postmoderna, è sia il tramite per raggiungere gli altri come la frontiera per dividersene, il limite di Romolo e Remo, quella linea di demarcazione per indicare  che cosa può stare al di qua o al di là del segno convenzionale. Quella porta che negli ultimi due anni abbiamo identificato come salvezza e salvaguardia, per allontanarci dagli altri quali portatori di patologie. Questa porta che si apre infinite volte con violenti e caustici Sbam da fumetto che ancora risuonano nei timpani come scansione ritmica precisa e puntuale, come sottolineatura della battuta, che si chiude altrettanto celermente perché la misantropia è galoppante e l'uomo è sì un essere sociale che ha bisogno degli altri ma la pandemia lo ha profondamente mutato accentuando la deriva di autoconservazione e autoaffermazione scambiando le possibilità della tecnologia e della modernità per progresso. Siamo sempre più chiusi dentro i nostri loculi e abbiamo paura dell'esterno e dell'incontro con gli altri sempre portatori di conflitti e contrasti. Ma che cos'è l'Hybris? E' “l'orgogliosa tracotanza che porta l'uomo a presumere della propria potenza e fortuna e a ribellarsi contro l'ordine costituito, divino e umano, immancabilmente seguita da vendetta o punizione divina”.
che cosa può stare al di qua o al di là del segno convenzionale. Quella porta che negli ultimi due anni abbiamo identificato come salvezza e salvaguardia, per allontanarci dagli altri quali portatori di patologie. Questa porta che si apre infinite volte con violenti e caustici Sbam da fumetto che ancora risuonano nei timpani come scansione ritmica precisa e puntuale, come sottolineatura della battuta, che si chiude altrettanto celermente perché la misantropia è galoppante e l'uomo è sì un essere sociale che ha bisogno degli altri ma la pandemia lo ha profondamente mutato accentuando la deriva di autoconservazione e autoaffermazione scambiando le possibilità della tecnologia e della modernità per progresso. Siamo sempre più chiusi dentro i nostri loculi e abbiamo paura dell'esterno e dell'incontro con gli altri sempre portatori di conflitti e contrasti. Ma che cos'è l'Hybris? E' “l'orgogliosa tracotanza che porta l'uomo a presumere della propria potenza e fortuna e a ribellarsi contro l'ordine costituito, divino e umano, immancabilmente seguita da vendetta o punizione divina”.
Pecchiamo, abbiamo peccato di poter fare a meno dei nostri simili e così ci siamo inariditi, chiusi nelle nostre celle a doppia mandata. Ma se una cosa non può entrare necessariamente neanche ciò che è all'interno può uscire, quindi lo spazio, fisico ma anche di sguardo e di riflessione sul mondo circostante, si affievolisce, si incupisce, si mortifica. Rezza, sempre surreale e dadaista, vestito da fachiro ipercolorato, quasi mummia che esce dal sarcofago è devastante nella sua fisicità che va di pari passo con una dialettica raffinata, iperaccelerata, sagace e animalesca che si fa gramelot dove perdersi volontariamente ma mai dolcemente: “Siete giovani. Diverticoli” o “Grazie di desistere”, l'apocalisse è qui, è già in atto e non ce ne rendiamo conto. Siamo l'orchestra che continua a suonare sul Titanic ormai in fase d'affondamento. La casa piccola, la casa modesta fino ad arrivare alla casa molesta ovvero alla violenza domestica o la porta che diventa metal detector, la sciagura del guscio che da protettore si fa avviluppante catena e morsa asfissiante. Non sbagliamo, non esageriamo a definire i Rezza/Mastrella geniali, rari, unici: “Stanotte ho pensato a noi due e il fatto che uno dei due fossi io mi ha dato tanta forza”, la tracotanza positiva insita nell'attore, quell'alterigia, quell'arroganza, quella prepotenza, quell'aggressività della quale non vorremmo mai fare a meno.
E arriviamo, alla messinscena di Thomas Ostermeier, “History of Violence”, stratificata, densa, complessa, frastagliata, disarmante. Dalla storia autobiografica dell'autore, il francese Edouard Louis, che racconta la violenza subita, e il trauma conseguente, nella notte di Natale di pochi anni fa. Il libretto parla di stupro ma non è tutto così lineare. La trasposizione scenica del regista della Schaubuhne, come un montaggio cinematografico, ma molto più intenso, è un salto continuo, mai progressivo-temporale mai lineare, dentro le viscere (è questo il caso di dirlo) di questa materia scioccante,  drammatica, vitale, pulsante. Ci lascia tante, tantissime domande, nodi da dover dipanare senza risposte. Un teatro politico, non potrebbe essere altrimenti perché non parla di un corpo abusato ma di un corpo che si fa emblema, materia sociologica, campo di battaglia e di studio. La storia è complessa perché il suo andamento subisce continui scossoni ad ogni scena, ad ogni capoverso e quadro, che controbilanciano, spostano, aggiustano, cancellano, quello che precedentemente avevamo pensato di avere acquisito sulla narrazione, scivolosa, pruriginosa, viscida.
drammatica, vitale, pulsante. Ci lascia tante, tantissime domande, nodi da dover dipanare senza risposte. Un teatro politico, non potrebbe essere altrimenti perché non parla di un corpo abusato ma di un corpo che si fa emblema, materia sociologica, campo di battaglia e di studio. La storia è complessa perché il suo andamento subisce continui scossoni ad ogni scena, ad ogni capoverso e quadro, che controbilanciano, spostano, aggiustano, cancellano, quello che precedentemente avevamo pensato di avere acquisito sulla narrazione, scivolosa, pruriginosa, viscida.
Un batterista in scena che storna colpi che scandiscono le parole e gli stati d'animo, il protagonista che diventa narratore in terza persona, altri due attori che impersonificano tutti gli altri ruoli collaterali: un grande lavoro di ampio respiro. Semplificando potremmo riportare che “History of violence” racconta di uno stupro subito. Non è così. Ovvero, questa è solo la patina, la punta dell'iceberg di tutto quello che c'è sotto, perché la realtà non è mai univoca né così semplicistica. Come se fosse un giallo entrano in scena medici e Polizia che si incastrano con tutto il magma di sensazioni del protagonista che ricorda e rivive quegli attimi, prima, durante e dopo, in presa diretta per raccontarli e metterli a verbale. Com'è difficile raccontare a terzi la verità ed essere creduti? In questo spettacolo (e nel romanzo dal quale è tratto) lo stupro sembra essere il grimaldello per scoperchiare molti punti deboli della nostra casa Europa: emerge la dicotomia campagna rurale versus città, mondo etero vs omosessualità, cittadini vs immigrati, destra e sinistra, tutto miscelato dentro una pentola a  pressione che non può far altro che implodere.
pressione che non può far altro che implodere.
Edouad, alle quattro della mattina della notte di Natale, al ritorno da una cena tra amici, incontra sotto casa Reda, un affascinante giovane nord africano. Il nostro scrittore ne è attratto ma anche impaurito, l'altro è molto insistente. Lo invita a salire da lui, si fida. Si confidano, si aprono, si amano. Fin quando l'algerino, mentre l'altro è a fare la doccia, non gli sottrae il cellulare. A quel punto, scoperto il furto e chiesta la restituzione dell'oggetto, Reda impugna la pistola, tenta di soffocarlo con una sciarpa e lo abusa. Non è una narrazione di uno stupro ma di una contraddizione. Perché l'abusato, pur odiandosi e avendo gli incubi e gli attacchi di panico e ha il desiderio di farla finita, diventa il primo giustificatore dell'aggressore, mostrando pietà e perdono, mettendo sul piatto della bilancia la povertà e la disperazione dello stupratore. Lo va a denunciare ma non vorrebbe che finisse in carcere in una sorta di Sindrome di Stoccolma reiterata. In qualche modo pensa che la violenza che ha subito sia stata giusta come colpa da scontare della nostra cultura, dolore da patire per equilibrare colonialismo e razzismo e sfruttamento. Che cosa però ci vuole raccontare lo scrittore rimane nebuloso e, ovviamente, tormentato: ci vuole forse dire che la Polizia francese sia “fascista”? Lui, l'aggredito da un tale reato così ignobile e odioso, difende l'abusatore dal linguaggio degli uomini in divisa che nel verbale lo definiscono “magrebino”. Ci vuole raccontare che ha ragione il Fronte Nazionale sulla questione degli immigrati e sulle banlieu? Ci vuole dire che gli extracomunitari hanno il diritto di soverchiarci senza che possiamo difenderci perché corrosi dal senso di colpa? Ci vuole dire che chi viene accolto in Europa ci odia e continuerà ad odiarci perché non si riconosce nei nostri valori e li vuole abbattere (o simbolicamente stuprare, “fottere” una cultura; Houellebecq) e ci disprezza per i nostri comportamenti e le nostre possibilità e libertà? L'Europa sarà spazzata via da questo tipo di ragionamento che tende, sempre e comunque, a vederci come aggressori anche quando siamo stati aggrediti.
Tommaso Chimenti 10/07/2022
A Colpi di scena il meglio del Teatro ragazzi in circolazione
FAENZA – L'Accademia non si è affatto Perduta o almeno, certamente se lo è stata si è ampiamente ritrovata. “Colpi di Scena” è un format consolidato nel teatro per le giovani generazioni e da biennale lo scorso anno si è trasformato in annuale alternando la visione di spettacoli per adulti, negli anni dispari (la prossima edizione sarà a settembre '23), a quelli per ragazzi, negli anni pari. E i colpi teatrali dell'AP (in collaborazione con ATER) sono stati ben assestati anche quest'anno, dislocati tra Faenza e Forlì tra i tanti teatri che compongono la costellazione degli spazi romagnoli: il San Luigi e il Testori, Il Piccolo, il Diego Fabbri e il Felix Guattari tutti a Forlì, la Casa del Teatro e il Masini a Faenza. Un solido spargimento teatrale che fa storia e tradizione come comunità e passione. In Romagna non manca mai la voglia di allegria, sorrisi e piadina. In quattro giorni una piccola, faticosa ma soddisfacente, maratona, con diciotto piece e otto debutti, colma di visioni e approdi, di parole e colori. Sale calde, temperature hot.
Un giovane performer che riprende l'antica tradizione, quasi scomparsa, del ventriloquo ne “Il Gran Ventriloquini” della compagnia Madame Rebiné: Max Pederzoli alto, dinoccolato  in giallo, a metà strada tra Adrien Brody e Adam Driver, immerso in una pseudo situazione circense. Si sente che sono freschi, che hanno sensibilità ed entusiasmo. E' la classica, ma sempre affascinante storia, degli oggetti che si ribellano al suo creatore, del figlio che deve “uccidere” il padre per staccarsi dal cordone ombelicale e camminare con le proprie gambe. Il tagliare i fili della marionetta, Pinocchio e Frankenstein. Qui il nostro mago discute e litiga con “Klaus il Clown” che se ne sta dentro una botola e non ne vuol sentire di uscire per esibirsi ed anzi entra in sciopero. Intanto il mago, per riempire l'attesa, mitraglia le sue barzellette: “Perché le renne vivono in Antartide? Perché lì c'è la neve perenne”. Altro personaggio che si ribella a colui che gli presta la voce non riconoscendone l'autorità è il calzino a mano, una sorta di serpente con la lisca. Klaus e Calzino si rifiutano di dire le barzellette del ventriloquo considerandole squallide. A bocca chiusa rappa e scretcha, suona la base di Billie Jean, parla fuori sincrono, parla con l'eco. E' la lotta infinita tra l'uomo e gli oggetti inanimati che però un'anima ce l'hanno eccome. Intanto: “Vorrei una camicia” “La taglia?” “No, la porto via intera”. Questo è un piccolo circo di periferia “che cade a pezzi”, le cose si rompono, le luci si spengono, i pannelli cadono, le tende si staccano. Il concetto del padre-padrone non regge più e gli oggetti di lavoro si sono fatti consapevoli e vogliono ottenere la libertà per finalmente formare un trio di artisti con pari dignità. “Cosa ordina un riccio al bar? Una birra alla spina”.
in giallo, a metà strada tra Adrien Brody e Adam Driver, immerso in una pseudo situazione circense. Si sente che sono freschi, che hanno sensibilità ed entusiasmo. E' la classica, ma sempre affascinante storia, degli oggetti che si ribellano al suo creatore, del figlio che deve “uccidere” il padre per staccarsi dal cordone ombelicale e camminare con le proprie gambe. Il tagliare i fili della marionetta, Pinocchio e Frankenstein. Qui il nostro mago discute e litiga con “Klaus il Clown” che se ne sta dentro una botola e non ne vuol sentire di uscire per esibirsi ed anzi entra in sciopero. Intanto il mago, per riempire l'attesa, mitraglia le sue barzellette: “Perché le renne vivono in Antartide? Perché lì c'è la neve perenne”. Altro personaggio che si ribella a colui che gli presta la voce non riconoscendone l'autorità è il calzino a mano, una sorta di serpente con la lisca. Klaus e Calzino si rifiutano di dire le barzellette del ventriloquo considerandole squallide. A bocca chiusa rappa e scretcha, suona la base di Billie Jean, parla fuori sincrono, parla con l'eco. E' la lotta infinita tra l'uomo e gli oggetti inanimati che però un'anima ce l'hanno eccome. Intanto: “Vorrei una camicia” “La taglia?” “No, la porto via intera”. Questo è un piccolo circo di periferia “che cade a pezzi”, le cose si rompono, le luci si spengono, i pannelli cadono, le tende si staccano. Il concetto del padre-padrone non regge più e gli oggetti di lavoro si sono fatti consapevoli e vogliono ottenere la libertà per finalmente formare un trio di artisti con pari dignità. “Cosa ordina un riccio al bar? Una birra alla spina”.
Dai  colori al buio tetro degli Zaches che sono sempre cupi e neri, certo raffinati, fini tecnicamente e formalmente eleganti ma anche molto foschi e scuri, impaurenti, intimorenti. Stavolta affrontano la fiaba di “Cipì” e fin dalla prima bellissima scena, quella della tempesta, si ha la sensazione di uno spettacolo noir con i fogli che svolazzano addosso al Maestro in maniera aggressiva quasi cani alla catena che attaccano. La musica coinvolgente e avvolgente crea una sensazione di pathos e ansia prima di giungere al nodo della storia, il nostro Cipì, uccellino curioso che vuole andare a scoprire il mondo mentre il Nonno-Maestro non vuole lasciarlo libero perché là fuori, dice, è molto pericoloso. Come quei genitori che fanno crescere i figli sotto una campana di vetro. E questa versione è anche molto cruda con l'arrivo dei cacciatori e della falciatrice. Una favola ambientalista alla quale avrebbe giovato un po' di leggerezza, un pizzico di allegria e una lievità maggiore.
colori al buio tetro degli Zaches che sono sempre cupi e neri, certo raffinati, fini tecnicamente e formalmente eleganti ma anche molto foschi e scuri, impaurenti, intimorenti. Stavolta affrontano la fiaba di “Cipì” e fin dalla prima bellissima scena, quella della tempesta, si ha la sensazione di uno spettacolo noir con i fogli che svolazzano addosso al Maestro in maniera aggressiva quasi cani alla catena che attaccano. La musica coinvolgente e avvolgente crea una sensazione di pathos e ansia prima di giungere al nodo della storia, il nostro Cipì, uccellino curioso che vuole andare a scoprire il mondo mentre il Nonno-Maestro non vuole lasciarlo libero perché là fuori, dice, è molto pericoloso. Come quei genitori che fanno crescere i figli sotto una campana di vetro. E questa versione è anche molto cruda con l'arrivo dei cacciatori e della falciatrice. Una favola ambientalista alla quale avrebbe giovato un po' di leggerezza, un pizzico di allegria e una lievità maggiore.
Abbiamo avuto  riserve, di altro tipo però, anche per quanto riguarda “Ferdinando, il toro” con Danilo Conti impegnato in una storia atavica di pacifismo raccontata attraverso grandi cartonati non così efficaci. Mancava di ritmo e i pannelli e la grande testa di toro come quella da torero, pur nella bellezza dell'oggetto artigianale, non sono riusciti a far decollare la storia che si è appiattita diventando monocorde, senza slancio. Una favola sulla diversità ma dove al suo interno oggi possiamo leggere anche una metafora tra il torero-Putin e il toro-l'Ucraina. Sappiamo chi vince nella realtà ma sappiamo anche chi vince nelle fiabe.
riserve, di altro tipo però, anche per quanto riguarda “Ferdinando, il toro” con Danilo Conti impegnato in una storia atavica di pacifismo raccontata attraverso grandi cartonati non così efficaci. Mancava di ritmo e i pannelli e la grande testa di toro come quella da torero, pur nella bellezza dell'oggetto artigianale, non sono riusciti a far decollare la storia che si è appiattita diventando monocorde, senza slancio. Una favola sulla diversità ma dove al suo interno oggi possiamo leggere anche una metafora tra il torero-Putin e il toro-l'Ucraina. Sappiamo chi vince nella realtà ma sappiamo anche chi vince nelle fiabe.
Dire che “Cide”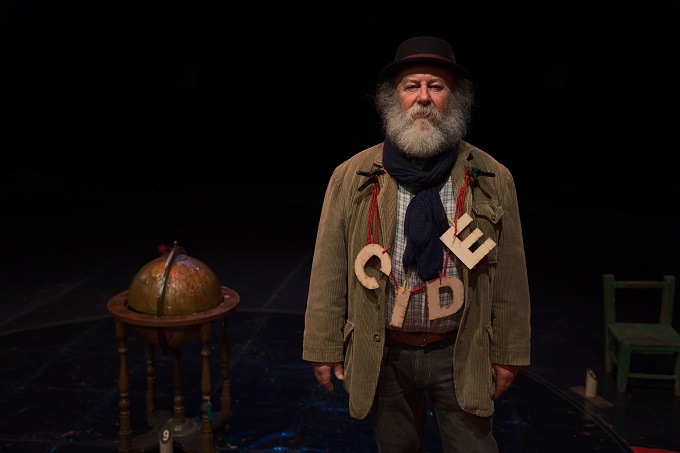 di Maurizio Bercini (prod. Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti), colonna storica del teatro per i ragazzi e dei burattini, sarebbe limitativo. Bercini ha toccato, con semplicità, le corde dell'emozione, della poesia, del pathos, della nostalgia, del ricordo, della commozione. Cide è Alcide Cervi, al quale i fascisti hanno ucciso sette figli. Una roba da uccidere un toro, invece gli oggetti che compongono questo mosaico sulla scena stanno a testimoniare che la verità non si ferma e che la memoria rende gli uomini liberi. Oggetti carichi di significati, doni di chi ha visto in Alcide la costanza e la forza di non abbattersi, di non mollare, di non cedere alle sventure e alle ingiustizie della vita che gli aveva tolto tutto. E Bercini fa sua quella rabbia atavica, è un fuoco, si percepisce che prova ancora quello sdegno e sgomento ogni volta che la rievoca, non si risparmia, è generoso tocca la Bibbia e il Mappamondo, le Bocce e la Falce, unendo i vari punti di questa sorta di cartina sensoriale, di questo quadro che a poco a poco si dipana nel racconto coinvolgendo la platea, andando sempre più a fondo. Un teatro d'oggetti antico e sempre verde, tattile, concreto, materiale, ricco di onestà, un teatro formativo, pedagogico ma mai pedante, per i bambini di ogni età: “Faccio teatro da quando ho diciassette anni, sono passato dai soldatini ai burattini. Non sono mai cresciuto”, dice. Una fortuna. Assolutamente da vedere: applausi di vicinanza e occhi lucidi; la verità non vincerà sempre ma esistono degli eroi pronti a raccontarla.
di Maurizio Bercini (prod. Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti), colonna storica del teatro per i ragazzi e dei burattini, sarebbe limitativo. Bercini ha toccato, con semplicità, le corde dell'emozione, della poesia, del pathos, della nostalgia, del ricordo, della commozione. Cide è Alcide Cervi, al quale i fascisti hanno ucciso sette figli. Una roba da uccidere un toro, invece gli oggetti che compongono questo mosaico sulla scena stanno a testimoniare che la verità non si ferma e che la memoria rende gli uomini liberi. Oggetti carichi di significati, doni di chi ha visto in Alcide la costanza e la forza di non abbattersi, di non mollare, di non cedere alle sventure e alle ingiustizie della vita che gli aveva tolto tutto. E Bercini fa sua quella rabbia atavica, è un fuoco, si percepisce che prova ancora quello sdegno e sgomento ogni volta che la rievoca, non si risparmia, è generoso tocca la Bibbia e il Mappamondo, le Bocce e la Falce, unendo i vari punti di questa sorta di cartina sensoriale, di questo quadro che a poco a poco si dipana nel racconto coinvolgendo la platea, andando sempre più a fondo. Un teatro d'oggetti antico e sempre verde, tattile, concreto, materiale, ricco di onestà, un teatro formativo, pedagogico ma mai pedante, per i bambini di ogni età: “Faccio teatro da quando ho diciassette anni, sono passato dai soldatini ai burattini. Non sono mai cresciuto”, dice. Una fortuna. Assolutamente da vedere: applausi di vicinanza e occhi lucidi; la verità non vincerà sempre ma esistono degli eroi pronti a raccontarla.
Il tema degli hikikomori sembra essere un problema molto sentito tra i giovani. “C'è nessuno” indaga, attraverso l'uso di video e chat, il complesso meccanismo sociale e psicologico che si nasconde dietro i nostri portatili, i nostri smartphone, questa possibilità di poter raggiungere tutti che ci appaga e soddisfa e non ci lascia la curiosità dell'incontro fisico. La compagnia Mandara Ke mette in scena due giovani, uno sul palco e l'altro online a distanza ed è al tempo stesso divertente e tenero, preoccupante e allarmante il rapporto degli adolescenti con le tecnologie da una parte, con gli altri esseri umani dall'altra. Una fase questa acuita dalla pandemia e dalla forzata separazione fisica dei ragazzi che si sono presto abituati a questa dinamica dell'esserci senza esserci in un mondo virtuale fatto di videogiochi e chat tutto irreale, volatile, fumoso. Le chat senza il vis a vis non può che portare ad un game over fatto di sempre più persone isolate, lontane ma con l'intima convinzione di essere felici perché dal divano o dalla cameretta di casa possono, fintamente, raggiungere e fare tutto. Fanno paura le frasi: “Non vorrei crescere” di ventenni senza speranza, preoccupati costantemente del domani, affidandosi ai guru del web, ai tutorial che portano in dono soluzioni (come il Gatto e la Volpe): “Mi avete illuso che sono libero e che posso fare tutto quello che voglio”.
La pulizia dei tratti e la raffinatezza delle scene ben costruite di “Cassandra”, del Teatro Gioco Vita (50 anni di attività, da Piacenza), ci fanno sobbalzare insieme a temi ben architettati ed a  tesi di fondo condivisibili, precise, lucide e puntuali. In una sorta di braciere greco due ancelle performano il loro rituale di ombre da rimanerne esterrefatti. La modalità registica invece di modulare le ombre nel retro del telo e successivamente arrivare sul boccascena a spiegarci, didascalicamente, il quadro appena visto l'abbiamo trovato molto scolastico. Ma il tema è veramente importante: qui Cassandra, che parla ma non viene creduta, è una Greta dei giorni nostri che ci informa e allerta sui pericoli del cambiamento climatico ma ai quali non crediamo per ignoranza, disinformazione ad hoc, paura del futuro e di prendere delle decisioni che in qualche modo possano cambiare, peggiorandola, la nostra piccola esistenza. Abbiamo perso l'età dell'innocenza e il futuro dell'uomo è segnato. Si sentono le sirene di nuovi lockdown, le temperature che aumentano vertiginosamente portando la Terra al collasso, le coltivazioni, le città invivibili, l'emergenza idrica, l'inquinamento, gli incendi. “Cassandra” è uno schiaffo apocalittico con la tropicalizzazione e la saharizzazione del Globo. Lo spettacolo per noi si conclude (troppi finali uno dopo l'altro) con la potente immagine di migranti che nella fuliggine di un deserto camminano verso non si sa quale meta. Da lì in avanti è un cercare di dire le stesse cose precedentemente esposte con altri mezzi rendendo il tutto pesante e inutilmente sottolineante, dalle immagini di cortei e proteste (quando il teatro insegue la tv o il cinema inevitabilmente soccombe). Chi dice la verità è un nemico del Popolo.
tesi di fondo condivisibili, precise, lucide e puntuali. In una sorta di braciere greco due ancelle performano il loro rituale di ombre da rimanerne esterrefatti. La modalità registica invece di modulare le ombre nel retro del telo e successivamente arrivare sul boccascena a spiegarci, didascalicamente, il quadro appena visto l'abbiamo trovato molto scolastico. Ma il tema è veramente importante: qui Cassandra, che parla ma non viene creduta, è una Greta dei giorni nostri che ci informa e allerta sui pericoli del cambiamento climatico ma ai quali non crediamo per ignoranza, disinformazione ad hoc, paura del futuro e di prendere delle decisioni che in qualche modo possano cambiare, peggiorandola, la nostra piccola esistenza. Abbiamo perso l'età dell'innocenza e il futuro dell'uomo è segnato. Si sentono le sirene di nuovi lockdown, le temperature che aumentano vertiginosamente portando la Terra al collasso, le coltivazioni, le città invivibili, l'emergenza idrica, l'inquinamento, gli incendi. “Cassandra” è uno schiaffo apocalittico con la tropicalizzazione e la saharizzazione del Globo. Lo spettacolo per noi si conclude (troppi finali uno dopo l'altro) con la potente immagine di migranti che nella fuliggine di un deserto camminano verso non si sa quale meta. Da lì in avanti è un cercare di dire le stesse cose precedentemente esposte con altri mezzi rendendo il tutto pesante e inutilmente sottolineante, dalle immagini di cortei e proteste (quando il teatro insegue la tv o il cinema inevitabilmente soccombe). Chi dice la verità è un nemico del Popolo.
Dall'incubo al sogno con “I sognatori” (Teatro delle Briciole Solares) che fin da subito ci ricorda e ci riporta alle suggestioni felliniane de “La voce della Luna”. In una sorta di futuro apocalittico, certamente post atomico, un futuro prossimo possibile, si incrociano Gigante e Cico e Pallina (due danzatori), una sgangherata compagnia di giro, cialtrona e vagamente circense. Si vorrebbe far ricorso alla visionarietà come all'immaginazione ma il testo pecca di voler essere filosofeggiante e poetico senza riuscire nell'intento, cadendo in scontatezze e risultando leggermente superficiale. Toccando Fellini è facile cadere nello stereotipo, nella forma più che nella profondità: manca della verità teatrale.
di futuro apocalittico, certamente post atomico, un futuro prossimo possibile, si incrociano Gigante e Cico e Pallina (due danzatori), una sgangherata compagnia di giro, cialtrona e vagamente circense. Si vorrebbe far ricorso alla visionarietà come all'immaginazione ma il testo pecca di voler essere filosofeggiante e poetico senza riuscire nell'intento, cadendo in scontatezze e risultando leggermente superficiale. Toccando Fellini è facile cadere nello stereotipo, nella forma più che nella profondità: manca della verità teatrale.
Conosciamo Michele Di Giacomo da anni avendolo visto, e apprezzato, in molti spettacoli di prosa per adulti. Anche qui tiene la barra dritta, tiene il pubblico, incuriosisce con questa narrazione supportata dai video sul fondale che cambiano ambientazione, un video mapping che cambia forma risultando un vero e proprio coprotagonista con il quale interagire. “Sono solo favole” (Alchemico Tre) inizia kafkiano e prosegue sul filo, mai banale, della ricerca della memoria, di un passato, nell'intreccio tra la realtà e l'immaginazione. Un ragazzo che ha perduto la madre si ritrova nella casa d'infanzia e, attraverso un gioco-caccia al tesoro organizza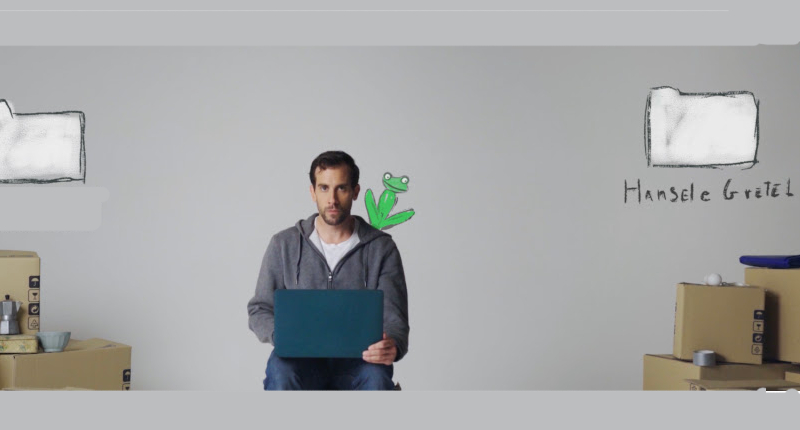 ta proprio dalla genitrice, riesce a risalire a chi è, a scoprire lati importanti del suo carattere, a ritrovare anche se parzialmente la mamma, a capire meglio il suo passato e proiettarsi con più fiducia, ora che ha sconfitto i demoni dell'infanzia, verso il domani. I ricordi fanno paura perché spesso fanno male, non possono essere cambiati. In questa casa virtuale sullo schermo, il ragazzo si fa detective in un giallo a caccia di indizi, una sorta di Alice dentro un mondo parallelo che sono le storie della madre scrittrice (tra la Rowling e Agatha Christie) i cui personaggi si materializzano sullo schermo. La mamma sognatrice e il figlio concreto che alla fine imparerà che le favole, la letteratura, l'arte in generale possono cambiare e migliorare la realtà: “Le fiabe non raccontano che esistono i draghi ma che possono essere sconfitti”. Interessante anche la parte interattiva con il pubblico.
ta proprio dalla genitrice, riesce a risalire a chi è, a scoprire lati importanti del suo carattere, a ritrovare anche se parzialmente la mamma, a capire meglio il suo passato e proiettarsi con più fiducia, ora che ha sconfitto i demoni dell'infanzia, verso il domani. I ricordi fanno paura perché spesso fanno male, non possono essere cambiati. In questa casa virtuale sullo schermo, il ragazzo si fa detective in un giallo a caccia di indizi, una sorta di Alice dentro un mondo parallelo che sono le storie della madre scrittrice (tra la Rowling e Agatha Christie) i cui personaggi si materializzano sullo schermo. La mamma sognatrice e il figlio concreto che alla fine imparerà che le favole, la letteratura, l'arte in generale possono cambiare e migliorare la realtà: “Le fiabe non raccontano che esistono i draghi ma che possono essere sconfitti”. Interessante anche la parte interattiva con il pubblico.
E finiamo con  il miglior spettacolo visto in questa edizione di “Colpi di scena”: “Il messaggero delle stelle”, scritto mirabilmente da Francesco Niccolini, con il funambolico Flavio Albanese sul palco abbigliato tra cavaliere errante e astronauta. E' Astolfo paladino dalla pronuncia inglesizzata che, con il suo ippogrifo, ha raggiunto la Luna per recuperare il senno di Orlando. Ma è qui che esplode tutta l'arte di Albanese, vero mattatore, che ci delizia ed esalta la scrittura di Niccolini, tutta in rima, quando Astolfo incontra filosofi e scienziati in questo limbo nell'Aldilà: Galileo con cadenza toscana, Giordano Bruno napoletano, e poi Tolomeo e Copernico lanciandosi in dialoghi surreali e patafisici sulla conoscenza, l'Universo, l'esistenza, Dio, i corpi celesti. Albanese, davvero un grande attore, riesce a rendere l'astronomia leggibile e semplice, esaltando l'ironia felice e profonda di Niccolini (suoi cavalli di battaglia sia i Paladini che Galileo). Da veri, sentiti, pieni applausi.
il miglior spettacolo visto in questa edizione di “Colpi di scena”: “Il messaggero delle stelle”, scritto mirabilmente da Francesco Niccolini, con il funambolico Flavio Albanese sul palco abbigliato tra cavaliere errante e astronauta. E' Astolfo paladino dalla pronuncia inglesizzata che, con il suo ippogrifo, ha raggiunto la Luna per recuperare il senno di Orlando. Ma è qui che esplode tutta l'arte di Albanese, vero mattatore, che ci delizia ed esalta la scrittura di Niccolini, tutta in rima, quando Astolfo incontra filosofi e scienziati in questo limbo nell'Aldilà: Galileo con cadenza toscana, Giordano Bruno napoletano, e poi Tolomeo e Copernico lanciandosi in dialoghi surreali e patafisici sulla conoscenza, l'Universo, l'esistenza, Dio, i corpi celesti. Albanese, davvero un grande attore, riesce a rendere l'astronomia leggibile e semplice, esaltando l'ironia felice e profonda di Niccolini (suoi cavalli di battaglia sia i Paladini che Galileo). Da veri, sentiti, pieni applausi.
Tommaso Chimenti 07/07/2022
Colpi di Scena si tinge di olandese: Orange is the new theatre
FORLI' – Senza voler essere necessariamente esterofili, le due proposte provenienti dall'Olanda, all'interno del fitto e corposo cartellone della rassegna “Colpi di Scena” (organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater Fondazione), festival di teatro per ragazzi e giovani tra Forlì e Faenza, sono state le più incisive, sicuramente le più moderne e contemporanee, con linguaggi aperti a riflessioni stratificate, interessantissime suggestioni piene di senso e contenuti adatti ad ogni età e non chiusi nella scatola-definizione-dicitura-didascalia “teatro ragazzi” che alle nostre latitudini limita la visuale e semplifica l'immaginazione.
Per primi ci siamo trovati davanti ad “Hermit” (significa “Eremita”) del gruppo Simone De Jong Company, mezz'ora di purezza, trenta minuti da vivere, respirare, capire, assaporare. Tutto si svolge dentro, a fianco, attorno ad un cubo. Facile il primo aggancio semiotico e sentimentale al Cubo di Rubik o, al limite, ai bozzoli di Cocoon; infatti siamo davanti ad un rompicapo, ad un bivio esistenziale, ad un passaggio in perenne contraddizione tra la voglia di stare e quella di scappare, tra il desiderio di abitarlo e quello di cercare la libertà trovandosi di volta in volta insoddisfatti e delusi da una  delle due condizioni. Dentro il cubo-bara una lucina ne illumina le pareti e subito ci appaiono i classici segni semicircolari di una ecografia: nasciamo da un luogo claustrofobico ma caldo, costrittivo ma comodo e, durante l'esistenza, ci muoviamo come trottole per ricercare e ritrovare quella sensazione di pace e di benessere. Sembra un lavoro scritto durante la pandemia, o almeno sembra calato in questi nostri tempi dove più che l'andare fisico sembra che ci basti viaggiare sepolti e impigriti dai nostri divani, sprofondati nei letti o nelle poltrone delle scrivanie con l'illusoria convinzione, malsana e ipocrita, che ci vendono i nostri smartphone facendoci credere che tutto sia a portata di click quando sullo schermo la realtà che vediamo è soltanto bidimensionale mancando la profondità, mancando appunto noi dentro quel panorama. Il nostro protagonista (sembra un astronauta nella sua navicella, sembra un giapponese nel suo loculo) se ne sta rannicchiato dentro, compresso, è come impaurito; ai tanti campanelli che installa all'esterno delle pareti protettive del suo guscio, sonagli che evidentemente dovrebbero logicamente servire per essere trovato, risponde perennemente con “Non sono in casa” non volendo entrare in nessuna relazione con gli altri, affetto da una forma di patologica misantropia accelerata all'ennesima potenza. Quando la sua voglia di uscire si fa esondante e finalmente riesce a prendere coraggio per esplorare gli intorni del suo spazio e prendere consapevolezza del proprio corpo al di là dei confini imposti dalla sua pelle, esce dall'oblò e comincia una furiosa e forsennata corsa felice e liberatoria e di risate a bocca piena, gambe in spalle che sanno di gioia e soprattutto libertà. Ma, come
delle due condizioni. Dentro il cubo-bara una lucina ne illumina le pareti e subito ci appaiono i classici segni semicircolari di una ecografia: nasciamo da un luogo claustrofobico ma caldo, costrittivo ma comodo e, durante l'esistenza, ci muoviamo come trottole per ricercare e ritrovare quella sensazione di pace e di benessere. Sembra un lavoro scritto durante la pandemia, o almeno sembra calato in questi nostri tempi dove più che l'andare fisico sembra che ci basti viaggiare sepolti e impigriti dai nostri divani, sprofondati nei letti o nelle poltrone delle scrivanie con l'illusoria convinzione, malsana e ipocrita, che ci vendono i nostri smartphone facendoci credere che tutto sia a portata di click quando sullo schermo la realtà che vediamo è soltanto bidimensionale mancando la profondità, mancando appunto noi dentro quel panorama. Il nostro protagonista (sembra un astronauta nella sua navicella, sembra un giapponese nel suo loculo) se ne sta rannicchiato dentro, compresso, è come impaurito; ai tanti campanelli che installa all'esterno delle pareti protettive del suo guscio, sonagli che evidentemente dovrebbero logicamente servire per essere trovato, risponde perennemente con “Non sono in casa” non volendo entrare in nessuna relazione con gli altri, affetto da una forma di patologica misantropia accelerata all'ennesima potenza. Quando la sua voglia di uscire si fa esondante e finalmente riesce a prendere coraggio per esplorare gli intorni del suo spazio e prendere consapevolezza del proprio corpo al di là dei confini imposti dalla sua pelle, esce dall'oblò e comincia una furiosa e forsennata corsa felice e liberatoria e di risate a bocca piena, gambe in spalle che sanno di gioia e soprattutto libertà. Ma, come  si dice, se non puoi uscire dal tuo tunnel allora arredalo. Una volta resosi conto della presenza di tanti sconosciuti, di molti occhi a fissarlo, la paura e il timore del contatto (forse del contagio) lo assale ferocemente facendolo ritirare dentro la sua sicurezza e fortezza. Con il lockdown è cambiata radicalmente l'idea di casa; adesso l'abitazione è una propaggine di sé, come la chitarra per Jimi Hendrix, ci deve assomigliare perché lì dentro ci passiamo, ci passeremo molto tempo. E la riflessione prende una piega drammatica: se possiamo stare tranquillamente in casa e lì lavorare non abbiamo più bisogno di uscire per raggiungere il posto di lavoro, non ho più bisogno del cinema perché ho Netflix e Prime Amazon, non ho bisogno di andare a fare la spesa perché me la porta direttamente un deliveroo, non ho più bisogno di relazioni perché parlo con Alexa, posso chattare con sconosciuti e tutto risulta essere anche più asettico e pulito. Quando non vado d'accordo con qualcuno posso bannarlo o bloccarlo e cancellarlo così che il problema viene estirpato alla radice. La paura dell'altro ci fa rinchiudere nel nostro guscio di chiocciola, come un paguro nella conchiglia, come una tartaruga all'interno del carapace. Questo chiudersi al mondo, illudendosi di lasciare fuori di casa i problemi, crea nuovi hikikomori: il futuro è grigio, bisogna per questo aprire le finestre per cambiare l'aria e respirare a pieni polmoni. Gli altri non sono un problema, il problema siamo noi stessi.
si dice, se non puoi uscire dal tuo tunnel allora arredalo. Una volta resosi conto della presenza di tanti sconosciuti, di molti occhi a fissarlo, la paura e il timore del contatto (forse del contagio) lo assale ferocemente facendolo ritirare dentro la sua sicurezza e fortezza. Con il lockdown è cambiata radicalmente l'idea di casa; adesso l'abitazione è una propaggine di sé, come la chitarra per Jimi Hendrix, ci deve assomigliare perché lì dentro ci passiamo, ci passeremo molto tempo. E la riflessione prende una piega drammatica: se possiamo stare tranquillamente in casa e lì lavorare non abbiamo più bisogno di uscire per raggiungere il posto di lavoro, non ho più bisogno del cinema perché ho Netflix e Prime Amazon, non ho bisogno di andare a fare la spesa perché me la porta direttamente un deliveroo, non ho più bisogno di relazioni perché parlo con Alexa, posso chattare con sconosciuti e tutto risulta essere anche più asettico e pulito. Quando non vado d'accordo con qualcuno posso bannarlo o bloccarlo e cancellarlo così che il problema viene estirpato alla radice. La paura dell'altro ci fa rinchiudere nel nostro guscio di chiocciola, come un paguro nella conchiglia, come una tartaruga all'interno del carapace. Questo chiudersi al mondo, illudendosi di lasciare fuori di casa i problemi, crea nuovi hikikomori: il futuro è grigio, bisogna per questo aprire le finestre per cambiare l'aria e respirare a pieni polmoni. Gli altri non sono un problema, il problema siamo noi stessi.
Anche il secondo “Kleur+” (significa “Colore”) della compagnia Dadodans è una performance senza preclusioni, per tutti i tipi di pubblico.  Un gioco di una performer (concept e coreografia di Gaia Gonnelli) immersa in una scena dove la fanno da padroni visivamente palle argentate di varie dimensioni. E qui scattano due illuminazioni, due direzioni che sembrano opposte anche se entrambe hanno a che vedere con la creazione, con la nascita. La prima è che l'attrice potrebbe essere la metafora di Dio, o per esso la Natura, che gioca a dadi con gli uomini in questo sistema solare che sposta a piacimento, muove, fa rotolare galileianamente. Facendo tintinnare e barcollare le sfere qualcuna si apre e si rompe facendo fuoriuscire della polvere rossa, allegoria della saharizzazione del mondo come del tanto sangue versato dall'uomo, sua creatura principale fatto a sua immagine e somiglianza, come se giocasse con il sangue, calpestandolo, e con le continue guerre degli uomini stolti. Quelle strisce rossastre ricordano il sangue rimasto nell'arena, nella Plaza de Toros dopo che il bovino imbufalito è stato trascinato, ormai morto, fuori dalla corrida con il carro dei cavalli. Il rosso che imbratta la scena, che alla fine sarà di pollockiana memoria (ma potremmo andare anche a Kandinsky o Rothko) apre alla seconda immagine forte esplicita che balena quando la grossa goccia, che è appesa come un gigantesco punchingball pugilistico a mezz'aria, anch'essa si apre e lascia colare (come la rottura delle acque) liquido di vernici impastanti appiccicose. Potremmo essere all'interno di un utero e la maxigoccia essere l'ovulo: certamente un'immagine potente. Due proposte che ci fanno capire in quale direzione stia andando non soltanto il teatro ma anche il teatro ragazzi nel mondo dove non esistono distinzioni e non esistono categorie, perché fondamentalmente ci sono solamente due tipi di teatro: quello fatto bene e quello fatto male. L'arancione rimane un bel colore.
Un gioco di una performer (concept e coreografia di Gaia Gonnelli) immersa in una scena dove la fanno da padroni visivamente palle argentate di varie dimensioni. E qui scattano due illuminazioni, due direzioni che sembrano opposte anche se entrambe hanno a che vedere con la creazione, con la nascita. La prima è che l'attrice potrebbe essere la metafora di Dio, o per esso la Natura, che gioca a dadi con gli uomini in questo sistema solare che sposta a piacimento, muove, fa rotolare galileianamente. Facendo tintinnare e barcollare le sfere qualcuna si apre e si rompe facendo fuoriuscire della polvere rossa, allegoria della saharizzazione del mondo come del tanto sangue versato dall'uomo, sua creatura principale fatto a sua immagine e somiglianza, come se giocasse con il sangue, calpestandolo, e con le continue guerre degli uomini stolti. Quelle strisce rossastre ricordano il sangue rimasto nell'arena, nella Plaza de Toros dopo che il bovino imbufalito è stato trascinato, ormai morto, fuori dalla corrida con il carro dei cavalli. Il rosso che imbratta la scena, che alla fine sarà di pollockiana memoria (ma potremmo andare anche a Kandinsky o Rothko) apre alla seconda immagine forte esplicita che balena quando la grossa goccia, che è appesa come un gigantesco punchingball pugilistico a mezz'aria, anch'essa si apre e lascia colare (come la rottura delle acque) liquido di vernici impastanti appiccicose. Potremmo essere all'interno di un utero e la maxigoccia essere l'ovulo: certamente un'immagine potente. Due proposte che ci fanno capire in quale direzione stia andando non soltanto il teatro ma anche il teatro ragazzi nel mondo dove non esistono distinzioni e non esistono categorie, perché fondamentalmente ci sono solamente due tipi di teatro: quello fatto bene e quello fatto male. L'arancione rimane un bel colore.
Tommaso Chimenti 02/07/2022
Narni Città Teatro: il teatro è ovunque
NARNI – Spoleto, Todi, Narni. In Umbria, teatralmente parlando, accadono le cose, il panorama si muove. Davide Sacco, codirettore del festival Narni Città Teatro assieme a Francesco Montanari, ha portato il teatro in ogni angolo, piazza, sala, in un teatro da restaurare e ripristinare, come in chiostri e giardini, scorci di valle e maneggi di cavalli, al castello come un su tavolo, negli anfratti di mura scorticate e divelte come su un tessuto aereo, nei porticati, orti, spiazzi, terrazze. Dovunque ci sia un luogo per mettersi in cerchio e vedere e ascoltare qualcuno posto al centro, allora lì c'è teatro, lì si può fare teatro. Perché il teatro è un sentire, è un luogo dell'anima e mai un luogo fisico. Una città-teatro all'aperto: abbiamo trovato una cittadina viva, fervente, spumeggiante, pronta alla contaminazione, elettrica, frizzante, ricettiva e allestita per accogliere i diversi e nuovi linguaggi della scena, dalla prosa ai kids, dal circo all'affabulazione, dalla musica al parkour, dal comico al grottesco, dalle prove aperte in norvegese fino alle performance sonore o quelle all'alba o dopo la mezzanotte. Un grande lavoro progettuale e organizzativo. Non ci si annoia: si entra e si esce dagli spazi non convenzionali, si incontrano Filippo Nigro come Sabina Guzzanti e mille altri volti noti del nostro teatro. C'è carica e tensione positiva, nell'aria frigge qualcosa come lo zucchero filato che continua nel suo vorticare con il lungo bastoncino nella magia alchemica della trasformazione dai granelli ruvidi a quella nuvola-batuffolo che è un salto carpiato nell'infanzia, nei Luna Park dei nostri  ricordi sbiaditi. Dei tanti appuntamenti proposti (trentadue per sessanta repliche complessive in tre giorni significa un illuminato vortice, un folgorante tourbillon di bellezza) ne abbiamo scelti sei, quelli che, per un verso o per l'altro, ci hanno maggiormente toccato, sollecitato, solleticato, ispirato, spostato.
ricordi sbiaditi. Dei tanti appuntamenti proposti (trentadue per sessanta repliche complessive in tre giorni significa un illuminato vortice, un folgorante tourbillon di bellezza) ne abbiamo scelti sei, quelli che, per un verso o per l'altro, ci hanno maggiormente toccato, sollecitato, solleticato, ispirato, spostato.
Ci ha commosso per la sua estrema semplicità, e insieme immaginificità, il ceco “Prefab” per la regia di Dominik Migac: il pubblico, otto persone al massimo, attorno ad una scrivania dove un performer con una maschera, lignea e squadrata, movimenta piccoli oggetti seguendo il filo narrativo dei rumori di fondo che si spandono in audio. Nessuna parola, pochissime azioni, il film è tutto personale. Pochi elementi per stuzzicare la fantasia e farsi dentro ognuno la propria storia. Ci ha ricordato il lavoro dello spagnolo David Espinosa “Una storia universale” oppure l'altro suo piccolo capolavoro “Mi gran Obra”, visto alla Biennale di Venezia. Oppure quello di un altro spagnolo Xavier Bobés con “Cosas que se olvidan facilmente”, al quale assistemmo qualche anno fa al Kilowatt Festival. O ancora l'inarrivabile “Finale di Partita” del Teatrino Giullare. Teatro da tavolino che esplode di senso con piccoli movimenti delle mani che corrono dietro ai segni del sonoro. L'abatjour sopra il tavolo ci appare come la Luna che illumina questo piccolo cubo che diventa casa, questi parallelepipedi (la suggestione ci ha portato ai quadri di De Chirico ma soprattutto alla Chiesa di San Paolo Apostolo progettata da Fuksas a Foligno) che si stravolgono in palazzi. Ecco i passi e rumori del traffico, un abbaiare di un cane, un aprire di porte, l'ascensore che si spalanca con il suo classico cigolio da pellicola horror. Un linguaggio onomatopeico gutturale universale. Non c'è niente, o perlomeno accade realmente poco, tutto prende forma nelle retine  e nelle menti di chi guarda, osserva, ascolta. Il cane che fa la pipì, i vicini che litigano, gli elicotteri, la città che dorme e poi si risveglia in una normalità di cemento con i blocchi che, come in un tetris, si girano e ribaltano componendosi in una creazione articolata con mini diapositive che fanno la loro apparizione alle hitchcockiane finestre di fronte. Nella miniaturizzazione delle abitazioni capiamo la nostra infinitesimale piccolezza e irrilevanza, la periferia e ininfluenza dei nostri ego. Un piccolo gioiello per una mezz'ora miracolosa.
e nelle menti di chi guarda, osserva, ascolta. Il cane che fa la pipì, i vicini che litigano, gli elicotteri, la città che dorme e poi si risveglia in una normalità di cemento con i blocchi che, come in un tetris, si girano e ribaltano componendosi in una creazione articolata con mini diapositive che fanno la loro apparizione alle hitchcockiane finestre di fronte. Nella miniaturizzazione delle abitazioni capiamo la nostra infinitesimale piccolezza e irrilevanza, la periferia e ininfluenza dei nostri ego. Un piccolo gioiello per una mezz'ora miracolosa.
Due le performance che vogliamo mettere insieme per ragioni opposte, “Il Terzo Reich” (prod. Societas) di Romeo Castellucci e “Nella solitudine dei campi di cotone” (prod. CSS) a cura di Mario Martone e qui riproposta da Fabrizio Arcuri. Se nella prima venivamo aggrediti da suoni dirompenti (all'entrata consegnano tappi per le orecchie) e disturbanti associati a parole illuminate sparate a getto continuo (una ogni ventesimo di secondo), per decine di minuti interminabili, ad infastidire l'attenzione e colpire il bulbo oculare in un continuo bombardamento di parole frullate e gettate sul grande schermo con luci stroboscopiche (che regalano nausea) senza  aver trovato alcun nesso con il titolo dell'opera in un susseguirsi monocorde, senza nessun scarto né evoluzione né cambio di direzione, fortunatamente nel secondo è stata potente la nebbia che ha avvolto i pochi spettatori a rappresentazione, con cuffie, immersi dentro un antico teatro da ristrutturare in uno scenario apocalittico beckettiano (ricordava le immagini del teatro ucraino distrutto dagli aggressori sovietici a Mariupol) dove camminare liberamente tra le stanze, perdersi dentro la polvere e le parole pungenti di Koltes nelle orecchie. Un viaggio interiore fatto di sbiadimenti e sbandamenti, di
aver trovato alcun nesso con il titolo dell'opera in un susseguirsi monocorde, senza nessun scarto né evoluzione né cambio di direzione, fortunatamente nel secondo è stata potente la nebbia che ha avvolto i pochi spettatori a rappresentazione, con cuffie, immersi dentro un antico teatro da ristrutturare in uno scenario apocalittico beckettiano (ricordava le immagini del teatro ucraino distrutto dagli aggressori sovietici a Mariupol) dove camminare liberamente tra le stanze, perdersi dentro la polvere e le parole pungenti di Koltes nelle orecchie. Un viaggio interiore fatto di sbiadimenti e sbandamenti, di  visioni distorte, annacquate e appannate, confuse e contemplative, mistiche e allucinate tra i fumi metaforici della memoria, dell'inganno, del mistero, del desiderio rarefatto, della paura dell'ignoto, dell'incubo.
visioni distorte, annacquate e appannate, confuse e contemplative, mistiche e allucinate tra i fumi metaforici della memoria, dell'inganno, del mistero, del desiderio rarefatto, della paura dell'ignoto, dell'incubo.
Abbiamo scoperto Francesco Brandi con la sua storia sul liminare tra sorriso e tragedia, “La fine della Grecia”, passando dal purtroppo recente lockdown alla fine di un amore, soffermandosi sui condomini, tratteggiando, con leggerezza e sensibilità, con grazia e cura, la figura dell'eterno sfigato, il Calimero, il Paperino, il perdente che si deve accontentare di veder sempre vincere gli altri, senza nessuna concessione, senza soddisfazione, represso da anni di ombre, a sopportare dolori e frustrazioni. Commovente il rapporto con il padre, contemporaneo l'inserto del virologo così come il precariato e disperato il licenziamento. Gli vuoi bene al personaggio (e a Brandi), lo vedi un po' come una pentola a pressione che incamera fin quando non esplode di rabbia e ribellione come il tipo di “Un giorno di ordinaria follia”. Certo arriva il lieto fine ma senza sciupare quell'atmosfera calda, opaca, trasognante, riflessiva, senza pedanteria. Non bisogna aver paura di osare, di buttarsi, non bisogna temere di fare la fine della Grecia. Si lascia ascoltare, si lascia volentieri applaudire.
Metti la sera su un prato di un chiostro, metti un grande attore che nemmeno per un minuto sembra che stia recitando, metti la sua naturalezza, semplicità, gentilezza, leggerezza anche nei passaggi più drammatici, metti un teatro partecipativo e interattivo, pieno e coinvolgente ed avrete “Every brilliant thing”. Il testo di Duncan MacMillian, per la regia di Fabrizio Arcuri e l'interpretazione di un gigantesco Filippo Nigro (prod. CSS, Sardegna Teatro) fa letteralmente partecipare tutto il pubblico; infatti ad ogni spettatore viene dato all'ingresso un foglietto con un numero e una frase scritta sopra: sono le varie liste che il protagonista (un bambino che diventa prima un ragazzo e poi un uomo) stila per far comprendere alla madre, depressa cronica, quali e quante sono le cose per le quali valga la pena vivere. La drammaturgia ci ha ricordato “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” di Mark Haddon come “Molto forte, incredibilmente vicino” di Jonathan Safran Foer ma anche le infinite liste presenti in “Alta fedeltà” di Nick Hornby. C'è grande lievità e grazia nei movimenti e nelle parole di Nigro (meraviglioso interprete) che dialoga con la platea che tiene con dolcezza, la accompagna senza formalismi, è affabile, sorride insieme a noi, si intristisce insieme a noi. La storia sembra talmente sua che a tratti potresti chiederti, tanto è credibile e convincente, se possa essere la sua autobiografia. Non 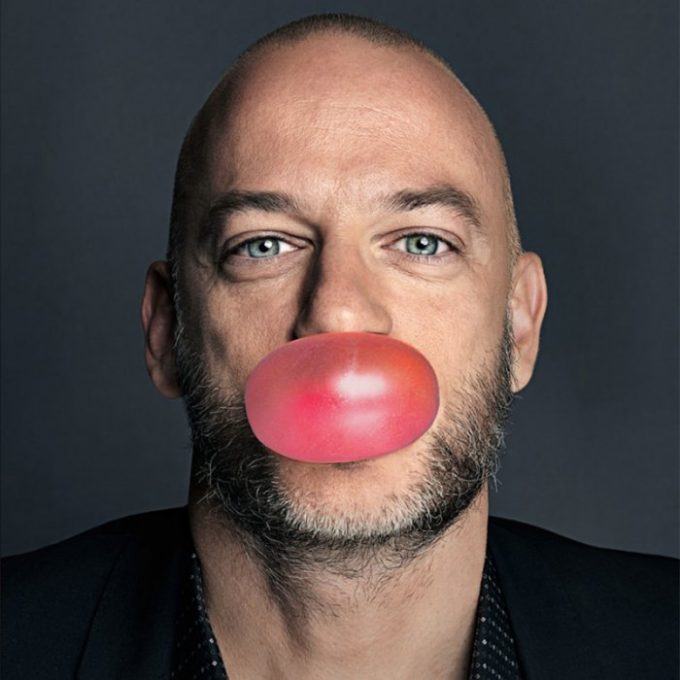 recita ma racconta, ci prende per mano, ci apre la porta sui mondi che riesce a creare con una parola, un passo, una mano tesa, una sospensione carica di pathos. Come un professore che deve interrogare enuncia casualmente i vari numeri delle liste e il proprietario del foglietto di riferimento lo legge ad alta voce, è un incontro, una chiacchierata e un colloquio continuo: si crea un doppio filo che non si spezza, una fiducia reciproca che si rafforza. La storia del ragazzo è straziante: con il padre comunica soltanto attraverso dischi jazz, con la madre soltanto con le liste senza ricevere nessuna risposta, nessun conforto, né confronto, da entrambi. Quando mancano le attenzioni, quando manca il dialogo e l'amore, spesso non riesci a tua volta a donarlo, a passarlo alle persone care che arriveranno nella tua vita. E così anche l'amore per la fidanzata, poi diventata moglie, svanisce, si esaurisce, evapora. EBT lascia un sapore dolce in bocca, una delizia seppur impastata di lacrime perché “la felicità mi ha sempre fatto paura” e nel rischio di essere contenti e soddisfatti, impauriti e timorosi, ci rivediamo tutti, nei nostri piccoli grandi fallimenti, sconfitte, perdite, parole non dette, carezze non date o mai ricevute, nell'impotenza cinica e turgida, nell'assenza di supporto che fa male, nel bisogno di aiuto senza aver la forza di chiederlo. Le liste non salvano ma aiutano a delineare gli obbiettivi, a capire chi siamo, a focalizzare cosa è, o dovrebbe essere, per noi la felicità. La vita non ci salva ma va vissuta fino in fondo.
recita ma racconta, ci prende per mano, ci apre la porta sui mondi che riesce a creare con una parola, un passo, una mano tesa, una sospensione carica di pathos. Come un professore che deve interrogare enuncia casualmente i vari numeri delle liste e il proprietario del foglietto di riferimento lo legge ad alta voce, è un incontro, una chiacchierata e un colloquio continuo: si crea un doppio filo che non si spezza, una fiducia reciproca che si rafforza. La storia del ragazzo è straziante: con il padre comunica soltanto attraverso dischi jazz, con la madre soltanto con le liste senza ricevere nessuna risposta, nessun conforto, né confronto, da entrambi. Quando mancano le attenzioni, quando manca il dialogo e l'amore, spesso non riesci a tua volta a donarlo, a passarlo alle persone care che arriveranno nella tua vita. E così anche l'amore per la fidanzata, poi diventata moglie, svanisce, si esaurisce, evapora. EBT lascia un sapore dolce in bocca, una delizia seppur impastata di lacrime perché “la felicità mi ha sempre fatto paura” e nel rischio di essere contenti e soddisfatti, impauriti e timorosi, ci rivediamo tutti, nei nostri piccoli grandi fallimenti, sconfitte, perdite, parole non dette, carezze non date o mai ricevute, nell'impotenza cinica e turgida, nell'assenza di supporto che fa male, nel bisogno di aiuto senza aver la forza di chiederlo. Le liste non salvano ma aiutano a delineare gli obbiettivi, a capire chi siamo, a focalizzare cosa è, o dovrebbe essere, per noi la felicità. La vita non ci salva ma va vissuta fino in fondo.
Il festival si chiude con il controverso “Uno spettacolo di fantascienza” di Liv Ferracchiati (prod. Marche Teatro, CSS, Metastasio), a nostro avviso il suo spettacolo più composito e “teatrale” e maturo pur sempre inflazionato da quella spessa autoreferenzialità che punteggia i suoi lavori e da quell'insaziabile voglia di portare sul palco, ogni volta, questioni legate alla propria autobiografia. Certo può essere una cifra stilistica ma così l'arte rischia di  essere limitativa e restrittiva e non universale, non pone domande ma esprime soltanto proprie posizioni su un unico preciso quesito personale. “Uno spettacolo di fantascienza” parte come un rarefatto dramma di Jon Fosse (sarà la neve, saranno i blocchi di ghiaccio) e pian piano si fa latelliano come scelte, pupazzi, microfoni, luci, fino a sfiorare il paravidinico, in un continuo teatro nel teatro e un perenne dentro e fuori dal testo, dialogando con la platea come fosse un convegno sul tema preferito. Non si può dire però che, per lunghi tratti, non sia piacevole e alcune riflessioni non colgano il bersaglio dell'emotività. Ferracchiati che non è un attore non poteva però non esserci visto che ogni sillaba è assolutamente grondante del desiderio di parlare delle proprie istanze, invece Petra Valentini ha piglio e sicurezza e carisma, e Andrea Cosentino, bergonzoniano, ne esce bene e, dopo un primo approccio stentato al palco, carbura quando il testo si fa più comodo per le sue corde. Due storie che si intrecciano, come si intreccia la finzione dei personaggi con la vita reale non dei caratteri bensì degli attori stessi in una miscela che spiazza felicemente fin quando la trovata della prova aperta si reitera oltremodo. Il tricheco ci ha portato alla mente a “Un eschimese in Amazzonia”, vecchio titolo dello stesso autore. Anche l'affrontare la fine del mondo si riduce in definitiva alla fine di un solo personaggio, ad un solo esondante Io rimanendo noi esclusi, nell'impossibilità empatica di essere compresi come individui e non strumentalizzati da un compiacimento che tracima. Il fulcro di fondo rimane sempre l'indagine sull'identità che tutto accentra e tritura come unico grande tema della sua produzione: qui si parla forsennatamente dell'identità dicendo però al pubblico, in loop, che questo non è uno spettacolo sull'identità. Un teatro che può risultare “freddo”: una specie di Alaska.
essere limitativa e restrittiva e non universale, non pone domande ma esprime soltanto proprie posizioni su un unico preciso quesito personale. “Uno spettacolo di fantascienza” parte come un rarefatto dramma di Jon Fosse (sarà la neve, saranno i blocchi di ghiaccio) e pian piano si fa latelliano come scelte, pupazzi, microfoni, luci, fino a sfiorare il paravidinico, in un continuo teatro nel teatro e un perenne dentro e fuori dal testo, dialogando con la platea come fosse un convegno sul tema preferito. Non si può dire però che, per lunghi tratti, non sia piacevole e alcune riflessioni non colgano il bersaglio dell'emotività. Ferracchiati che non è un attore non poteva però non esserci visto che ogni sillaba è assolutamente grondante del desiderio di parlare delle proprie istanze, invece Petra Valentini ha piglio e sicurezza e carisma, e Andrea Cosentino, bergonzoniano, ne esce bene e, dopo un primo approccio stentato al palco, carbura quando il testo si fa più comodo per le sue corde. Due storie che si intrecciano, come si intreccia la finzione dei personaggi con la vita reale non dei caratteri bensì degli attori stessi in una miscela che spiazza felicemente fin quando la trovata della prova aperta si reitera oltremodo. Il tricheco ci ha portato alla mente a “Un eschimese in Amazzonia”, vecchio titolo dello stesso autore. Anche l'affrontare la fine del mondo si riduce in definitiva alla fine di un solo personaggio, ad un solo esondante Io rimanendo noi esclusi, nell'impossibilità empatica di essere compresi come individui e non strumentalizzati da un compiacimento che tracima. Il fulcro di fondo rimane sempre l'indagine sull'identità che tutto accentra e tritura come unico grande tema della sua produzione: qui si parla forsennatamente dell'identità dicendo però al pubblico, in loop, che questo non è uno spettacolo sull'identità. Un teatro che può risultare “freddo”: una specie di Alaska.
Tommaso Chimenti 20/06/2022
Camminare con i Cuocolo/Bosetti: un viaggio interiore
PARMA – Il cammino e il teatro sembrano luoghi così distanti, o almeno ce li hanno raccontati mettendoli in categorie lontane: a teatro si sta fermi e a sedere nel buio, si cammina invece nelle luce, muovendosi e, forse, anche interagendo con gli altri e con la natura circostante. Ma alcune esperienze invece ci raccontano che è possibile unire le due fasi in un errare teatrale o in un teatro podistico. Ecco che in questo paniere mettiamo certamente il “Walking Therapie” del Teatro di Rifredi, a Firenze, il “Walking in Fabula” tra Piacenza e Lodi, le “Passeggiate” dei Chille de la Balanza a San Salvi, sempre a Firenze, le “Camminate meditative” a cura del Teatro Nonviolento Theandric, l'“Immergersi nel Paesaggio” di Michele Pascarella, oppure le tante  pièce che ogni anno si sviluppano e prendono vita nei boschi di Campsirago all'interno del festival “Il Giardino delle Esperidi” in Brianza. Il cammino è scoperta, curiosità, cercare, vedere, osservare, entrare in nuovi mondi, avere occhi nuovi. Proprio come il teatro. O il racconto, la parola, quel suono pieno di senso che riempie la natura circostante in una continua altalena tra il metaforico e il fisico, tra l'immaginario e il reale per un viaggio da fare con i piedi fuori nel mondo e uno tutto interiore e personale da realizzare attraverso l'ascolto. Due binari, due viaggi, interno ed esterno che non si annullano ma anzi si elevano, si assommano, si esaltano, si moltiplicano, si autoalimentano.
pièce che ogni anno si sviluppano e prendono vita nei boschi di Campsirago all'interno del festival “Il Giardino delle Esperidi” in Brianza. Il cammino è scoperta, curiosità, cercare, vedere, osservare, entrare in nuovi mondi, avere occhi nuovi. Proprio come il teatro. O il racconto, la parola, quel suono pieno di senso che riempie la natura circostante in una continua altalena tra il metaforico e il fisico, tra l'immaginario e il reale per un viaggio da fare con i piedi fuori nel mondo e uno tutto interiore e personale da realizzare attraverso l'ascolto. Due binari, due viaggi, interno ed esterno che non si annullano ma anzi si elevano, si assommano, si esaltano, si moltiplicano, si autoalimentano.
Possiamo certamente inserire anche il duo vercellese-australiano Cuocolo/Bosetti in questo carnet di artisti che hanno scelto questa forma d'arte. I CB poi ne hanno tratto un vero e proprio format che si declina, da alcune stagioni, in varie forme: sono nati così negli anni “The Walk”, nelle strade cittadine, o “Underground”, che abbiamo visto nella metropolitana di Napoli, “Exibition”, nei musei, e questo “Dickinson's Walk” che abbiamo potuto osservare e vivere all'interno del Parco Ducale a Parma nella stagione estiva del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti a cura del direttore artistico Giuliano Maria Tenisci. Ed esistono due storie, due linee, due diverse bisettrici per comprendere il composito lavoro dei CB, un prima dove le performance erano per pochi spettatori, a volte anche uno solo, all'interno di appartamenti, che definirei “claustrofobico”, interiore, ed un secondo momento, con i “Walk” tutto fuori, con qualche decina di astanti seguaci di Roberta pifferaia magica, in cammino per raggiungere vette liriche e angoli profondi. Due facce della stessa poetica. La voce soffice e soave ci guida, ci istiga, ci deraglia,  si insinua, noi la seguiamo fedeli verso l'ignoto, attraverso prati di foglie secche, alberi di ippocastano, passando dentro siepi fiabesche. E' caldo sullo sterrato che ci porta alla grande vasca, le nostre cuffie sono di blu illuminate.
si insinua, noi la seguiamo fedeli verso l'ignoto, attraverso prati di foglie secche, alberi di ippocastano, passando dentro siepi fiabesche. E' caldo sullo sterrato che ci porta alla grande vasca, le nostre cuffie sono di blu illuminate.
La Bosetti è una donna di Modigliani dentro un quadro di Hopper, affascinante come la Dama con l'ermellino, soffice come la Gioconda, eterea come la Ragazza con l'orecchino di perla, elegante come Venere del Botticelli e delicata come la Giuditta di Klimt tra i rumori di fondo del bosco e le grida della città, gli strepiti di questa fauna che popola il parco. Ci racconta/declama le poesie di Emily Dickinson (i numeri, che per la poetessa statunitense dell'Ottocento, sostituivano i titoli delle liriche, stoppano leggermente il pathos e interrompono lo scorrere fluido tra i versi) nel contrasto tra le sculture bianche classiche del giardino e la popolazione che bivacca, che sporca panchine e prati, che beve  birra rotolandosi. L'incedere è cadenzato, troviamo il nostro andamento, il tempo del gruppo, sentiamo i nostri stessi passi che rimbombano, salgono al naso forti gli odori dell'erba, cerchiamo riparo sotto le gigantesche chiome degli alberi.
birra rotolandosi. L'incedere è cadenzato, troviamo il nostro andamento, il tempo del gruppo, sentiamo i nostri stessi passi che rimbombano, salgono al naso forti gli odori dell'erba, cerchiamo riparo sotto le gigantesche chiome degli alberi.
Lei è l'insegnante, la docente, la maestra, la madre, noi siamo scolaretti, studenti peripatetici e alunni, figli. Corrono i cani liberi di annusarsi, corrono i podisti sudati, lontano un hip hop sguaiato. Controlliamo il passo e le scarpe, i piedi e i talloni, le suole e le tomaie e intanto le parole ci colgono e ci colpiscono, ci feriscono o ci accolgono, ci abbracciano e ci scuotono: siamo senza difese perché dobbiamo pensare contemporaneamente ad andare. Conosciamo con le orecchie e conosciamo con i piedi. Scricchiolano croccanti i passi, scricchiola l'anima nei sentieri tracciati o appena scovati dentro le nostre autobiografie che trovano echi e rimandi e suggestioni con le parole della Dickinson. Proseguiamo caracollando, avanziamo labirintico. E non ci fermeremo mai.
visto a Parma il 15 giugno 2022
Tommaso Chimenti 16/06/2022
Aprono il "Campania Teatro Festival" Lina Sastri e un Amleto uscito dal carcere minorile
NAPOLI – Anche se il mare non lo vedi, di sottofondo ti arriva sempre a prendere. Ti sposta, una carezza decisa, come un tirarti sottobraccio, amichevole e netto. Tutte le strade portano alla maestosità del Maschio Angioino che, anche con le gru che tentano invano di bloccarne la visuale, anche con gli infiniti lavori della metropolitana, se ne sta lì vedendoci passare piccoli, con gli occhi stretti davanti alle sue pietre brune, ai suoi merli, alle sue torri imponenti. Sui muri dei vicoli spuntano gatti francesi sorridenti disegnati con colori sgargianti che il tempo e il caldo hanno scolorito senza però perderne la felicità, la sornionità napoletana di sopravvivere alle incertezze, di fronteggiare le avversità, di tenere botta ai giorni, agli anni, alle difficoltà. E guardando in alto appaiono le sirene sovrappeso in zona Piazza Bellini dove le camionette dell'esercito se ne stanno davanti al grande murales che inneggia ad un celebre gruppo organizzato del tifo per il Napoli, come un Caravaggio tra la frutta in via dei Tribunali. I panni stesi sono un'installazione continua, a cielo aperto, tirare il naso all'insù è un esplodere di colori, di tele che svolazzano sopra la testa a creare un puzzle, un mosaico da portarsi dentro. E ancora il Mulino arrugginito in una traversa di via Toledo, donchisciottesco e decadente tra i palazzoni del centro, ci dice che qui l'Utopia vive e sopravvive, anche se le pale non sono funzionanti, anche se sembra aver perso il suo smalto, ma resiste “in faccia ai maligni e ai superbi” direbbe un De Gregori circense. E poi c'è il Colapesce ritratto, testa di pesce e corpo da Re con tanto di tridente in mano e le regole di vita vergate sul bandone di un bar in zona Università che sarebbero da imparare, seguire, ripassare ogni giorno della propria esistenza. Napoli è un respiro, a volte è un fritto, a volte uno sbuffo delle televisioni sempre accese i cui colori smodati escono aggressivi dai bassi, ora è una sirena, adesso uno sbattere d'ali di piccioni. Se Napoli è già un teatro a scena aperta, il “Campania Teatro Festival”  (budget 4 milioni e mezzo) è teatro nel teatro, esaltazione del teatro, anche se il suo fondale, da qualche anno, è confinato nel bellissimo polmone verde che guarda la città dall'alto, tra le palme e i due palchi organizzati alla Reggia di Capodimonte. Sopra nel cielo, sembrano rincorrersi gli strepiti dei gabbiani che urlano al tramonto la loro voglia di vita o la loro paura delle tenebre, e gli aerei che, incuranti degli uomini così piccoli là sotto, sferragliano con le loro tonnellate, con i loro fumi come siluri tra le nuvole arrivando e ripartendo da Capodichino con le loro lucine accese a lasciare una scia fosforescente e ipnotica nell'azzurro sopra le nostre teste rapite.
(budget 4 milioni e mezzo) è teatro nel teatro, esaltazione del teatro, anche se il suo fondale, da qualche anno, è confinato nel bellissimo polmone verde che guarda la città dall'alto, tra le palme e i due palchi organizzati alla Reggia di Capodimonte. Sopra nel cielo, sembrano rincorrersi gli strepiti dei gabbiani che urlano al tramonto la loro voglia di vita o la loro paura delle tenebre, e gli aerei che, incuranti degli uomini così piccoli là sotto, sferragliano con le loro tonnellate, con i loro fumi come siluri tra le nuvole arrivando e ripartendo da Capodichino con le loro lucine accese a lasciare una scia fosforescente e ipnotica nell'azzurro sopra le nostre teste rapite.
E' stato un soffio potente, leggero e profondo, quello che ha aperto questa edizione del festival diretto da Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi, da considerare più per il percorso esistenziale ed emozionale che dal punto di vista artistico. Quale personaggio migliore di “Amleto” per raffigurare un giovane in balia del Sistema, tra le gabbie della sua fortezza, vera o presunta, chiuso tra quelle pareti a chiedere giustizia e verità, a voler mettere in atto la sua vendetta? E' un Amleto particolare questo portato sul palco dai ragazzi del carcere minorile di Airola e dalle studentesse dell'Istituto I.S.A.M. de' Liguori di Sant'Agata de' Goti. Schegge di Amleto, sprazzi di Shakespeare, spunti secolari, lampi che toccano, hanno toccato e toccheranno tutti gli uomini prima e dopo di noi. Il classico che s'infarcisce di oggi, le parole del Bardo, con piccole dosi di ironia funzionano, intervallate dalla contemporaneità che bussa alle porte, irrompe sulla scena senza chiedere permesso. I ragazzi entrano in nero sul boccascena, hanno dei bastoni in mano per battere il tempo. Airola che prende le fattezze di Elsinor, con una prigionia che si fa fisica e mentale, reale e psicologica. Amleto diventa Amlè, Ofelia è Ofè. Spunta anche un cantante neomelodico, ma quello che più ci ha colpito, e che ha dato un valore più alto e tangibile all'operazione, sono stati gli inserti hip hop (il maestro è stato il cantante Lucariello) con alcune canzoni-sfogo che hanno squarciato la quarta parete, pur nell'oggettiva incomprensibilità (per i non napoletani) ma con una potenza di fuoco ruvida, una voce che arrivava a toccare corde lontane, distanti dal buonismo e senza lamentazioni, tasti perduti dentro il cuore e la pancia del pubblico. In quelle parole così piene e rudi, così gracchianti e graffianti, così sentite e vere, sta il nocciolo e il centro e il fulcro di questo “Amleto Principe di Airola” (il presentatore è quello che meglio reggeva i tempi e i ritmi, dovrebbe continuare a fare teatro), improvvisazioni su basi dai bassi potenti. E in ogni rima sembrava di rivedere alcune vite segnate, alcuni destini tranciati troppo presto. Ma il teatro è una risorsa, è una via di fuga, può essere una finestra oggi per guardare fuori dalle sbarre, domani per immaginare per se stessi un futuro (anche se non intrapreso a livello professionale) non penalizzato, un avvenire da riempire di cose positive. Ecco “Mammà”: “Come eri bella quando mi capivi, Sei sempre pronta a prenderti questo male, Come eri bella quando mi guardavi e con il sorriso mi dicevi tutto. Fermerei il tempo tra le tue braccia, Un’ora a settimana non mi basta mai, Mamma ti chiedo scusa in questa canzone che tra quattro mura sto scrivendo. Ogni pensiero mi parla di te che mi difendi anche se ho sbagliato, Siamo lontani ma sei sempre presente, Sei un pensiero fisso nella mia mente. Mamma ti regalerei la mia vita, Perché tu stai pagando i miei sbagli e non lo meriti, ti voglio bene. Tutti i pensieri mi parlano di te, Porti la croce per questo figlio tuo e ora mamma tu non ci sei, Ma questa condanna deve finire”. Il teatro, e la musica, come voglia di rinascita, rivincita, rivalsa. Ma, ed è qui che la storia cambia, e deve necessariamente cambiare per interrompere la catena di errori, il nostro Amleto quando ha la possibilità di vendicarsi, con la spada in pugno, fa un passo indietro e non cade nella trappola della vendetta che uccide sia l'ucciso sia l'uccisore. E' questo l'insegnamento più grande, uscire dalle regole tribali, dall'occhio per occhio e dente per dente, il riuscire a razionalizzare senza farsi muovere dall'istinto primordiale delle belve feroci. E poi arriva “Guagliune sfurtunat” che racconta di solitudine ed emarginazione, di lontananza, della scuola che non riesce a colmare il divario tra le possibilità delle varie classi sociali: “Ricordo quando andavo a scuola, Lo ricordo come se fosse adesso, ricordo che tutti ridevano perché avevo le scarpe bucate. Nel banchetto ero sempre solo, all’inizio non capivo il perché, Non si avvicinava nessuno, si sentivano diversi da me. Non avevo una maglietta come loro. Non avevo un paio di scarpe buone ma mi accontentavo di quelle che poteva permettersi mia madre che ogni giorno mi donava il suo cuore. Tutti si riunivano in gruppi, Io sempre solo come un lupo. Sono cresciuto sempre da solo”. La bellezza forse non salverà il mondo ma l'arte può sicuramente innescare il cambiamento.
E' una lettera aperta,  scritta ancora con il cuore frantumato, con delicatezza, ma senza sdolcinature, una missiva mai consegnata scritta con il sangue della memoria, con la linfa del ricordo, quella che Lina Sastri (una delle ultime signore del teatro) ha portato in scena ne “La Mancanza” (prod. Salina) per il fratello scomparso. Non è solo una morte questa ma un accanimento che alcune esistenze attuano: nel 2013 un'emorragia cerebrale seguita, dopo riabilitazione, dalla scoperta di un cancro nel '17 ed infine ad inizio '21 il Covid che ha posto fine agli ultimi otto anni di calvario, di martirio, di dolore e tragedia. Quindi non è la morte il sentimento e la situazione che affronta la Sastri ma questo lento scivolare verso la fine, lunga e travagliata altalena tra difficoltose e tortuose riprese fisiche e interiori e la nuova mannaia calata a troncare sogni e aspettative di ripresa. Come stare sulle montagne russe, dentro e fuori l'ospedale con la speranza ogni volta da riattivare, i risvegli e le ricadute, gli slanci e le depressioni, il nuovo entusiasmo ritrovato e continue delusioni. Una tragedia personale nella quale, con dolcezza e pudore, ci conduce l'attrice che ci apre le porte dei suoi diari, delle sue note, dei suoi bloc-notes pieni di appunti, di considerazioni dove tratteggia, con grande umanità, la tenacia e la tenerezza, l'impotenza come il perdono. Ricordare è portare nuovamente al cuore. Un percorso dentro la mancanza, un girovagare in mezzo alle parole per trovare un senso all'assenza, l'autopsia di un sentimento, con lucidità ma senza fredda razionalità, anzi con passione e forza, mettendo in campo tutta la fragilità e il coraggio. “La mancanza” è un taglio di Lucio Fontana sulla pelle, è un guardare dentro la ferita e provare una vertigine, è vedere la carne viva, è una lezione di vita che ci dice che anche di fronte all'ineluttabile, all'incertezza del presente, quando si è immersi nella sofferenza e nella solitudine di tenere dritta e viva la barra della coscienza, dell'integrità anche quando tutto attorno a noi ci direbbe di mollare, di lasciarsi andare, di cadere in quello stesso vortice e baratro. La morte delle persone che ci stanno a fianco è un peso insopportabile (“Sono morta un po' anch'io”) che, forse, solo la rielaborazione, che non può essere consolatoria, attraverso le parole e la scrittura e quella terapia condivisa e collettiva chiamata teatro, può leggermente scalfire e lenire. L'Arte ci dice che non siamo soli.
scritta ancora con il cuore frantumato, con delicatezza, ma senza sdolcinature, una missiva mai consegnata scritta con il sangue della memoria, con la linfa del ricordo, quella che Lina Sastri (una delle ultime signore del teatro) ha portato in scena ne “La Mancanza” (prod. Salina) per il fratello scomparso. Non è solo una morte questa ma un accanimento che alcune esistenze attuano: nel 2013 un'emorragia cerebrale seguita, dopo riabilitazione, dalla scoperta di un cancro nel '17 ed infine ad inizio '21 il Covid che ha posto fine agli ultimi otto anni di calvario, di martirio, di dolore e tragedia. Quindi non è la morte il sentimento e la situazione che affronta la Sastri ma questo lento scivolare verso la fine, lunga e travagliata altalena tra difficoltose e tortuose riprese fisiche e interiori e la nuova mannaia calata a troncare sogni e aspettative di ripresa. Come stare sulle montagne russe, dentro e fuori l'ospedale con la speranza ogni volta da riattivare, i risvegli e le ricadute, gli slanci e le depressioni, il nuovo entusiasmo ritrovato e continue delusioni. Una tragedia personale nella quale, con dolcezza e pudore, ci conduce l'attrice che ci apre le porte dei suoi diari, delle sue note, dei suoi bloc-notes pieni di appunti, di considerazioni dove tratteggia, con grande umanità, la tenacia e la tenerezza, l'impotenza come il perdono. Ricordare è portare nuovamente al cuore. Un percorso dentro la mancanza, un girovagare in mezzo alle parole per trovare un senso all'assenza, l'autopsia di un sentimento, con lucidità ma senza fredda razionalità, anzi con passione e forza, mettendo in campo tutta la fragilità e il coraggio. “La mancanza” è un taglio di Lucio Fontana sulla pelle, è un guardare dentro la ferita e provare una vertigine, è vedere la carne viva, è una lezione di vita che ci dice che anche di fronte all'ineluttabile, all'incertezza del presente, quando si è immersi nella sofferenza e nella solitudine di tenere dritta e viva la barra della coscienza, dell'integrità anche quando tutto attorno a noi ci direbbe di mollare, di lasciarsi andare, di cadere in quello stesso vortice e baratro. La morte delle persone che ci stanno a fianco è un peso insopportabile (“Sono morta un po' anch'io”) che, forse, solo la rielaborazione, che non può essere consolatoria, attraverso le parole e la scrittura e quella terapia condivisa e collettiva chiamata teatro, può leggermente scalfire e lenire. L'Arte ci dice che non siamo soli.
Visti a Napoli il 10 giugno 2022.
Tommaso Chimenti 14/06/2022
"Torino Fringe Festival": il teatro indipendente sugli scudi
TORINO – Torino Caput Mundi. O quanto meno dell'Italia. Se Milano è città europea, Torino le va subito a ruota. Qui accadono le cose, pur nelle contraddizioni, si ha la netta sensazione che questa metropoli, una volta considerata aristocratica e adesso cosmopolita, sia in cammino, in movimento. A Torino non ci si annoia. Negli ultimi anni infatti, su questa sponda del Po, sono, non a caso, approdati il Salone del Libro come i Masters di Tennis o ultimamente l'Eurovision. L'arabo che prende piede, la Francia così vicina, la maestosità delle montagne sullo sfondo di questa cartolina, Torino incastrata tra il mare ligure e le Alpi, la Torino solida per natura, per dna basti pensare ai suoi due simboli per eccellenza: il toro, che dà il nome all'unica squadra di calcio tifata in zona, e la Mole. Ma è grazie al “Fringe Festival”, alla sua decima edizione, che ci siamo spinti lungo bisettrici laterali, esplorando quartieri popolari fuori dalle rotte classiche turistiche; e così abbiamo visitato (tra le dieci location della rassegna) Casa Fools che da fuori sembra un negozio e invece dentro si apre in un'accogliente sala, ed ecco lo Spazio Kairos ex fabbrica di colla poi divenuta ditta di terra rossa per i campi da tennis sbriciolando mattoni, poi scuola circerse adesso teatro con la forma di un fienile, o ancora il Circolo di via Baltea quasi una serra, e infine lo Spazio Ferramenta, luogo di culto comunista, vicino al museo Mao, tutto votato al sovietico, al cimelio russo (non il momento migliore per la nostalgia socialista), con la sua sala sotterranea fresca che sembra di scendere nelle segrete di un castello o nella sala torture. Una trentina gli spettacoli off proposti, sei repliche ognuno, grande carica, grande energia per tre settimane di freschezza e colori, di fermento, di ribollire, di incontri e collaborazioni, di scambi e incroci, di conoscenze e vicinanze artistiche e umane. Il Torino Fringe (la direzione artistica è affidata a Cecilia Bozzolini, Pierpaolo Congiu, Michele Guaraldo,  Lia Tomatis) vale sempre una visita per l'accuratezza delle scelte, per la dedizione, per lo spirito che scorre sottopelle come filo sotterraneo riempiendo le atmosfere di ogni spazio dedicato al palco e ai suoi derivati.
Lia Tomatis) vale sempre una visita per l'accuratezza delle scelte, per la dedizione, per lo spirito che scorre sottopelle come filo sotterraneo riempiendo le atmosfere di ogni spazio dedicato al palco e ai suoi derivati.
Il nostro viaggio è cominciato con “L'origine dell'occhio” del giovane Collettivo Spinaci dell'acqua (nato all'interno del Progetto Cantiere del Festival Incanti diretto da Alberto Jona)che hanno messo in campo la loro ingenuità artistica ma anche idee e voglia, visione, spirito, immaginazione, lavoro e una ricerca invidiabile. Due tavoli laterali, quasi tecnigrafi da geometri, e nel mezzo un telo per le proiezioni, un impianto tanto semplice quanto artificioso che aveva sentori di laboratorio come di artigianalità, di esperimenti scientifici come di manualità tecnica. Se il musicista stava in mezzo ai suoi aggeggi meccanici, oggetti strani, insoliti e inusuali strumenti musicali che producevano inquietanti suoni di caverna, di abisso, di sirene d'Ulisse, di canto delle balene, dall'altra parte la performer muoveva i suoi piccoli arnesi mentre piccole telecamere ne riproiettavano le fattezze amplificate sullo schermo creando una bolla cinematografica dove perdersi. Non solo oggetti miniaturizzati ripresi (qui ci sono tornate in mente le esecuzioni di David Espinosa, specialmente “Mi gran obra”) ma anche libri pop-up (e in questo caso ci sono balzati agli occhi i Sacchi di Sabbia con “Un fossile di cartone animato”) le cui pagine, una volta voltate, escono prepotenti come montagne, prendono forme, aumentano il loro volume, diventano tridimensionali. Una poetica che scivola nell'infantilismo, con delicatezza, una rotta che tende in maniera ostinata e contraria allo stesso tempo verso le paure ancestrali dell'Uomo, ovvero da dove veniamo e dove stiamo andando ma soprattutto chi siamo. Il loro (in scena Martina Mirante e Costantino Orlando) è un racconto sull'origine della vita sul pianeta Terra. Sembrano amanuensi piegati sui propri tomi di studio alla ricerca del Sacro Graal, curvi impegnati tra i loro alambicchi e pozioni e intingoli e arcani. Ed è interessante vedere il prodotto del loro fervente lavoro (e lavorio) come è altrettanto coinvolgente esaminare le postazioni aggrovigliate e arruffate, captando gli autotune e le eco, i riverberi, le mosse tra piccoli segmenti, tra microattrezzi che si trasformano in maniera alchemica in cinema casalingo. L'immagine iconica conclusiva con l'attrice abbracciata al lenzuolo diventa in un attimo l'affresco ambientalista di una ragazza abbarbicata alla coda di un cetaceo: questi ragazzi hanno tenacia, tenerezza e grazia: “Non sarà il canto delle sirene, nel girone terrestre ad insegnarci quale ritorno attraverso le tempeste, quando la bussola s'incanta, quando si pianta il motore, non sarà il canto delle  sirene ad addormentarci il cuore”, De Gregori rules.
sirene ad addormentarci il cuore”, De Gregori rules.
Climax completamente opposto è quello invece che porta in scena, e che riesce ad alimentare Willy nel suo “Clown Last Show”. Come bravi soldatini compiliamo un foglio anonimo con i nostri ultimi desideri prima di lasciare questo mondo e li infiliamo in una boccia da pesci rossi: è chiaro di cosa parlerà lo spettacolo ed è chiaro come andrà a finire. Ci si presenta subito un clown aggressivo, alla Leo Bassi ma senza quella carica dirompente e dissacrante. I vuoti sono corposi, i silenzi ampi e consistenti ma con una canzone dopo l'altra si cerca-tenta-crede di ovviare alla mancanza di senso, di testo, di drammaturgia. Entra una bara in scena e il prevedibile diventa reale. Aumentano le attese ed è snervante questa riproposizione della Famiglia Addams, il macabro che sfocia nell'ironia caustica, nel rapporto tra il capocomico e la sua aiutante: le gag sono consunte e consumate, la musica è debordante che sembra di essere in un piano bar e viene usata esclusivamente come riempitivo, la sostanza è minima se non infinitesimale, il tedio ci assale in questo brodo che viene continuamente allungato di superficialità, l'entusiasmo è ai minimi storici e neanche il continuo ricorso al pubblico, portato in scena, riesce a rivitalizzare il boccheggiante, ansimante, agonizzante, claudicante, stanco show: “Io sono un clown e faccio collezione di attimi”, sosteneva Heinrich Böll. Qui sono mancati proprio gli attimi.
Stuzzica e affascina l'impianto creato da Davide Carnevali nel suo “Calciobalilla”, un gioco nel gioco, una partita di ping pong che si trasforma in pedana di scherma che diventa un finale di partita scacchistico beckettiano. Ci si aspetterebbe il classico calcino con gli omini fissi e immobili blu e rossi impagliati nelle stesse pose lungo le assi di ferro a muoversi soltanto lateralmente, e invece ecco la prima sorpresa: la scena. Una lettura a tavolino con i due attori (Fabrizio Martorelli e Stefano Moretti efficaci, tormentati, turbolenti, furiosi, provocatori, molesti) e il regista-direttore d'orchestra (Claudio Boschi kantoriano), tre voci profonde radiofoniche, e microfoni che colano e calano a piombo ad ovattare il suono, ad imperlarlo, ad emanciparlo, a riecheggiare lo spazio. Il testo, un'operetta gioiosa e furiosa, è un perdersi futurista, è una continua rivelazione ed epifania, è un cadere e ripartire come le corse attorno a questo tavolo-campo di battaglia, è una rima dietro l'altra che amplifica il senso ma che al tempo stesso lo dissolve, lo distrugge, impastando tutto in un'onda, in un'armonia dove è piacevole naufragare e lasciarsi cullare. I due hanno fogli in mano, adesso sembra un doppiaggio ed è proprio quando ti concentri sui movimenti di quest'esperimento che emerge prepotente il testo (ha aperto spazi  riconducibili al “Cyrano de Bergerac” di Rostand) e le sue parole concatenate, ed è proprio quando surfi sulle sillabe che la macchineria meramente teatrale si esalta e vive e guizza tra gol o canzoni sudamericane che mordono l'anima, infarti d'assonanze, disillusi come filastrocche, abbandonati nei rimandi semantici, sovraesposti negli sberleffi, orfani di calembour. In definitiva la vita è “una partita di calcio da giocare da fermi”. Diceva un anonimo: “Mi sento come se nella partita di calcetto di ieri io fossi stato il pallone”.
riconducibili al “Cyrano de Bergerac” di Rostand) e le sue parole concatenate, ed è proprio quando surfi sulle sillabe che la macchineria meramente teatrale si esalta e vive e guizza tra gol o canzoni sudamericane che mordono l'anima, infarti d'assonanze, disillusi come filastrocche, abbandonati nei rimandi semantici, sovraesposti negli sberleffi, orfani di calembour. In definitiva la vita è “una partita di calcio da giocare da fermi”. Diceva un anonimo: “Mi sento come se nella partita di calcetto di ieri io fossi stato il pallone”.
Si ride, a tratti smodatamente altre amaramente, con gli “Happy Days” di Stefano Santomauro, terza appendice comico-grottesca sulle italiche falle comportamentali, dopo “Fake Club” e “Like”. Il livornese è scatenato, riempie la scena, la fa sua, e somiglia, come impatto, forza espressiva, argento vivo addosso, a Jack Black in “School of Rock”. Le sue analisi sul reale certo sono declinate sul brillante cercando sempre di ridere delle tragedie, ma hanno tra le righe il desiderio di comprendere meglio i nostri tempi bui, di sviscerare l'affresco degli anni, caotici e in continua evoluzione, che stiamo vivendo, o subendo, sulla nostra pelle stanca. Qui si parla di felicità rapportando il Bel Paese al Nord Europa, alla Scandinavia dove, nonostante il clima inclemente e l'alto tasso dei suicidi, sono sempre nelle prime posizioni nella classifica dei popoli più happy per reddito, welfare, aspettative di vita, onestà e fiducia nel governo, salute. Perché, si chiede e ci interroga Santomauro (uno dei crack del Fringe a livello di pubblico presente), sempre spigliato e pimpante, frizzante ed esplosivo, con la sua classica veemenza e la sua postura guerrigliera da mitragliatore, se in Italia abbiamo tutto non riusciamo ad essere felici come quelle nazioni che hanno meno di noi? Cosa è successo? “Perché ci siamo ridotti in questo Stato?”, cantava Caparezza, con la S volutamente maiuscola. Quindi l'indagine (scritta in collaborazione con Marco Vicari e Daniela Morozzi) del comico livornese (che ha tempi e scansioni e ritmo perfetti) è tutt'altro che leggera, ci stuzzica, ci fa riflettere, continuando a ridere di gusto, tra pezzi talmente assurdi di autobiografia da essere realmente accaduti. Il suo sguardo è quello incisivo che trafigge di Van Gogh, le sue mani frullano, non perde un colpo, trascina le folle, è un capopopolo battagliero e sa come arringare la platea. Si esce più consapevoli, con tante domande alle quali rispondere sorridendo. Forse più felici. “Ha stato lo Stato”, urla un murales.
rispondere sorridendo. Forse più felici. “Ha stato lo Stato”, urla un murales.
Un divano e un interno borghese ci attendono sulla scena di “Una cena d'addio” degli Onda Larsen nel loro teatro rinnovato con uno spazio all'esterno in stile baita, un vero e proprio foyer all'aperto ospitale e accogliente. L'ambientazione e la cadenza, l'andamento e il ritmo, le situazioni e la scelta delle parole sono indubbiamente francesi (gli autori sono gli stessi de “Il nome del figlio” trasposto anche in Italia), e alle gag e ai misunderstanding si sommano grandi valori sociali, civili e quel pizzico di cinismo che rende il tutto più interessante e pungente, certamente divertente. Ad essere sul tavolo anatomico è l'amicizia. Una coppia decide di seguire l'esempio di un loro conoscente che organizza delle cene d'addio con i suoi amici per “tagliare i rami secchi” delle relazioni inutili e circondarsi di nuove persone più stimolanti. I tre in scena (Lia Tomatis, Riccardo De Leo, Gianluca Guastella tosti) hanno piglio brillante, i dialoghi tengono, la tensione regge: marito, moglie e il terzo incomodo, perché la compagna di quest'ultimo non si è neanche degnata di presenziare, senza avvertire, alla cena-resa dei conti. E infatti escono fuori, come in un duello da Far West, le acredini incancrenite da anni, i difetti nascosti e mal sopportati, le crepe non dette, i livori sotterranei, le ragioni taciute per il quieto vivere, le litigate postdatate. Viene fuori tutto, come un vomito irrefrenabile, tra nevrosi e psicoanalisti, tic e egocentrismi, manipolazioni e consuetudini noiose. Una sorta di Ultima Cena per azzerare le amicizie ormai meccaniche senza più l'intimità che le hanno generate (ricorda “La cena dei cretini”, non a caso francese anch'esso). Si ride molto di noi, del nostro avere bisogno degli altri e allo stesso tempo del nostro essere antisociali; in una parola sola, bipolari: “Di quei violini suonati dal vento l'ultimo bacio mia dolce bambina brucia sul viso come gocce di limone l'eroico coraggio di un feroce addio”, Carmen Consoli docet.
Tommaso Chimenti 02/06/2022
Libro della settimana
-
 "Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…













