NARNI – Spoleto, Todi, Narni. In Umbria, teatralmente parlando, accadono le cose, il panorama si muove. Davide Sacco, codirettore del festival Narni Città Teatro assieme a Francesco Montanari, ha portato il teatro in ogni angolo, piazza, sala, in un teatro da restaurare e ripristinare, come in chiostri e giardini, scorci di valle e maneggi di cavalli, al castello come un su tavolo, negli anfratti di mura scorticate e divelte come su un tessuto aereo, nei porticati, orti, spiazzi, terrazze. Dovunque ci sia un luogo per mettersi in cerchio e vedere e ascoltare qualcuno posto al centro, allora lì c'è teatro, lì si può fare teatro. Perché il teatro è un sentire, è un luogo dell'anima e mai un luogo fisico. Una città-teatro all'aperto: abbiamo trovato una cittadina viva, fervente, spumeggiante, pronta alla contaminazione, elettrica, frizzante, ricettiva e allestita per accogliere i diversi e nuovi linguaggi della scena, dalla prosa ai kids, dal circo all'affabulazione, dalla musica al parkour, dal comico al grottesco, dalle prove aperte in norvegese fino alle performance sonore o quelle all'alba o dopo la mezzanotte. Un grande lavoro progettuale e organizzativo. Non ci si annoia: si entra e si esce dagli spazi non convenzionali, si incontrano Filippo Nigro come Sabina Guzzanti e mille altri volti noti del nostro teatro. C'è carica e tensione positiva, nell'aria frigge qualcosa come lo zucchero filato che continua nel suo vorticare con il lungo bastoncino nella magia alchemica della trasformazione dai granelli ruvidi a quella nuvola-batuffolo che è un salto carpiato nell'infanzia, nei Luna Park dei nostri  ricordi sbiaditi. Dei tanti appuntamenti proposti (trentadue per sessanta repliche complessive in tre giorni significa un illuminato vortice, un folgorante tourbillon di bellezza) ne abbiamo scelti sei, quelli che, per un verso o per l'altro, ci hanno maggiormente toccato, sollecitato, solleticato, ispirato, spostato.
ricordi sbiaditi. Dei tanti appuntamenti proposti (trentadue per sessanta repliche complessive in tre giorni significa un illuminato vortice, un folgorante tourbillon di bellezza) ne abbiamo scelti sei, quelli che, per un verso o per l'altro, ci hanno maggiormente toccato, sollecitato, solleticato, ispirato, spostato.
Ci ha commosso per la sua estrema semplicità, e insieme immaginificità, il ceco “Prefab” per la regia di Dominik Migac: il pubblico, otto persone al massimo, attorno ad una scrivania dove un performer con una maschera, lignea e squadrata, movimenta piccoli oggetti seguendo il filo narrativo dei rumori di fondo che si spandono in audio. Nessuna parola, pochissime azioni, il film è tutto personale. Pochi elementi per stuzzicare la fantasia e farsi dentro ognuno la propria storia. Ci ha ricordato il lavoro dello spagnolo David Espinosa “Una storia universale” oppure l'altro suo piccolo capolavoro “Mi gran Obra”, visto alla Biennale di Venezia. Oppure quello di un altro spagnolo Xavier Bobés con “Cosas que se olvidan facilmente”, al quale assistemmo qualche anno fa al Kilowatt Festival. O ancora l'inarrivabile “Finale di Partita” del Teatrino Giullare. Teatro da tavolino che esplode di senso con piccoli movimenti delle mani che corrono dietro ai segni del sonoro. L'abatjour sopra il tavolo ci appare come la Luna che illumina questo piccolo cubo che diventa casa, questi parallelepipedi (la suggestione ci ha portato ai quadri di De Chirico ma soprattutto alla Chiesa di San Paolo Apostolo progettata da Fuksas a Foligno) che si stravolgono in palazzi. Ecco i passi e rumori del traffico, un abbaiare di un cane, un aprire di porte, l'ascensore che si spalanca con il suo classico cigolio da pellicola horror. Un linguaggio onomatopeico gutturale universale. Non c'è niente, o perlomeno accade realmente poco, tutto prende forma nelle retine  e nelle menti di chi guarda, osserva, ascolta. Il cane che fa la pipì, i vicini che litigano, gli elicotteri, la città che dorme e poi si risveglia in una normalità di cemento con i blocchi che, come in un tetris, si girano e ribaltano componendosi in una creazione articolata con mini diapositive che fanno la loro apparizione alle hitchcockiane finestre di fronte. Nella miniaturizzazione delle abitazioni capiamo la nostra infinitesimale piccolezza e irrilevanza, la periferia e ininfluenza dei nostri ego. Un piccolo gioiello per una mezz'ora miracolosa.
e nelle menti di chi guarda, osserva, ascolta. Il cane che fa la pipì, i vicini che litigano, gli elicotteri, la città che dorme e poi si risveglia in una normalità di cemento con i blocchi che, come in un tetris, si girano e ribaltano componendosi in una creazione articolata con mini diapositive che fanno la loro apparizione alle hitchcockiane finestre di fronte. Nella miniaturizzazione delle abitazioni capiamo la nostra infinitesimale piccolezza e irrilevanza, la periferia e ininfluenza dei nostri ego. Un piccolo gioiello per una mezz'ora miracolosa.
Due le performance che vogliamo mettere insieme per ragioni opposte, “Il Terzo Reich” (prod. Societas) di Romeo Castellucci e “Nella solitudine dei campi di cotone” (prod. CSS) a cura di Mario Martone e qui riproposta da Fabrizio Arcuri. Se nella prima venivamo aggrediti da suoni dirompenti (all'entrata consegnano tappi per le orecchie) e disturbanti associati a parole illuminate sparate a getto continuo (una ogni ventesimo di secondo), per decine di minuti interminabili, ad infastidire l'attenzione e colpire il bulbo oculare in un continuo bombardamento di parole frullate e gettate sul grande schermo con luci stroboscopiche (che regalano nausea) senza  aver trovato alcun nesso con il titolo dell'opera in un susseguirsi monocorde, senza nessun scarto né evoluzione né cambio di direzione, fortunatamente nel secondo è stata potente la nebbia che ha avvolto i pochi spettatori a rappresentazione, con cuffie, immersi dentro un antico teatro da ristrutturare in uno scenario apocalittico beckettiano (ricordava le immagini del teatro ucraino distrutto dagli aggressori sovietici a Mariupol) dove camminare liberamente tra le stanze, perdersi dentro la polvere e le parole pungenti di Koltes nelle orecchie. Un viaggio interiore fatto di sbiadimenti e sbandamenti, di
aver trovato alcun nesso con il titolo dell'opera in un susseguirsi monocorde, senza nessun scarto né evoluzione né cambio di direzione, fortunatamente nel secondo è stata potente la nebbia che ha avvolto i pochi spettatori a rappresentazione, con cuffie, immersi dentro un antico teatro da ristrutturare in uno scenario apocalittico beckettiano (ricordava le immagini del teatro ucraino distrutto dagli aggressori sovietici a Mariupol) dove camminare liberamente tra le stanze, perdersi dentro la polvere e le parole pungenti di Koltes nelle orecchie. Un viaggio interiore fatto di sbiadimenti e sbandamenti, di  visioni distorte, annacquate e appannate, confuse e contemplative, mistiche e allucinate tra i fumi metaforici della memoria, dell'inganno, del mistero, del desiderio rarefatto, della paura dell'ignoto, dell'incubo.
visioni distorte, annacquate e appannate, confuse e contemplative, mistiche e allucinate tra i fumi metaforici della memoria, dell'inganno, del mistero, del desiderio rarefatto, della paura dell'ignoto, dell'incubo.
Abbiamo scoperto Francesco Brandi con la sua storia sul liminare tra sorriso e tragedia, “La fine della Grecia”, passando dal purtroppo recente lockdown alla fine di un amore, soffermandosi sui condomini, tratteggiando, con leggerezza e sensibilità, con grazia e cura, la figura dell'eterno sfigato, il Calimero, il Paperino, il perdente che si deve accontentare di veder sempre vincere gli altri, senza nessuna concessione, senza soddisfazione, represso da anni di ombre, a sopportare dolori e frustrazioni. Commovente il rapporto con il padre, contemporaneo l'inserto del virologo così come il precariato e disperato il licenziamento. Gli vuoi bene al personaggio (e a Brandi), lo vedi un po' come una pentola a pressione che incamera fin quando non esplode di rabbia e ribellione come il tipo di “Un giorno di ordinaria follia”. Certo arriva il lieto fine ma senza sciupare quell'atmosfera calda, opaca, trasognante, riflessiva, senza pedanteria. Non bisogna aver paura di osare, di buttarsi, non bisogna temere di fare la fine della Grecia. Si lascia ascoltare, si lascia volentieri applaudire.
Metti la sera su un prato di un chiostro, metti un grande attore che nemmeno per un minuto sembra che stia recitando, metti la sua naturalezza, semplicità, gentilezza, leggerezza anche nei passaggi più drammatici, metti un teatro partecipativo e interattivo, pieno e coinvolgente ed avrete “Every brilliant thing”. Il testo di Duncan MacMillian, per la regia di Fabrizio Arcuri e l'interpretazione di un gigantesco Filippo Nigro (prod. CSS, Sardegna Teatro) fa letteralmente partecipare tutto il pubblico; infatti ad ogni spettatore viene dato all'ingresso un foglietto con un numero e una frase scritta sopra: sono le varie liste che il protagonista (un bambino che diventa prima un ragazzo e poi un uomo) stila per far comprendere alla madre, depressa cronica, quali e quante sono le cose per le quali valga la pena vivere. La drammaturgia ci ha ricordato “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” di Mark Haddon come “Molto forte, incredibilmente vicino” di Jonathan Safran Foer ma anche le infinite liste presenti in “Alta fedeltà” di Nick Hornby. C'è grande lievità e grazia nei movimenti e nelle parole di Nigro (meraviglioso interprete) che dialoga con la platea che tiene con dolcezza, la accompagna senza formalismi, è affabile, sorride insieme a noi, si intristisce insieme a noi. La storia sembra talmente sua che a tratti potresti chiederti, tanto è credibile e convincente, se possa essere la sua autobiografia. Non 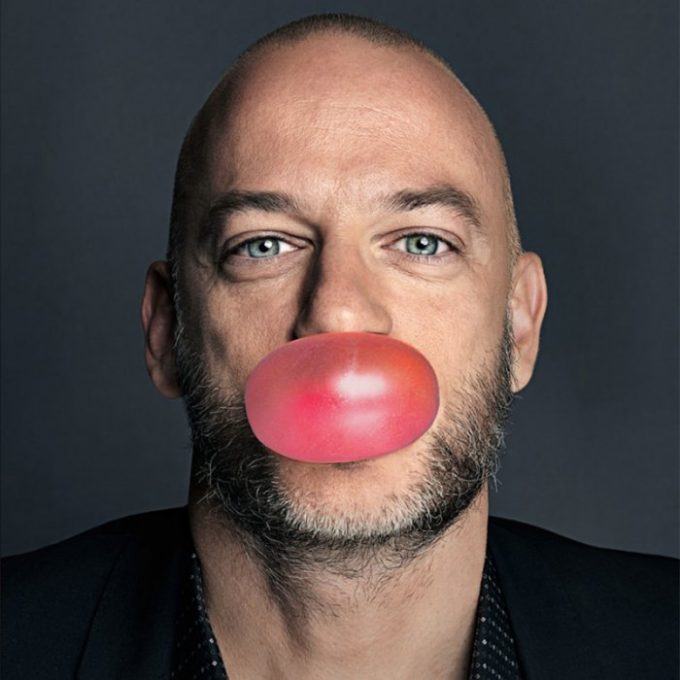 recita ma racconta, ci prende per mano, ci apre la porta sui mondi che riesce a creare con una parola, un passo, una mano tesa, una sospensione carica di pathos. Come un professore che deve interrogare enuncia casualmente i vari numeri delle liste e il proprietario del foglietto di riferimento lo legge ad alta voce, è un incontro, una chiacchierata e un colloquio continuo: si crea un doppio filo che non si spezza, una fiducia reciproca che si rafforza. La storia del ragazzo è straziante: con il padre comunica soltanto attraverso dischi jazz, con la madre soltanto con le liste senza ricevere nessuna risposta, nessun conforto, né confronto, da entrambi. Quando mancano le attenzioni, quando manca il dialogo e l'amore, spesso non riesci a tua volta a donarlo, a passarlo alle persone care che arriveranno nella tua vita. E così anche l'amore per la fidanzata, poi diventata moglie, svanisce, si esaurisce, evapora. EBT lascia un sapore dolce in bocca, una delizia seppur impastata di lacrime perché “la felicità mi ha sempre fatto paura” e nel rischio di essere contenti e soddisfatti, impauriti e timorosi, ci rivediamo tutti, nei nostri piccoli grandi fallimenti, sconfitte, perdite, parole non dette, carezze non date o mai ricevute, nell'impotenza cinica e turgida, nell'assenza di supporto che fa male, nel bisogno di aiuto senza aver la forza di chiederlo. Le liste non salvano ma aiutano a delineare gli obbiettivi, a capire chi siamo, a focalizzare cosa è, o dovrebbe essere, per noi la felicità. La vita non ci salva ma va vissuta fino in fondo.
recita ma racconta, ci prende per mano, ci apre la porta sui mondi che riesce a creare con una parola, un passo, una mano tesa, una sospensione carica di pathos. Come un professore che deve interrogare enuncia casualmente i vari numeri delle liste e il proprietario del foglietto di riferimento lo legge ad alta voce, è un incontro, una chiacchierata e un colloquio continuo: si crea un doppio filo che non si spezza, una fiducia reciproca che si rafforza. La storia del ragazzo è straziante: con il padre comunica soltanto attraverso dischi jazz, con la madre soltanto con le liste senza ricevere nessuna risposta, nessun conforto, né confronto, da entrambi. Quando mancano le attenzioni, quando manca il dialogo e l'amore, spesso non riesci a tua volta a donarlo, a passarlo alle persone care che arriveranno nella tua vita. E così anche l'amore per la fidanzata, poi diventata moglie, svanisce, si esaurisce, evapora. EBT lascia un sapore dolce in bocca, una delizia seppur impastata di lacrime perché “la felicità mi ha sempre fatto paura” e nel rischio di essere contenti e soddisfatti, impauriti e timorosi, ci rivediamo tutti, nei nostri piccoli grandi fallimenti, sconfitte, perdite, parole non dette, carezze non date o mai ricevute, nell'impotenza cinica e turgida, nell'assenza di supporto che fa male, nel bisogno di aiuto senza aver la forza di chiederlo. Le liste non salvano ma aiutano a delineare gli obbiettivi, a capire chi siamo, a focalizzare cosa è, o dovrebbe essere, per noi la felicità. La vita non ci salva ma va vissuta fino in fondo.
Il festival si chiude con il controverso “Uno spettacolo di fantascienza” di Liv Ferracchiati (prod. Marche Teatro, CSS, Metastasio), a nostro avviso il suo spettacolo più composito e “teatrale” e maturo pur sempre inflazionato da quella spessa autoreferenzialità che punteggia i suoi lavori e da quell'insaziabile voglia di portare sul palco, ogni volta, questioni legate alla propria autobiografia. Certo può essere una cifra stilistica ma così l'arte rischia di  essere limitativa e restrittiva e non universale, non pone domande ma esprime soltanto proprie posizioni su un unico preciso quesito personale. “Uno spettacolo di fantascienza” parte come un rarefatto dramma di Jon Fosse (sarà la neve, saranno i blocchi di ghiaccio) e pian piano si fa latelliano come scelte, pupazzi, microfoni, luci, fino a sfiorare il paravidinico, in un continuo teatro nel teatro e un perenne dentro e fuori dal testo, dialogando con la platea come fosse un convegno sul tema preferito. Non si può dire però che, per lunghi tratti, non sia piacevole e alcune riflessioni non colgano il bersaglio dell'emotività. Ferracchiati che non è un attore non poteva però non esserci visto che ogni sillaba è assolutamente grondante del desiderio di parlare delle proprie istanze, invece Petra Valentini ha piglio e sicurezza e carisma, e Andrea Cosentino, bergonzoniano, ne esce bene e, dopo un primo approccio stentato al palco, carbura quando il testo si fa più comodo per le sue corde. Due storie che si intrecciano, come si intreccia la finzione dei personaggi con la vita reale non dei caratteri bensì degli attori stessi in una miscela che spiazza felicemente fin quando la trovata della prova aperta si reitera oltremodo. Il tricheco ci ha portato alla mente a “Un eschimese in Amazzonia”, vecchio titolo dello stesso autore. Anche l'affrontare la fine del mondo si riduce in definitiva alla fine di un solo personaggio, ad un solo esondante Io rimanendo noi esclusi, nell'impossibilità empatica di essere compresi come individui e non strumentalizzati da un compiacimento che tracima. Il fulcro di fondo rimane sempre l'indagine sull'identità che tutto accentra e tritura come unico grande tema della sua produzione: qui si parla forsennatamente dell'identità dicendo però al pubblico, in loop, che questo non è uno spettacolo sull'identità. Un teatro che può risultare “freddo”: una specie di Alaska.
essere limitativa e restrittiva e non universale, non pone domande ma esprime soltanto proprie posizioni su un unico preciso quesito personale. “Uno spettacolo di fantascienza” parte come un rarefatto dramma di Jon Fosse (sarà la neve, saranno i blocchi di ghiaccio) e pian piano si fa latelliano come scelte, pupazzi, microfoni, luci, fino a sfiorare il paravidinico, in un continuo teatro nel teatro e un perenne dentro e fuori dal testo, dialogando con la platea come fosse un convegno sul tema preferito. Non si può dire però che, per lunghi tratti, non sia piacevole e alcune riflessioni non colgano il bersaglio dell'emotività. Ferracchiati che non è un attore non poteva però non esserci visto che ogni sillaba è assolutamente grondante del desiderio di parlare delle proprie istanze, invece Petra Valentini ha piglio e sicurezza e carisma, e Andrea Cosentino, bergonzoniano, ne esce bene e, dopo un primo approccio stentato al palco, carbura quando il testo si fa più comodo per le sue corde. Due storie che si intrecciano, come si intreccia la finzione dei personaggi con la vita reale non dei caratteri bensì degli attori stessi in una miscela che spiazza felicemente fin quando la trovata della prova aperta si reitera oltremodo. Il tricheco ci ha portato alla mente a “Un eschimese in Amazzonia”, vecchio titolo dello stesso autore. Anche l'affrontare la fine del mondo si riduce in definitiva alla fine di un solo personaggio, ad un solo esondante Io rimanendo noi esclusi, nell'impossibilità empatica di essere compresi come individui e non strumentalizzati da un compiacimento che tracima. Il fulcro di fondo rimane sempre l'indagine sull'identità che tutto accentra e tritura come unico grande tema della sua produzione: qui si parla forsennatamente dell'identità dicendo però al pubblico, in loop, che questo non è uno spettacolo sull'identità. Un teatro che può risultare “freddo”: una specie di Alaska.
Tommaso Chimenti 20/06/2022




