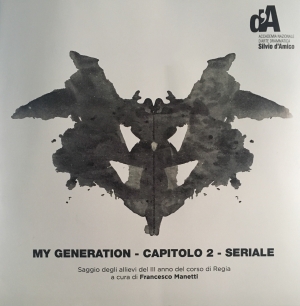My Generation - Capitolo 2 - Seriale: la violenza e il mito contemporaneo del serial killer
La mitologia contemporanea e la psicologia del serial killer sono i temi centrali da cui si sviluppano i tre allestimenti di My Generation, il saggio, a cura del Maestro Francesco Manetti, che gli allievi registi di terzo anno dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica "Silvio D’Amico" hanno realizzato in collaborazione con gli allievi attori del primo anno.
Giunto al secondo capitolo, il progetto My Generation continua a sviscerare le potenzialità sceniche della violenza umana, questa volta con tre drammaturgie originali ispirate a reali assassini seriali: Fritz Harmaann, Edmund Kemper e Andrew Cunanan.
Il primo spettacolo, La luna di Fritz, è scritto e diretto dall’allievo Danilo Capezzani con la collaborazione dell’assistente drammaturgo Alessio Moneta e già nel titolo evoca chiaramente il Licantropo di Hannover, Harmaann. Notevole è in questo caso lo sforzo di regia che riesce a creare l’illusione di una comunicazione fra tempi e spazi differenti: da un lato l’intenso l’io narrante di un folle Harmaan, interpretato da Francesco Brullo, e dall’altro la ricostruzione delle sue terribili gesta. Su due piani diversi, verbale e performativo, viene rappresentato il medesimo il rito morboso fra vittime e carnefice ed è così che lo spettacolo nel suo insieme riesce a trascinare il pubblico nell’abisso mentale dell’omicida.
Il secondo spettacolo, Totem, compie un salto storico di circa mezzo secolo verso l’agghiacciante storia di Ed Kemper come simbolo patologico del "maschio castrato", valida oggi come negli anni Settanta. L’arguzia, la folle consapevolezza e la cinica lucidità di Kemper traspaiono perfettamente nel testo di Matilde D’Accardi e nel personaggio interpretato da Gabriele Pestilli. Anche in questo caso, il regista Federico Orsetti sceglie una sovrapposizione di tempi e spazi, mostrando tuttavia in maniera più netta, attraverso codici illuminotecnici, la distinzione fra il presente e i flashback. Pur se estrema nella sua evocazione, la violenza non colpisce mai direttamente il pubblico e forse anche per questo rimane impressa a un livello più profondo, psicologico, come rimane impresso visivamente l’emblematico totem finale.
Infine, Dopo di me il diluvio, diretto da Caterina Dazzi e scritto da Marco Fasciana, mette in scena un interessante intreccio di monologhi paralleli e indipendenti, idealmente pronunciati in tempi diversi dallo stesso personaggio, Andrew Cunanan, intrepretato da sei diversi attori, al momento dei suoi cinque omicidi e del suo suicidio. È uno spettacolo che si sviluppa per sottrazione, su una scena nuda in cui è solo l’intensità delle parole a evocare sia il contesto della Miami anni Novanta sia le situazioni violente che sono il fulcro dello spettacolo. Il richiamo a Gianni Versace è evidente già nel riferimento al suo assassino, ma costituisce solo l’apice di una riflessione psicologica più complessa sulla spasmodica ricerca di successo e visibilità attraverso gesti eclatanti e irreversibili. Si tratta di un’idea complessa, nel senso che richiede forse allo spettatore una maggiore conoscenza delle vicende biografiche del protagonista e richiede al contempo uno sforzo di interpretazione iniziale che, tuttavia, una volta effettuato permette di apprezzare ancor di più la costruzione asciutta, essenziale e brutale della messa in scena.
Valeria Verbaro, 14/04/2019
Totem: intervista al regista Federico Orsetti
Il 13 e 14 aprile è andato in scena al Teatro Duse di Roma la seconda edizione del progetto My Generation - Serial, saggio di fine anno degli allievi registi al terzo anno dell'Accademia Nazionale d'Arte drammatica Silvio D'Amico. Per l'occasione abbiamo intervistato Federico Orsetti, classe 1994, regista dello spettacolo Totem.
È la prima volta che lavori ad un progetto che ha come tematica principale la violenza? Hai sposato subito la sceneggiatura di Matilde D’Accardi o hai avuto dei dubbi?
"Non è la prima volta che lavoro su tematiche relative alla violenza. Ho avuto modo di avvicinarmi alla violenza psicologica e fisica sia prima che durante la triennale in regia all'Accademia. In Totem, per esempio, la violenza è nella maggior parte dei casi implicita, anche se compaiono dei momenti di violenza più o meno reale. In merito alla sceneggiatura di Matilde D'Accardi non avevo avuto molti dubbi all'inizio, poi proseguendo con la preparazione dello spettacolo abbiamo un po' perso di vista il testo. Non nego che se avessimo avuto modo di confrontarci durante le prove avremmo potuto trovare dei punti in comune, rispetto a quella che era la sua idea di Totem e la mia".
Qual'era la tua idea di Totem?
"Alcune cose sono diverse da come me l'aspettavo, fondamentalmente volevo raccontare di un bambino che si vendica della madre dopo le umiliazioni subite. All'inizio uccideva delle ragazze che ricordavano vagamente caratteristiche fisiche o psicologiche della madre, collezionava le loro teste nell'armadio e quando aveva uno scontro con quest'ultima praticava del sesso orale con questi pezzi di corpi inanimati. Dopo alcuni omicidi il protagonista scopre che il suo problema è sempre stato il rapporto con sua madre e decide di ucciderla".
"La domanda che apre la narrazione è ‘come sarebbe stato se’. Lo spettacolo si sviluppa quindi come un’analisi psicologica o ripercorre cronologicamente i fatti di cronaca legati al protagonista?
"Entrambi, questa forse è la pecca di Totem. Io e Matilde abbiamo voluto raccontare la vita criminale di Kemper soffermandoci anche sulla sua psicologia, partendo da episodi legati all'infanzia. Probabilmente avremmo dovuto prendere un pomeriggio significativo della sua vita e svilupparlo nei 30 minuti dello spettacolo, per approfondire al massimo un singolo avvenimento. Il lavoro di scrittura è stato integrato con dei documenti che ho recuperato dalla polizia scientifica di Roma, tra cui un manuale di criminologia sui serial killer in cui veniva analizzato sia l'aspetto psicologico che il rapporto tra queste persone ed il resto della società. Da qui nasce l'idea di Totem".
Perché avete scelto di intitolare lo spettacolo Totem?
"Perché rimanda al primitivo, all'impulso primordiale che viene onorato nella sua piena forza distruttrice e creatrice allo stesso tempo. Il totem rappresenta la forza animale ma è anche considerata come il primo tentativo delle popolazioni selvagge per evitare l'incesto (perché non ci si poteva accoppiare con qualcuno che apparteneva al tuo stesso clan). Il tema del doppio, che caratterizza il totem, viene riversato sul palcoscenico. La storia ripercorre omicidi, stupri e violenze in onore di questa forza oscura che pervade il protagonista. Come in un totem reale anche in Kemper coabitano due forze naturali, la luce e il buio, il serial killer e il poliziotto, lo sciamano e il cowboy. Un uomo che offre al suo demone le donne e ne costruisce un monumento di corpi in suo onore.
"Da questa tua affermazione non si può non pensare all'ultimo film di Lars Von Trier 'La casa di Jack'. Hai avuto modo di vederlo? Cosa ne pensi?
"Si l'ho visto. Da una parte sono contento perché la mia idea è nata prima del film ma dall'altra lo sono meno perché non vorrei si pensasse che ho portato a teatro quello che Von Trier ha fatto al cinema".
Leggevo che Kemper ha ispirato personaggi della letteratura e del cinema come i protagonisti de ‘Il silenzio degli innocenti’ ed il più recente ‘American Psyco’. Il tuo protagonista è nato dalla commistione di questi esempi popolari o hai trovato l’ispirazione altrove?
"No, non mi sono ispirato a questi personaggi. Non ho un particolare interesse nel cinema anche se di recente mi sono in parte ricreduto. Ho letto diverse biografie di serial killer ma non ho preso spunto ne dal cinema e ne da opere letterarie. Il Kemper in Totem è un personaggio nato attraverso quello che mi interessava raccontare di lui. Mi affascina la sua mente brillante, ha aiutato psichiatri a migliorare l'mda (un test sulla personalità) ed è diventato insegnate in carcere. L'idea che mi sono fatto della sua personalità è paragonabile al nucleo di una stella, pieno di energia, che rischia di diventare un buco nero. Una grande potenzialità che se vissuta male diventa la più distruttiva, come la storia di Lucifero. Secondo me tutti gli uomini nascono buoni poi succede qualcosa in cui - in caso minore maggiore o estremo - la luce originale si trasforma in un buco nero, ed è un processo che non ha una via di ritorno. Per questo è comprensibile che Kemper non abbia mai chiesto perdono per i suoi crimini, perché una mente che possiede ancora un minimo di luce, di coscienza, non potrebbe mai a vivere bene con sé stesso. Forse l'unica opera dalla quale ho preso spunto è 'Il giardino delle delizie' di Bosch, una raffigurazione dell'inferno fatto di pezzi di corpi che manifesta il principio della distruzione".
Passando invece alle serialità televisiva, il caso Kemper ha contribuito alla nascita della serie tv netflix ‘Mindhunter’ solo che qui il punto di vista è quello del negoziatore Ford mentre in Totem viene privilegiata la visione del serial killer. Come mai questa scelta?
"Perché io lo vedo come una vittima e non come il carnefice della storia, gli altri per lui sono i carnefici. Diciamo che lui è stato vittima dei geni, sua madre soffriva di schizofrenia ed era borderline. Scegliere una visione puramente soggettiva sottolinea che lui è l'unico buono, anche se la sua natura rimane un quesito aperto fino alla fine: non sappiamo cosa era e cosa è diventato. Il rischio era quello di farne un martire e non volevo farlo passare per martire, anche perché non sta nell'operazione artistica dare un giudizio. L'operazione artistica sceglie uno sguardo e cerca di approfondire quello sguardo, intercettando la sua anima e il suo cuore, lasciando ognuno alle sue conclusioni. Non deve essere un manifesto. Inoltre ho voluto adottare il punto di vista di Kemper perché i serial killer vengono sempre designati come alieni ma in realtà sono degli essere umani. Non ho mai usato parole come bandito o pazzo, perché non vogliono dire niente, mettono già un pregiudizio negando di base un possibile rapporto umano. Credo che queste etichette allontanino lo spettatore e gli attori, che prima di essere professionisti sono essere umani".
Quindi nella tua visione alla fine lui è ancora una vittima oppure la predominanza della forza negativa lo trasforma in carnefice?
"Nel finale predomina la parte oscura perché Kemper è morto nello stesso momento in cui ha ucciso sua madre. Come capita a tutti i seria killer, dopo aver raggiunto il proprio obiettivo non si ha più un motivo per vivere. Mettendo un attimo da parte la coscienza, lui non si è mai pentito perché il suo è stato un percorso simile al viaggio dell'eroe, che dopo aver ucciso il drago - in questo caso rappresentato dalla madre - porta a termine una narrazione lineare. In questo punto il protagonista non ha più ragione di vivere, ritorna nel mondo ordinario con una consapevolezza diversa. Diventa un servitore dell'odio guidato da questa entità oscura. Il totem rappresenta quindi una metafora dell'esistenza umana, non abbiamo reinventato niente ma abbiamo approfondito un qualcosa raccontando una storia parallela che, pur non essendo quella ufficiale, non è detto che sia meno vera della prima. Dobbiamo ancora decidere se il totem parlerà o meno, sappiamo solo che se lo farà sarà in prosa con una visione leopardiana della natura e della madre".
Secondo te perché negli ultimi anni le narrazioni sui serial killer hanno riscontrato un grande successo e perché la violenza, pur essendo considerata un atto ingiustificabile, è una delle tematiche più frequenti nel teatro, nel cinema e nella letteratura contemporanea?
"Ruben De Luca, criminologo e psicoterapeuta, ha spiegato che il fenomeno dei serial killer è presente solamente nel primo e nel secondo mondo, non ci sono tracce nel terzo e quarto mondo. Ma, mentre nelle due realtà sottosviluppate viene praticato ancora il cannibalismo, il sacrificio umano, e meccanismi tribali in chiave ritualistica, nelle realtà più sviluppate il fenomeno dei serial killer si basa sullo scontro tra l'istinto animale e la razionalità, riportandoci nuovamente al tema del doppio. Abbiamo tutti una parte legata al male che non può uscire, non può essere espressa, non ha diritto di esistere nel nostro mondo e di conseguenza viene nascosta, celata, e come in tutte le opere d'arte quando la parte nascosta viene rappresentata diventa subito catartica, viene esorcizzata. L'analisi di Ruben De Luca crea inoltre un parallelismo tra artisti e serial killer, affermando che il processo di creazione artistica sia molto simile a quello dell'omicidio seriale, un processo che viene suddiviso in varie fasi creative. Il serial killer viene paragonato ad un'artista che riguardando le sue opere e rivive i momenti di gloria".
In un futuro prossimo o vicino ti piacerebbe ampliare questo progetto?
"Sinceramente si. Mi piacerebbe molto perché ci sono ancora tante cose da raccontare su Kemper e più in generale sui serial killer, che hanno delle personalità molto complesse a cui dedicherei volentieri del tempo".
Francesca Totaro
My Generation- Capitolo 2 - Seriale: intervista al Maestro Francesco Manetti
Recensito incontra il Maestro Francesco Manetti, docente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e anche quest’anno curatore di “My Generation”, esercitazione degli allievi del terzo anno di regia dell’Accademia.
Le tre drammaturgie originali, “La luna di Fritz”, “Totem” e “Dopo di me il diluvio”, rispettivamente messe in scena da Danilo Capezzani, Federico Orsetti e Caterina Dazzi, tratteranno anche quest’anno il tema della violenza, declinato però dal punto di vista dell’omicida seriale.
La prima di “My Generation –Capitolo 2 – Seriale” si terrà al Teatro Eleonora Duse il 13 aprile 2019 alle 19.30 e sarà in replica anche il 14 aprile alle 17.30.
Quest’anno il progetto My Generation si arricchisce di un secondo capitolo. Cosa cambia e cosa viene invece confermato rispetto all’idea del 2018?
Ciò che rimane identico rispetto all’anno scorso è prima di tutto la formula, che ha già funzionato molto bene e che consiste, in un certo senso, nel riprodurre in piccolo, all’interno dell’Accademia, il rapporto regista-attore così come lo si ritroverà una volta fuoriusciti dal contesto accademico. Anche quest’anno quindi gli allievi registi del terzo anno lavorano con gli allievi attori di primo anno. Il motivo di questa scelta è che oggi il regista ha anche il compito di portare l’attore nel proprio mondo e quindi di fare discorso pedagogico. In questo modo, facendo lavorare insieme i giovani attori di primo anno e i registi di terzo con più esperienza alle spalle, si può riprodurre quella certa autorevolezza che viene di solito concessa al regista. La seconda cosa che rimane rispetto all’anno scorso è la drammaturgia originale ispirata a fatti realmente accaduti e anche quest’anno fatti violenti. Il tema dell’anno scorso, infatti, era la violenza. Continuando la nostra ricerca del tragico nel contemporaneo, quindi, abbiamo riproposto il tema portandolo ancora oltre: se l’anno scorso era la violenza dei giovani contro altre generazioni, quest’anno è il serial killer, l’omicida seriale, perché credo che sia un’icona e uno specchio del nostro tempo e del consumismo esistenziale in cui viviamo.
Quindi, a proposito della violenza, nei tre spettacoli essa viene appunto declinata sempre dal punto di vista del serial killer oppure ci sono differenziazioni interne?
Agli allievi registi ho dato innanzitutto la libertà di scegliere il punto di vista da cui intervenire, poi per caso tutti e tre si sono posti dallo sguardo del serial killer, nel senso che tutti e tre hanno scelto un “narratore”, anche se declinato modi molto diversi, che aiuta a entrare nella testa del serial killer. Questo narratore in tutti e tre i casi è appunto il protagonista, cioè l’omicida, e ognuno di essi naturalmente è esistito, è reale.
Quale è stato quindi il progetto globale da cui è partita la differenziazione dei tre spettacoli?
All’inizio ho chiesto di aprire il tema generale del serial killer, per capire che cos’è il serial killer nella mitologia del contemporaneo, che cosa rappresenta e come funziona la sua psiche. Da qui sono scaturite tre scelte molto diverse. Un lavoro è su Haarman, fra i primi serial killer conosciuti negli anni Venti del Novecento. Dalla sua storia Theodore Lessing ha tratto un bellissimo saggio di psichiatria, "Storia di un lupo mannaro", che è uno dei capisaldi della psichiatria contemporanea, molto interessante come punto di partenza. Un altro è l’omicida di Versace (Andrew Cunanan, ndr), che oltre a quest’ultimo uccise altre quattro persone negli anni Novanta e che rappresenta proprio un prodotto della società contemporanea americana, nel tentativo fallimentare di affermare sé stesso, o meglio ancora la propria immagine, tramite la violenza. L’ultimo è uno dei più noti serial killer dei anni Settanta, Edmund Kemper che, nel contesto del neo-femminismo di quegli anni, porta i suoi conflitti con la madre e con il femminile a un livello patologico, rappresentando simbolicamente la frustrazione del maschio moderno, sfociata in questo caso negli omicidi di sei ragazze e della madre stessa.
All’Accademia Silvio D’Amico Lei è docente di combattimento scenico. Considerato il tema della violenza, che sottintende anche fisicità e corporeità, c’è stato modo di includere nei tre spettacoli quest’aspetto performativo specifico del corpo dell’attore? E come si è deciso di declinarlo nelle singole regie?
No, in questo caso no perché in questi tre progetti la violenza è stata sublimata dalla parola. Quando all’inizio ho detto «alla ricerca del tragico nel contemporaneo», quello è sempre il problema del tragico, in cui la violenza è talmente alta, è talmente forte che non può essere mostrata, ma in qualche modo deve essere solo detta, evocata. Qui è successa un po’ la stessa cosa. Tutte e tre le drammaturgie narrano di violenze ma non prevedono la rappresentazione, che poi, sinceramente è un po’ il sogno di ogni insegnante di combattimento scenico, arrivare a non illustrarla la violenza ma solo a raccontarla attraverso una posizione del corpo più che in una manifestazione dell’azione.
Valeria Verbaro, 04/04/2019
Caterina Dazzi racconta "Dopo di me il diluvio", spettacolo sul caso Versace tra violenza, sesso e trap
Caterina Dazzi, allieva regista dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico in attesa di diplomarsi, ci parla del suo spettacolo Dopo di me il diluvio, sull’omicidio di Gianni Versace per mano di Andrew Cunanan. Lo spettacolo fa parte di un ciclo di tre testi sulla violenza tra i giovani, per il progetto My Generation, arrivato al secondo anno e curato dal M. Francesco Manetti.
Per il tuo spettacolo Dopo di me il diluvio ti sei ispirata alla serie tv sull’omicidio Versace?
In realtà no, la serie l’ho vista ma non mi è piaciuta, l’ho trovata un po’ un’“americanata”. È incentrata soprattutto su Gianni Versace mentre Andrew Cunanan, che è un personaggio fantastico, non viene affatto valorizzato. È una produzione commerciale, con grandi attori, non si può pensare di farne un adattamento teatrale. Per lo spettacolo ci siamo basati soprattutto sul libro inchiesta di Maureen Orth, Il caso Versace. Era la scelta più giusta perché non era mediato da produttori, registi, attori, abbiamo potuto lavorarci con più libertà e apertura mentale. L’unica cosa che abbiamo preso in prestito dalla serie è il lavoro non tanto su personaggi ma su tipi, un po’ alla Tarantino. Ma era una scelta quasi obbligata perché lo spettacolo è molto pop.
Cosa ti piace del personaggio di Cunanan?
Mi piace perché compie un percorso verso l’autodistruzione. Dopo aver seminato il terrore con i suoi omicidi si rifugia in una casa galleggiante, braccato dalla polizia, e trascorre i suoi ultimi giorni seguendo gli sviluppi del suo caso in tv. Era ossessionato dai media e dall’immagine di se stesso. Era convinto di essere un privilegiato, destinato a grandi cose, nonostante le umili origini. I suoi unici valori erano il denaro e l’ozio: detestava con tutto se stesso lavorare. Era convinto che tutti un giorno lo avrebbero ricordato, solo perché era esistito. Era ambizioso, ma senza un punto di arrivo.
In questo senso è molto simile ai ragazzi di oggi, e la sua nemesi è proprio Gianni Versace, un uomo omosessuale di umili origini che si è fatto da solo.
Versace in quegli anni era il paradigma dello stile di vita a cui ambiva Cunanan, che era un reietto. Attraverso l’ostentazione della ricchezza, oltre che della sua sessualità, attraverso l’incarnazione ogni volta di un personaggio diverso grazie a un castello di bugie, Cunanan trova un suo punto di arrivo. Lui era un bugiardo patologico, soffriva di quella che gli psicologi chiamano psicotimia fantastica. La sua memoria non era basata sulle immagini, ma sul suono della sua voce. Sul suono delle sue bugie, nel suo caso, che andavano a costruire una realtà inventata che l’ha imprigionato in un circolo vizioso.
Perché le persone intorno a lui lo lasciavano fare?
Perché chi soffre di questa patologia, se confutato, tende a diventare aggressivo. I suoi amici hanno dichiarato inoltre che lui era considerato da tutti il re della festa anche per i suoi racconti fantastici e inventati. Che gusto c’è se la persona più divertente della festa mette il muso?
Secondo te la tendenza di Cunanan a indossare mille maschere precorre il fenomeno dei social network?
Assolutamente. Proprio come oggi, la società in cui ha vissuto Cunanan era basata sui soldi, sull’apparenza e sul concetto del self made man. Noi veniamo dal ventennio berlusconiano, ne sappiamo qualcosa. Il percorso di Cunanan lo paragonerei a quello che sta succedendo ora in Italia con la trap: una corrente musicale figlia della depressione del 2008, fatta da ragazzi che vedono nel denaro l’unica via di fuga e che non hanno valori, tranne la famiglia. Gli altri non esistono, gli altri non sono come me. Proprio come nel caso di Andrew. E quando Cunanan perde la sua famiglia, nel suo caso la comunità gay, si ritrova solo davanti al riflesso emaciato di se stesso.
Secondo te Cunanan odiava Versace perché gli ricordava ciò che lui avrebbe potuto essere?
Non esattamente. Lui lo odiava perché Versace, pur essendo molto simile a lui, era riuscito a imporsi con il duro lavoro, cosa che lui non era disposto a fare. Uccidendo Versace, uccide lo spettro delle sue ambizioni, compiendo quel percorso verso l’autodistruzione di cui parlavamo prima.
Visto che siamo in tema di violenza, parlami del ruolo che ha all’interno del tuo spettacolo.
Il testo lo trovo di per sé molto violento. È un testo di parola, la violenza passa da lì, anche perché siamo in teatro e tutto va mediato. È più un discorso di sensazione, come la sensazione che ti dà il sesso, la sensazione di superiorità sull’altro. È un gioco di potere, come piaceva ad Andrew, che si prostituiva sottomettendo vecchi danarosi. La violenza è il tema se vogliamo dello spettacolo.
Portare in scena un testo così violento ti ha dato una sensazione di catarsi piacevole?
Non parlerei di catarsi, perché quello che abbiamo cercato di fare è portare in scena un ragazzo di 27 anni. Un ragazzo che amava la bella vita, che aveva un q.i. di 147, che aveva tutta la vita davanti e le capacità di fare tutto ciò che voleva, e che ha distrutto tutto. Sulla base di questo, non partirei mai mostrandolo emaciato, distrutto. Abbiamo portato in scena un ragazzo come tanti, che compie un percorso verso l’annientamento. Può essere un processo di consapevolezza, per capire l’oggi, ma non parlerei di catarsi.
Come hai lavorato con gli attori?
Ci siamo concentrati sulle cause, più che sulla violenza in sé. La distruzione di un desiderio, di un ideale, la rabbia e l’invidia. Abbiamo lavorato molto sulla recitazione, anche attraverso improvvisazioni, restando sempre molto concreti. Il testo è molto denso, quindi non serve molta sovrastruttura. Ero partita con l’idea di aggiungere coreografie, immagini, poi ho capito che non servivano e abbiamo lavorato sull’asciugatura, andando alla radice, al cinismo insito nella violenza.
Nel libro di Maureen Orth si dice che Cunanan sovrapponeva alla sua identità quella delle persone con cui entrava in contatto. Quanto di questa caratteristica è assimilabile al lavoro dell’attore?
È tutto. Noi abbiamo improntato il lavoro come una sorta di gioco di specchi, di doppi: un attore è il Cunanan ultimo, quello nella casa galleggiante, gli altri cinque sono sempre lui in momenti diversi e dialogano con ognuna delle cinque vittime, da cui prendono le proprie linee metafisiche e identificative. In questo modo abbiamo creato dei tipi: lo yuppie, l’innamorato, il fanatico religioso, tutti aspetti della personalità di Cunanan che abbiamo volutamente esasperato per raccontare la schizofrenia.
Se dovessi riassumere il tuo spettacolo cosa diresti?
Che è un po’ come l’ultima scena di American Beauty, quando il protagonista vede tutta la sua vita in un istante, ma non è un istante breve, si dilata all’infinito. Andrew è nella casa galleggiante e prima di spararsi rivede tutta la sua vita, dialogando con le varie immagini di sé. È un flashback, un viaggio nel suo cervello.
Giulia Zennaro, 8/4/2019
Dal 13 al 14 aprile al Teatro Studio “Eleonora Duse” va in scena il secondo capitolo di “My Generation"
A distanza di un anno dalla prima riuscita esperienza, gli allievi del III anno del corso di regia dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, si mettono ancora una volta alla prova in un esercizio di stile all’interno del progetto seriale intitolato My Generation.
Il filo conduttore che conduce dal primo al secondo capitolo del progetto è la tematica della violenza: tre esercitazioni di drammaturgia e regia che partono da fatti di cronaca nera, dando vita a tre intensi e attuali spettacoli nei quali la forma classica della tragedia viene trasposta all’interno della società contemporanea.
Il primo spettacolo, “La luna di Fritz”, scritto e diretto da Danilo Capezzani (con l’assistenza alla drammaturgia di Alessio Moneta)., è ispirato alla storia di uno dei primi serial killer del Novecento, dalla cui analisi Doris Lessing ha tratto uno dei capisaldi della psichiatria, “Storia di un lupo mannaro”.
“Totem”, per la regia di Federico Orsetti e la drammaturgia di Matilde D’Accardi, mette in scena la storia di Edmund Kemper che negli anni ‘70 uccise sette donne, tra cui sua madre, portando le conflittualità irrisolte con la figura femminile a un livello patologico.
Nel terzo spettacolo, “Dopo di me il diluvio”, l'allieva regista Caterina Dazzi e l'allievo drammaturgo Marco Fasciana (lo scorso anno regista nel primo capitolo di My Generation) rappresentano l’omicidio di Gianni Versace, mostrando il tentativo fallimentare del suo assassino di affermare la propria immagine attraverso la violenza.
“My Generation - Capitolo 2” non è soltanto un esercizio per riprodurre in piccolo il rapporto tra regista e attore, così come sarà fuori dall’Accademia, ma è una vera e propria sperimentazione teatrale: “mettere in scena la violenza senza mostrarla, come avviene nelle tragedie”, afferma il maestro Manetti, “ponendosi dalla complessa prospettiva dell’assassino, per entrare nella testa di quello che è uno specchio del nostro tempo e del consumismo esistenziale in cui viviamo”.
Alessio Tommasoli
Libro della settimana
-
 "Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…