Nell'innovativo e straordinario "Natale in Casa Cupiello" di Interno 5 i protagonisti sono i pupazzi
NAPOLI – Un fondale che si espande a metà tra il Bosco Verticale milanese, con vie di fuga che saettano in alto, e il Calendario dell'Avvento, con le sue finestrelle tridimensionali, quasi squarci di Lucio Fontana nella tela a prendere luce e respiro, e le sorprese che si affacciano e si affollano di presenze, questo particolarissimo fedelissimo eduardiano “Natale in Casa Cupiello” cum figuris (per la regia di Lello Serao che si è messo in gioco, sperimentando un nuovo linguaggio) è forgiato tra luci e ombre, da apparizioni caustiche ed epifanie carsiche in una continua meraviglia che abbaglia pur nella penombra (le luci catartiche sono di Luigi Biondi e Giuseppe Di Lorenzo), che si infittisce di mistero, dove il testo si nasconde nelle pieghe dei movimenti dei burattini. Tre atti, con conseguenti cambi di scena, per questa perla (prod. Teatri Associati di Napoli, Interno 5) che rifulge di luce propria e riesce a rimettere in circolo, come sangue che pompa nelle vene, il dramma di De Filippo donandogli una veste nuova e suggestiva, curiosa e allettante. E' un presepe (proprio il termine che più ritorna come mantra) perpendicolare e gigantesco (praticamente una seduta spiritica) che  ci mostra tutta l'artigianalità del teatro, le sue assi, i suoi riflessi lignei, le sue carrucole, la sua delicatezza d'ingranaggio, questa manualità infantile di stelle appese e comete apposte, di angelo volante e asinello appoggiato. Sarà il “caso teatrale” di questa stagione, ne siamo certi, per intelligenza e tecnica.
ci mostra tutta l'artigianalità del teatro, le sue assi, i suoi riflessi lignei, le sue carrucole, la sua delicatezza d'ingranaggio, questa manualità infantile di stelle appese e comete apposte, di angelo volante e asinello appoggiato. Sarà il “caso teatrale” di questa stagione, ne siamo certi, per intelligenza e tecnica.
Si sente un ribollire di tensione emotiva e magma tattile (il Teatro Bellini ha fatto bene ad impostare una lunga tenitura, tre settimane, per questo piccolo capolavoro che verrà ricordato e che tutti gli amanti del teatro dovrebbero avere la possibilità, e la fortuna, di poter vedere) che tutto trasforma in questa sorta di laboratorio di falegnameria. E il parallelo nasce spontaneo con Geppetto (Lucariello) e Pinocchio (Tommasiello) tra trucioli, marionette e ciocchi di legno da intagliare, perfezionare, limare per questo grande presepe che è l'esistenza. E, se vogliamo forzare l'assonanza con Collodi, qui possiamo vedere, al contrario, come dalla carne, il capofamiglia Luca si faccia di legno perdendo la sua fisionomia terrena  e trasfigurandosi in una delle sue statuette tanto amate. Lucariello è un enorme Luca Saccoia davvero toccato dalla grazia del palcoscenico che, generosissimo e sempre in movimento, dà voce ai vari personaggi che si affacciano governati dai neri movimentat(t)tori (tre ragazzi, provenienti da un laboratorio di Scampia, e tre ragazze), cambiando il tono e l'inflessione. Se nel primo atto (le scene sono di Tiziano Fario) è appunto l'attore napoletano a prestare le corde vocali agli altri ruoli, nel secondo, attorno a questa tavola bassa da fiaba, trova il dialogo proprio con i manovratori per infine, nel terzo, scindersi dal suo personaggio e a specchio e farsi doppio, come l'anima che lascia il corpo, e aggirarsi attorno a quel defunto impersonando i personaggi-satelliti che gli hanno ruotato intorno fin dall'inizio senza capirne l'importanza, dandolo per scontato, non considerandolo abbastanza, certamente non amandolo.
e trasfigurandosi in una delle sue statuette tanto amate. Lucariello è un enorme Luca Saccoia davvero toccato dalla grazia del palcoscenico che, generosissimo e sempre in movimento, dà voce ai vari personaggi che si affacciano governati dai neri movimentat(t)tori (tre ragazzi, provenienti da un laboratorio di Scampia, e tre ragazze), cambiando il tono e l'inflessione. Se nel primo atto (le scene sono di Tiziano Fario) è appunto l'attore napoletano a prestare le corde vocali agli altri ruoli, nel secondo, attorno a questa tavola bassa da fiaba, trova il dialogo proprio con i manovratori per infine, nel terzo, scindersi dal suo personaggio e a specchio e farsi doppio, come l'anima che lascia il corpo, e aggirarsi attorno a quel defunto impersonando i personaggi-satelliti che gli hanno ruotato intorno fin dall'inizio senza capirne l'importanza, dandolo per scontato, non considerandolo abbastanza, certamente non amandolo.
E' sia una guerra generazionale NCC (ancora attualissima e contemporanea) tra un padre che non riesce a passare al figlio le proprie passioni né le regole di vita e di comportamento e soccombe davanti alla prole scapestrata (appunto pinocchiesca) che non riconosce la sua autorità e che di lui si fa beffe snobbandolo, deridendolo; mentre il padre vorrebbe soltanto un po' di vicinanza e solidarietà, chiede amore e domanda insistentemente di essere stimato attraverso la costruzione del presepe, e vorrebbe soltanto far vedere quanto vale ma per i suoi congiunti non conta né merita niente, e da parte del suo ragazzo riceve soltanto rifiuti e anzi pesanti negazioni e contrasti che lo fanno sentire inutile, vecchio, sorpassato, incompreso quando avrebbe voluto solamente essere capito e accolto e ascoltato, abbracciato e non allontanato con una freddezza tagliente che incassa anche se  gli fa malissimo. Il presepe è il suo recinto e cortile, il suo hobby e fiore all'occhiello, il suo orgoglio (la cosa che gli è riuscita meglio) e la sua fuga dalla realtà, un posto
gli fa malissimo. Il presepe è il suo recinto e cortile, il suo hobby e fiore all'occhiello, il suo orgoglio (la cosa che gli è riuscita meglio) e la sua fuga dalla realtà, un posto  dove tutti i pezzi vanno al loro posto e dove ogni staticità è fissa e decisa dal suo deus ex machina, dove i punti di riferimento sono comprensibili e standardizzati, dove ogni mossa è controllabile non come la sua vita (dileggiata, per gli altri componenti della famiglia è irrimediabilmente un perdente) sempre tra l'incudine e il martello di un figlio scansafatiche, di una moglie perennemente in contrasto e insoddisfatta, di un fratello brontolone, di una figlia frustrata. La felicità non abita in casa Cupiello che già nella sua radice contiene il cupo, il fioco, il fosco, il livido, il buio. Se qualcuno nel corso della vita vi chiederà più volte con perseveranza “Te piace o' presepe?” (in definitiva è una richiesta d'amore; qualunque oggetto ci sia al posto della capannuccia e dei re Magi) forse ci tiene così tanto che aspetta soltanto un cenno per sentirsi finalmente accettato per quello che è invece che per quello che avrebbe potuto o dovuto essere. “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre”.
dove tutti i pezzi vanno al loro posto e dove ogni staticità è fissa e decisa dal suo deus ex machina, dove i punti di riferimento sono comprensibili e standardizzati, dove ogni mossa è controllabile non come la sua vita (dileggiata, per gli altri componenti della famiglia è irrimediabilmente un perdente) sempre tra l'incudine e il martello di un figlio scansafatiche, di una moglie perennemente in contrasto e insoddisfatta, di un fratello brontolone, di una figlia frustrata. La felicità non abita in casa Cupiello che già nella sua radice contiene il cupo, il fioco, il fosco, il livido, il buio. Se qualcuno nel corso della vita vi chiederà più volte con perseveranza “Te piace o' presepe?” (in definitiva è una richiesta d'amore; qualunque oggetto ci sia al posto della capannuccia e dei re Magi) forse ci tiene così tanto che aspetta soltanto un cenno per sentirsi finalmente accettato per quello che è invece che per quello che avrebbe potuto o dovuto essere. “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre”.
Tommaso Chimenti 21/12/2022
Foto: Anna Camerlingo
Black and White: anima azera per il teatro finlandese
IMATRA (FINLANDIA) – Dall'incrocio tra Azerbajan ed Estonia nasce ad inizio anni 2000 il “Black and White Festival” a Imatra, cittadina finlandese di trentamila abitanti a quasi 300 chilometri ad est rispetto ad Helsinki e più vicina a San Pietroburgo di quanto non lo sia alla capitale finnica. Il confine dopotutto, adesso chiuso causa pandemia, si trova a sette chilometri. Il border lo puoi sentire, è palpabile. La Grande Russia degli Zar è lì ad un soffio. Da Baku infatti è arrivato, venticinque anni fa il direttore artistico Kamran Shahmardan, regista teatrale e cinematografico  (ha studiato Cinema), estone invece è la moglie Katri Latt, insegnante e vera anima del festival. Se lo scorso anno la rassegna saltò, quest'anno si è comunque deciso di organizzarla, con artisti finlandesi ed estoni, per un'edizione che è stata ribattezzata 17 e mezzo (28-31 luglio; il tema di quest'anno è: “Teatro in Korona”). Nel tragitto in treno da Tikkurila, la prima fermata della metro in superficie dopo l'aeroporto, ad Imatra si vedono solo panorami di conifere e spazi aperti. Verde e ampiezza, lontananza e verticalità. L'estate o non è arrivata o è già sparita. Il tempo è variabile: si passa dal caldo torrido, con annessi milioni di fastidiosi mosquitos, ad un vento che sa di tramontana misto a bora, uno scroscio di pioggia e freddo da giacca per poi tornare all'inizio del ciclo. Anche il treno (che si chiama Pendolino e inevitabilmente fa venire alla mente Cafù, terzino destro brasiliano ai tempi della Roma) è verde. L'acqua è potabile dappertutto e gratuita con le tante fontanelle sparse. Ogni tanto in mezzo a queste distese, nel centro del nulla, esplode un'industria, una fabbrica, una ditta, ciminiere sbuffanti, cemento accatastato. E fa ancora più rumore questa visione che stride. La visione attorno ai binari non muta per decine, centinaia di chilometri. Verde a destra, verde a sinistra.
(ha studiato Cinema), estone invece è la moglie Katri Latt, insegnante e vera anima del festival. Se lo scorso anno la rassegna saltò, quest'anno si è comunque deciso di organizzarla, con artisti finlandesi ed estoni, per un'edizione che è stata ribattezzata 17 e mezzo (28-31 luglio; il tema di quest'anno è: “Teatro in Korona”). Nel tragitto in treno da Tikkurila, la prima fermata della metro in superficie dopo l'aeroporto, ad Imatra si vedono solo panorami di conifere e spazi aperti. Verde e ampiezza, lontananza e verticalità. L'estate o non è arrivata o è già sparita. Il tempo è variabile: si passa dal caldo torrido, con annessi milioni di fastidiosi mosquitos, ad un vento che sa di tramontana misto a bora, uno scroscio di pioggia e freddo da giacca per poi tornare all'inizio del ciclo. Anche il treno (che si chiama Pendolino e inevitabilmente fa venire alla mente Cafù, terzino destro brasiliano ai tempi della Roma) è verde. L'acqua è potabile dappertutto e gratuita con le tante fontanelle sparse. Ogni tanto in mezzo a queste distese, nel centro del nulla, esplode un'industria, una fabbrica, una ditta, ciminiere sbuffanti, cemento accatastato. E fa ancora più rumore questa visione che stride. La visione attorno ai binari non muta per decine, centinaia di chilometri. Verde a destra, verde a sinistra.
Ad Imatra era importante la lavorazione del legno e la produzione di energia idroelettrica grazie ad una diga che nel periodo estivo diventa attrazione con l'apertura della stessa (per un quarto d'ora alle 18) e musica classica e schizzi e spruzzi e il ponte bloccato da due bus per permettere alla folla di fotografare gli sbuffi d'acqua che riempiono il torrente secco di rocce appuntite che spuntano fino a ricoprirle di onde. La potenza della Natura. Accanto alla diga ci intravede un piccolo cimitero sotto un boschetto: sono tutti ragazzi morti nel 1940, durante la Guerra d'Inverno il conflitto tra Finlandia e Russia, e ogni lapide a terra  (ci ha ricordato il Cimitero Militare Germanico della Futa a Firenzuola) ha la sua pianta accanto dai fiori rossi, quasi gerani in un'atmosfera finalmente pacificata e acquietata. La diga, l'albergo-castello costruito nei primi anni del Novecento, la strana e bianca Chiesa delle Tre Croci dell'architetto Alvar Aalto e il Lago Saimaa sono i punti focali e nodali della cittadina che è ricordata anche per un particolare che alle latitudini mediterranee può sembrare un'inezia ma che qua in Scandinavia invece è una cosa molto seria. Qui, nell'Ottocento, è nato l'inventore di un congegno che serviva per eliminare le interiora delle aringhe. Il cielo è torvo, tutto intorno è piatto, come un lungo campo cinematografico. Da maggio a luglio il fenomeno delle Notti bianche fa sì che ci siano soltanto due ore di buio, così come in inverno il nero avvolge la città mentre il sole non riesce a filtrare che per poche ore.
(ci ha ricordato il Cimitero Militare Germanico della Futa a Firenzuola) ha la sua pianta accanto dai fiori rossi, quasi gerani in un'atmosfera finalmente pacificata e acquietata. La diga, l'albergo-castello costruito nei primi anni del Novecento, la strana e bianca Chiesa delle Tre Croci dell'architetto Alvar Aalto e il Lago Saimaa sono i punti focali e nodali della cittadina che è ricordata anche per un particolare che alle latitudini mediterranee può sembrare un'inezia ma che qua in Scandinavia invece è una cosa molto seria. Qui, nell'Ottocento, è nato l'inventore di un congegno che serviva per eliminare le interiora delle aringhe. Il cielo è torvo, tutto intorno è piatto, come un lungo campo cinematografico. Da maggio a luglio il fenomeno delle Notti bianche fa sì che ci siano soltanto due ore di buio, così come in inverno il nero avvolge la città mentre il sole non riesce a filtrare che per poche ore.
“Black and White” (fino ad oggi ha ospitato 250 spettacoli provenienti da 46 Paesi nel mondo), il nero e il bianco come il bene e il male cabalistico, come la scacchiera perché “il teatro nasce dallo scontro, si alimenta dal conflitto” dice il vulcanico ed entusiasta Shahmardan (nel 2017 è stato nominato “Artista finlandese dell'anno”, è innamorato di Fellini, sarebbe andato molto d'accordo con Carlo Monni) che un po' somiglia a Danny DeVito (lo confessa lui stesso), un po' al Maestro di casa nostra Giancarlo Cauteruccio, un po' a Kusturica. Quattro giorni di teatro, performance e danza, rigorosamente all'aperto (anche se qui nessuno porta la mascherina né fuori né al chiuso, dopotutto i morti sono stati, ad oggi, 985 sui 5 milioni di abitanti del Paese) e rigorosamente gratuiti. Festival “gemello” del B&W è il “MAP” di Baku. Lo stemma della città è composto da tre saette bianche (icona dell'energia) con gli estremi gialli in campo rosso. Imatra è anche il titolo di un film-documentario (2007) di Corso Salani, attore e regista fiorentino scomparso nel 2010. Due le lingue ufficiali in Finlandia (che è fuori dalla NATO), il finlandese e lo svedese. La Svezia ha occupato e dominato queste terre per sei secoli, prima che, all'inizio dell'Ottocento, passasse sotto l'Impero russo prima di trovare l'indipendenza nel fatidico 1917. La domanda di fondo è: quale può essere l'identità di un Paese schiacciato tra i suoi due dominatori dell'ultimo millennio? Se ampliamo lo sguardo alla Scandinavia, la Finlandia, a differenza di Norvegia, Svezia e Danimarca, è l'unica a non avere i regnanti. Alcune teorie (il saggio “Omero nel Baltico” di Felice Vinci) collocano qui l'Iliade e l'Odissea e Troia corrisponderebbe a Toija vicino a Turku. In Finlandia ci sono 188.000 laghi (le acqua interne corrispondono ad un decimo delle superficie totale) e 180.000 isole, mentre per tre quarti è boschivo.
un po' a Kusturica. Quattro giorni di teatro, performance e danza, rigorosamente all'aperto (anche se qui nessuno porta la mascherina né fuori né al chiuso, dopotutto i morti sono stati, ad oggi, 985 sui 5 milioni di abitanti del Paese) e rigorosamente gratuiti. Festival “gemello” del B&W è il “MAP” di Baku. Lo stemma della città è composto da tre saette bianche (icona dell'energia) con gli estremi gialli in campo rosso. Imatra è anche il titolo di un film-documentario (2007) di Corso Salani, attore e regista fiorentino scomparso nel 2010. Due le lingue ufficiali in Finlandia (che è fuori dalla NATO), il finlandese e lo svedese. La Svezia ha occupato e dominato queste terre per sei secoli, prima che, all'inizio dell'Ottocento, passasse sotto l'Impero russo prima di trovare l'indipendenza nel fatidico 1917. La domanda di fondo è: quale può essere l'identità di un Paese schiacciato tra i suoi due dominatori dell'ultimo millennio? Se ampliamo lo sguardo alla Scandinavia, la Finlandia, a differenza di Norvegia, Svezia e Danimarca, è l'unica a non avere i regnanti. Alcune teorie (il saggio “Omero nel Baltico” di Felice Vinci) collocano qui l'Iliade e l'Odissea e Troia corrisponderebbe a Toija vicino a Turku. In Finlandia ci sono 188.000 laghi (le acqua interne corrispondono ad un decimo delle superficie totale) e 180.000 isole, mentre per tre quarti è boschivo.
Nel 2018, da quanto emerge dai risultati dell'annuale “World Happiness Report”, la Finlandia era stata decretata come “Il Paese più felice in cui vivere” (l'Italia era 47esima) dopo sondaggi con cittadini e immigrati sulla base di reddito, istruzione, salute, corruzione, razzismo, libertà, inclusione, fiducia nelle istituzioni, sicurezza. Finlandia in finlandese si dice “Suomi”. Qui c'è una sauna ogni due abitanti per un totale di circa tre milioni di saune in tutto il Paese. La sauna (mi viene in mente “Il Giardino delle Esperidi”, festival performativo lombardo a Campsirago diretto da Michele Losi, abituato alle rassegne nordiche, che costruirà una sauna nella nuova foresteria) è uno stile di vita, oltre che di benessere; per conoscersi, per parlare, per fare riunioni di lavoro è il miglior approccio. La sauna qui al B&W è parte integrante del festival, del dopo festival: uno chalet di montagna in legno proprio sulle rive del lago (dove fare nuotate ghiacciate notturne) con una sauna interna e la jacuzzi fuori e l'amichevole vodka che scioglie i rapporti e rende sempre il clima frizzante insieme all'immancabile salmone e alle profumate aringhe marinate.
Tra gli  spettacoli ai quali abbiamo assistito due sono stati quelli che più hanno colpito la nostra immaginazione. In primis “Relazione” del duo di Helsinki Kate & Pasi, formatisi nel Cirque Eloize, acrobati circensi che sono riusciti a sviluppare una drammaturgia profonda, potente e impegnata, a tratti commovente sul che cosa significa e che cosa serva per costruire una relazione di coppia. Sulla scena Kate, 50 kg, e Pasi, 100, compagni di palcoscenico ma anche di vita, fanno evoluzioni, si scambiano, si fronteggiano, guerreggiano. E' una guerriglia per avere voce in capitolo, per avere l'ultima parola, nel tenere costantemente testa all'altro senza cedere. Al centro una poltrona che è salotto, che è casa, che è famiglia. Lui legge imperterrito come se lei non esistesse. Lei tenta in tutti i modi, come un gatto che si struscia per avere attenzione ed essere considerato, di incuriosirlo, interromperlo senza successo, distrarlo dalle sue occupazioni, portarlo vicino alle sue mani. Lei gli danza sopra, intorno, addosso sul petto, sulle gambe, aggrappata alle caviglie, alle ginocchia, sui polpacci, sugli stinchi, sui piedi, addirittura sulla testa appoggiata sulla fronte come se non riuscisse a vivere senza di lui. Elemosina il suo amore, le sue mani, il suo tocc
spettacoli ai quali abbiamo assistito due sono stati quelli che più hanno colpito la nostra immaginazione. In primis “Relazione” del duo di Helsinki Kate & Pasi, formatisi nel Cirque Eloize, acrobati circensi che sono riusciti a sviluppare una drammaturgia profonda, potente e impegnata, a tratti commovente sul che cosa significa e che cosa serva per costruire una relazione di coppia. Sulla scena Kate, 50 kg, e Pasi, 100, compagni di palcoscenico ma anche di vita, fanno evoluzioni, si scambiano, si fronteggiano, guerreggiano. E' una guerriglia per avere voce in capitolo, per avere l'ultima parola, nel tenere costantemente testa all'altro senza cedere. Al centro una poltrona che è salotto, che è casa, che è famiglia. Lui legge imperterrito come se lei non esistesse. Lei tenta in tutti i modi, come un gatto che si struscia per avere attenzione ed essere considerato, di incuriosirlo, interromperlo senza successo, distrarlo dalle sue occupazioni, portarlo vicino alle sue mani. Lei gli danza sopra, intorno, addosso sul petto, sulle gambe, aggrappata alle caviglie, alle ginocchia, sui polpacci, sugli stinchi, sui piedi, addirittura sulla testa appoggiata sulla fronte come se non riuscisse a vivere senza di lui. Elemosina il suo amore, le sue mani, il suo tocc o e tatto ma lui continua a leggere imperturbabile, niente riesce a smuoverlo dalla sua concentrazione. Appena lui cede qualche centimetro e sembra che l'armonia sia entrata in quella abitazione, cominciando a leggere insieme, lei, memore del precedente trattamento ricevuto, lo scalza, lo spodesta, lo allontana, lo fa cadere dalla sua poltrona-trono, facendo cadere il suo machismo, la sua arroganza e tracotanza maschilista. Adesso i ruoli sono ribaltati e lottano per ottenere l'egemonia e supremazia di quello scranno. Kate & Pasi (www.kate-pasi.com) ci insegnano che la “Relazione” di coppia è un gioco di scambi, di incroci, di spostamenti, di scollamenti, di equilibri e assestamenti, di posizioni e di prese di posizioni, di flessibilità e rigidità, di slanci, di tentativi per non cadere, di rincorse, di play, di aggiustamenti, di avanzamenti e ritirate, di ritorni e rinculi, di paure, di scuse, di perché, di abbracci.
o e tatto ma lui continua a leggere imperturbabile, niente riesce a smuoverlo dalla sua concentrazione. Appena lui cede qualche centimetro e sembra che l'armonia sia entrata in quella abitazione, cominciando a leggere insieme, lei, memore del precedente trattamento ricevuto, lo scalza, lo spodesta, lo allontana, lo fa cadere dalla sua poltrona-trono, facendo cadere il suo machismo, la sua arroganza e tracotanza maschilista. Adesso i ruoli sono ribaltati e lottano per ottenere l'egemonia e supremazia di quello scranno. Kate & Pasi (www.kate-pasi.com) ci insegnano che la “Relazione” di coppia è un gioco di scambi, di incroci, di spostamenti, di scollamenti, di equilibri e assestamenti, di posizioni e di prese di posizioni, di flessibilità e rigidità, di slanci, di tentativi per non cadere, di rincorse, di play, di aggiustamenti, di avanzamenti e ritirate, di ritorni e rinculi, di paure, di scuse, di perché, di abbracci.
A chiudere un altro duo stavolta in nero avvolti dalla musica onirica, sacerdoti officianti di riti pagani tra candele e bastoni infuocati. “Flaming Language” della coppia Tulinaytos sono schegge di fuoco che roteano in raggi, in cerchi, sono sciamani, sono dervisci ipnotizzanti che si muovono su coreografie rutilanti dal sapore millenario e ancestrale, antico. Le fiamme si cercano e si allontanano, si rifiutano e si incontrano, si muovono come remi pagaiando per illuminare l'oscurità tra grazia estrema e dinamismo cosmico. Come un mantra, il mantra di Imatra.
Tommaso Chimenti 06/08/2021
Coppelia Theatre: la magia delle marionette da polso dal cuore della Russia
SAN CASCIANO DEI BAGNI – Le avevamo lasciate immerse nei chiaroscuri e nelle ombre magiche e trasognanti che tratteggiavano tremolanti la figura di Azzurra di Montebello nel loro “Born ghost” che avevamo visto all'interno della rassegna “Forever Young” alla Corte Ospitale. Sta tutto dentro al loro nome, un nome fatto di nodi e snodi, di possibilità e deviazioni liturgiche e dialettiche: Coppelia Theatre, all'anagrafe la costruttrice di pupazzi, scenografa e visual designer Jlenia Biffi e l'attrice e autrice Mariasole Brusa. Coppelia rievocando il personaggio, inquietante e terribile, protagonista dell'“Uomo della sabbia” di E.T.A. Hoffmann dove il sogno, l'incubo e l'automa si fondono in una marmellata inscindibile di sensazioni, ritorni, ambientazioni dark e simboliste. Una compagnia  che ha una decina d'anni nata dopo che la Biffi aveva trascorso quattro mesi in Siberia, precisamente nella città di Tomsk, geograficamente sospesa tra Kazakistan e Mongolia, apprendendo le tecniche delle marionette da polso dal Maestro Vladimir Zakharov, burattinaio che ha miscelato ingegneria e teatro di figura, purtroppo deceduto tragicamente tentando di salvare i suoi burattini da un incendio che aveva colpito il suo teatro, il 2KY Theater, e laboratorio dove li forgiava e dove prendevano vita: un'esistenza epica, un finale drammaticamente teatrale.
che ha una decina d'anni nata dopo che la Biffi aveva trascorso quattro mesi in Siberia, precisamente nella città di Tomsk, geograficamente sospesa tra Kazakistan e Mongolia, apprendendo le tecniche delle marionette da polso dal Maestro Vladimir Zakharov, burattinaio che ha miscelato ingegneria e teatro di figura, purtroppo deceduto tragicamente tentando di salvare i suoi burattini da un incendio che aveva colpito il suo teatro, il 2KY Theater, e laboratorio dove li forgiava e dove prendevano vita: un'esistenza epica, un finale drammaticamente teatrale.
La tecnica delle marionette da polso è complessa e affascinante perché riesce a coniugare l'ingegneria robotica alla scena, la biomeccanica all'umanità, la scienza al tatto, la macchina ai sentimenti umani: delle protesi al polso raccoglie i movimenti del manovratore che ha impegnate, con  grande sforzo e concentrazione, tutti i muscoli, tutte le dita delle mani. Zero elettronica ma soltanto piccoli impercettibili e lievi tocchi, soffi con i polpastrelli che muovono otto binari di fili, che riportano al personaggio, alla marionetta, tutta la sensibilità dell'attore: il mignolo movimenta gli occhi, l'anulare l'apertura della bocca, l'indice e il medio le gambe, il pollice la chiusura delle palpebre e il movimento laterale della testa. I gesti così diventano fluidi, non scattosi né meccanici, realistici, vivi “perché raccolgono la “sporcizia” del manipolatore” donando quella patina di imperfezione che rende l'uomo così dissimile dal robot. Due gli elementi centrali: la sensazione di vita e quella del peso, della gravità, che riescono ad unire e fondere la poesia con la tecnologia, rendendo la seconda più terrena e soffice e restituendo al pubblico un burattino non stereotipato. Il risultato è la fiducia che l'impatto con queste piccole macchine con il cuore riesce a far sbocciare negli spettatori di ogni età. Per questo il lavoro attoriale, fatto di complessità tecnica ma anche di versatilità scenica, è di fondamentale importanza. Coppelia si può tradurre nel motto della compagnia: Arte e Tecnologia.
grande sforzo e concentrazione, tutti i muscoli, tutte le dita delle mani. Zero elettronica ma soltanto piccoli impercettibili e lievi tocchi, soffi con i polpastrelli che muovono otto binari di fili, che riportano al personaggio, alla marionetta, tutta la sensibilità dell'attore: il mignolo movimenta gli occhi, l'anulare l'apertura della bocca, l'indice e il medio le gambe, il pollice la chiusura delle palpebre e il movimento laterale della testa. I gesti così diventano fluidi, non scattosi né meccanici, realistici, vivi “perché raccolgono la “sporcizia” del manipolatore” donando quella patina di imperfezione che rende l'uomo così dissimile dal robot. Due gli elementi centrali: la sensazione di vita e quella del peso, della gravità, che riescono ad unire e fondere la poesia con la tecnologia, rendendo la seconda più terrena e soffice e restituendo al pubblico un burattino non stereotipato. Il risultato è la fiducia che l'impatto con queste piccole macchine con il cuore riesce a far sbocciare negli spettatori di ogni età. Per questo il lavoro attoriale, fatto di complessità tecnica ma anche di versatilità scenica, è di fondamentale importanza. Coppelia si può tradurre nel motto della compagnia: Arte e Tecnologia.
In questi anni Coppelia Theatre è stata ospite in prestigiose rassegne internazionali come Avignone Off o il “Babkarka Bystrica” in Slovacchia, il “Festival Valise” a Lomza in Polonia, il “Bristol Festival of Puppetry” in Gran Bretagna, il “Festival Asile 404” a Basilea, il “Zone Puppet  Theatre Festival” proprio a Tomsk in Russia da dove tutto è partito, il “Festival der Gelegenheiten” a Berlino. Oltre che, tra i tanti italiani, citiamo “Mirabilia” o “Arrivano dal mare”, “VolterraTeatro”, “Mercantia” o “Kilowatt”. Ed anche i premi e i riconoscimenti sono arrivati copiosi, ottenuti con le loro produzioni, “Trucioli”, che ha raggiunto le 450 rappresentazioni e che abbiamo avuto modo di poter seguire all'interno del loro laboratorio in una replica speciale, “Star Hunter”, “Born Ghost”, che ha vinto il Bando ERT e finalista al “Forever Young”, “Chimera/Sirene” che avrà la voce di Michele Di Mauro che leggerà poesie di Dino Campana che ci condurrà dentro l'ontogenesi di una donna pesce dalla nascita fino alla sua morte, vincitore del bando internazionale “Giovani artisti per Dante” promosso da Ravenna Festival, “Witchy Things” sull'identità e gli stereotipi di genere, finalista Premio Scenario Infanzia '20 e vincitore del “Premio Internazionale Narrare la Parità”, o con “The Creature”.
Theatre Festival” proprio a Tomsk in Russia da dove tutto è partito, il “Festival der Gelegenheiten” a Berlino. Oltre che, tra i tanti italiani, citiamo “Mirabilia” o “Arrivano dal mare”, “VolterraTeatro”, “Mercantia” o “Kilowatt”. Ed anche i premi e i riconoscimenti sono arrivati copiosi, ottenuti con le loro produzioni, “Trucioli”, che ha raggiunto le 450 rappresentazioni e che abbiamo avuto modo di poter seguire all'interno del loro laboratorio in una replica speciale, “Star Hunter”, “Born Ghost”, che ha vinto il Bando ERT e finalista al “Forever Young”, “Chimera/Sirene” che avrà la voce di Michele Di Mauro che leggerà poesie di Dino Campana che ci condurrà dentro l'ontogenesi di una donna pesce dalla nascita fino alla sua morte, vincitore del bando internazionale “Giovani artisti per Dante” promosso da Ravenna Festival, “Witchy Things” sull'identità e gli stereotipi di genere, finalista Premio Scenario Infanzia '20 e vincitore del “Premio Internazionale Narrare la Parità”, o con “The Creature”.
L'artigianato e la creazione sta alla base di ogni loro progetto: meccanismi e ingranaggi, ali giganti o teste di mostri, trampoli o maschere in 3D, per  una gestazione che nasce da un'intuizione passa alle mani per poi tradursi in oggetti che, toccandoli, si ha la netta sensazione che abbiano un'anima, un trasporto, un'alchimia profonda, pensata e solida. Dalla piece “Clockwork Metaphisic”, metafisica a orologeria, con l'attrice Ilaria Drago e la regia di Marta Cuscunà, basato sulla pittrice spagnola surrealista Remedios Varo, sono nate due “costole” per spazi non teatrali, piccoli cammeo: “Trucioli” e “La cacciatrice di astri” di dieci minuti l'uno. L'idea è quella del teatro da camera di Guido Ceronetti, per creare luoghi dell'anima, intimi, per poche persone vicine dentro allo stesso sogno colorato e fantastico nella sua accezione più alta. “Trucioli” è ispirato all'opera “La creazione degli uccelli”, quadro della metà degli anni '50 del secolo scorso della Varo che, non a caso, era figlia di un ingegnere idraulico, vissuta tra
una gestazione che nasce da un'intuizione passa alle mani per poi tradursi in oggetti che, toccandoli, si ha la netta sensazione che abbiano un'anima, un trasporto, un'alchimia profonda, pensata e solida. Dalla piece “Clockwork Metaphisic”, metafisica a orologeria, con l'attrice Ilaria Drago e la regia di Marta Cuscunà, basato sulla pittrice spagnola surrealista Remedios Varo, sono nate due “costole” per spazi non teatrali, piccoli cammeo: “Trucioli” e “La cacciatrice di astri” di dieci minuti l'uno. L'idea è quella del teatro da camera di Guido Ceronetti, per creare luoghi dell'anima, intimi, per poche persone vicine dentro allo stesso sogno colorato e fantastico nella sua accezione più alta. “Trucioli” è ispirato all'opera “La creazione degli uccelli”, quadro della metà degli anni '50 del secolo scorso della Varo che, non a caso, era figlia di un ingegnere idraulico, vissuta tra  la Parigi di Breton, Barcellona e Città del Messico dove, era inevitabile e sarebbe stato impossibile il contrario, entrò in contatto con Frida Kahlo. Il quadro della pittrice spagnola, che si rifaceva a Bosch, vede una donna che macina stelle per imboccare e alimentare una Luna in gabbia condizione dell'autolimitazione della donna da una parte e dall'altra la donna di casa che ripete sempre gli stessi gesti.
la Parigi di Breton, Barcellona e Città del Messico dove, era inevitabile e sarebbe stato impossibile il contrario, entrò in contatto con Frida Kahlo. Il quadro della pittrice spagnola, che si rifaceva a Bosch, vede una donna che macina stelle per imboccare e alimentare una Luna in gabbia condizione dell'autolimitazione della donna da una parte e dall'altra la donna di casa che ripete sempre gli stessi gesti.
Un teatro nel teatro perché il piccolo impianto nel quale si svolge la vicenda è un teatrino da wunderkammer, capolavoro metafisico e patafisico, un sipario a metà tra una bocca di squalo e una volta celeste stellata dove al suo interno, immersa da mini luci coperte da conchiglie, una creatura ancestrale ibrida tra donna e civetta si muove con disinvoltura dipingendo, creando e distruggendo la propria arte. Usa il pennello come se fosse un plettro e ha appeso al collo un violino e, disegnando, macera e macina miscelandoli, i colori ciano, magenta e giallo, per produrre la sua personale creazione del mondo. In miniatura è ricreato uno studio, un laboratorio fatto di tavoli ed inchiostro, di orologi e calamaio, di nuvole e occhi che si rincorrono, un opificio che tutto trasforma, tra fumi e fiamme in una magia senza età che colpisce e cattura la curiosità. I movimenti rapiscono e si perde il senso del tempo, ci si concentra su un particolare che un altro ci illumina e ci abbaglia, ci porta lontano nel tempo, quello interiore personale anagrafico, come quello dell'Uomo con la maiuscola che, tra questi piccoli grandi colpi di genio, ci fanno sciogliere e liquefare tornando all'essenza di ciò che eravamo, di quello che, sotto le sovrastrutture ancora siamo: corpi magnetici in grado di meravigliarci.
violino e, disegnando, macera e macina miscelandoli, i colori ciano, magenta e giallo, per produrre la sua personale creazione del mondo. In miniatura è ricreato uno studio, un laboratorio fatto di tavoli ed inchiostro, di orologi e calamaio, di nuvole e occhi che si rincorrono, un opificio che tutto trasforma, tra fumi e fiamme in una magia senza età che colpisce e cattura la curiosità. I movimenti rapiscono e si perde il senso del tempo, ci si concentra su un particolare che un altro ci illumina e ci abbaglia, ci porta lontano nel tempo, quello interiore personale anagrafico, come quello dell'Uomo con la maiuscola che, tra questi piccoli grandi colpi di genio, ci fanno sciogliere e liquefare tornando all'essenza di ciò che eravamo, di quello che, sotto le sovrastrutture ancora siamo: corpi magnetici in grado di meravigliarci.
Tommaso Chimenti 12/03/2021
Il Pierrot Festival di Stara Zagora: il grande teatro di figura ammalia l'Europa
Il Pierrot Festival di Stara Zagora, in Bulgaria (l’undicesima edizione è stata in scena dal 24 al 29 settembre) è stato una scoperta e una conferma al tempo stesso. Una scoperta perché in questa cittadina, la sesta in Bulgaria per numero di abitanti, in cui le tracce dell’Impero Romano sono fulcro e attrazione (splendidi i resti dell’anfiteatro e della antica strada), la celebre rassegna di teatro di figura per adulti, organizzata e prodotta dallo State Puppet Theatre, è un motore trainante per lo sviluppo della cultura bulgara dentro e fuori il paese: oltre venti spettacoli (di cui dieci in concorso), tre teatri coinvolti, altrettanti spazi usati nel centro della città, performance interattive, concerti, mostre, presentazioni di libri e studi, sale sempre piene, anche di domenica mattina, e animate soprattutto dai giovani. Tanti giovani, tantissimi, fuori e dentro dal teatro, che si occupano di teatro a 360°, giovani attori, giovani autori, giovani registi, giovani critici. Il teatro, in questa parte dell’Europa, fa parte di una genetica che si tramanda di generazione in generazione con ferrea volontà e disciplina.
Una conferma, invece, per quanto riguarda il teatro di figura tout court, genere che si dimostra un terreno fertile e di incontro per un pubblico adulto, un terreno creativo, composto da tanti tasselli diversi che attingono alle varie forme teatrali. Teatro di puppets, certo, ma che non si limita solo alla gestualità della marionetta o del burattino, alla manualità dell’attore o al sapiente uso della maschera ma anche, e soprattutto, teatro di parola, teatro di narrazione, documentaristico, drammatico, distopico.
Il Pierrot Festival ha offerto una visione a 360° del teatro di figura e non solo con produzioni bulgare e internazionali (italiane, statunitensi, giapponesi, polacche, serbe) che ci hanno colpito per la differenziazione delle pièce e per l’alto livello qualitativo che abbiamo riscontrato in tutta la settimana di programmazione.
Nel nostro personale percorso all’interno della rassegna (dove eravamo anche coinvolti nella giuria internazionale che ha assegnato i vari premi previsti, sei in totale sui sette, dal momento che quello per la “Sperimentazione e nuove forme” non è stato conferito) vi segnaliamo cinque spettacoli che hanno catturato la nostra attenzione per profondità, precisione dell’esecuzione e originalità della narrazione.
Iniziamo con il parlare dei due spettacoli che si sono divisi i premi: “Nose”, della compagnia Teatro 199 Valentin Stoychev di Sofia, e “On the wolf’s trail” dei serbi dello Youth Theater, entrambi adattamenti di due testi celebri come il “Naso” di Gogol e “Il richiamo della foresta” di Jack London.
il parlare dei due spettacoli che si sono divisi i premi: “Nose”, della compagnia Teatro 199 Valentin Stoychev di Sofia, e “On the wolf’s trail” dei serbi dello Youth Theater, entrambi adattamenti di due testi celebri come il “Naso” di Gogol e “Il richiamo della foresta” di Jack London.
La compagnia bulgara – premiati i due attori Polina Hristova e Georgi Spasov rispettivamente come miglior attrice e miglior attore – diretta da Veselka Kuncheva si è misurata con il testo del drammaturgo russo in modo potente e di grande impatto scenico, andando a esaltare tutti i lati ironici e assurdi propri della narrazione attraverso una prova attoriale importante, fatta anche di grande fisicità e l’ottima trasposizione in maschera degli aspetti cardine del Naso: l’identità e la perdita della stessa, i rapporti e le gerarchie sociali, l’opinione comune, l’omologazione.
Sono proprio le maschere su cui si reggono i nasi, di varie dimensioni, alcuni enormi, che fortificano la scelta registica di porre l’attenzione sulla dimensione dell’assurdo, grottesco e surreale del racconto; il tutto viene rafforzato da una costruzione della scena pulita e efficace,  con un blocco unico che diventa banco degli imputati, ambiente domestico, teatro, sogno, ufficio amministrativo, archivio di nasi e dalla prova superlativa dei due attori (hanno ritmo e grande interplay) che scelgono di riportare la vicenda del funzionario Kovalev con una recitazione volutamente “sopra le righe”, con inserti comici e, allo stesso tempo, di seria riflessione: il protagonista (encomiabile Polina Hristova) è alla disperata ricerca del naso perduto, una disperazione che viene trasformata in scena in rabbia “deforme” e forte solitudine.
con un blocco unico che diventa banco degli imputati, ambiente domestico, teatro, sogno, ufficio amministrativo, archivio di nasi e dalla prova superlativa dei due attori (hanno ritmo e grande interplay) che scelgono di riportare la vicenda del funzionario Kovalev con una recitazione volutamente “sopra le righe”, con inserti comici e, allo stesso tempo, di seria riflessione: il protagonista (encomiabile Polina Hristova) è alla disperata ricerca del naso perduto, una disperazione che viene trasformata in scena in rabbia “deforme” e forte solitudine.
Ne esce uno spettacolo perfettamente costruito, efficace, brillante, intelligente e profondo, simbolo di un teatro di figura immaginifico e di grande resa scenica grazie ai grandi nasi e alle maschere ben fatte che ci restituiscono il senso di omologazione e di assenza di identità propria della società descritta da Gogol.
“On the wolf’s trail”, nell’adattamento della compagnia di Novi Sad (ha vinto il Gran Premio, il premio per la miglior scenografia e per la miglior regia), è stato un vero e proprio  viaggio nel testo di Jack London. Uno spettacolo che si è distinto per la grande complessità della macchina scenica e per l’abilità degli attori nella manipolazione dei pupazzi, veri e propri protagonisti, con una grande cura per i dettagli tanto da farci immergere nella narrazione in completa empatia con essi; la bravura degli attori è stata, infatti, anche quella di farci percepire il cane Buck come punto focale del racconto e non come semplice marionetta, che, in questo caso, ha perso la mera connotazione di semplice oggetto facendosi corpo, respiro, sguardo.
viaggio nel testo di Jack London. Uno spettacolo che si è distinto per la grande complessità della macchina scenica e per l’abilità degli attori nella manipolazione dei pupazzi, veri e propri protagonisti, con una grande cura per i dettagli tanto da farci immergere nella narrazione in completa empatia con essi; la bravura degli attori è stata, infatti, anche quella di farci percepire il cane Buck come punto focale del racconto e non come semplice marionetta, che, in questo caso, ha perso la mera connotazione di semplice oggetto facendosi corpo, respiro, sguardo.
La pièce si è sviluppata su diversi piani spazio-temporali anche grazie a una scenografia efficace (meritato il premio) che ha trasformato il palco del Teatro dell’Opera di Stara Zagora in un mondo di fantasia tra Oceano e grandi foreste del Nord America e alla costruzione del tappeto sonoro in diretta: la presenza del batterista-narratore onnisciente ha dato ritmo e collante mentre la compagnia ha lavorato con un equilibrio quasi magico, sincronizzando perfettamente suono e movimento ad ogni passaggio; elementi che sono risultati essenziali anche per la trasformazione e il passaggio tra interni ed esterni della narrazione, vere e proprie zoomate cinematografiche che hanno ampliato il nostro immaginario. Tutto ci è sembrato reale: il rumore degli attrezzi, gli alberi, la scoperta dell’oro, il viaggio nella nave così come il dolore, la perdita, l’assenza, il richiamo. 
Un dramma magistralmente costruito con delicatezza e precisione, adatto quindi a un pubblico anche di bambini, ricco di elementi tecnici e con una profonda attenzione al testo originale, sapientemente riadattato e riscritto.
Tra gli altri spettacoli in concorso che a nostro avviso avrebbero meritato un riconoscimento ricordiamo “Collateral Damage”, progetto bulgaro di Class 5x5 e Azaryan Theater, e “Hamlet” del polacco Adam Walny.
“Collateral Damage” è un progetto finanziato dal Fondo Nazionale per la Cultura della Bulgaria attraverso il programma “Debuts” realizzato con il supporto delle compagnie sopracitate e del Fondo bulgaro per le donne.
In questo fulgido esempio di teatro storico infatti le donne sono il fulcro di tutto, della drammaturgia e della scena: la storia è basata sulla vera vicenda di alcune 
Dopo l’invasione dell’Unione Sovietica da parte di Hitler, avvenuta con un colossale impiego di uomini e mezzi, l’esercito sovietico non si arrende e dopo un iniziale sbandamento riesce a riorganizzarsi, dando vita ad un’accanita resistenza. È in questo momento che intervengono le donne, centinaia di migliaia di diciottenni che sacrificano la propria giovinezza e gli studi per soccorrere la patria e i propri compagni. Infermiere, radiotelegrafiste, cuoche, lavandaie, soldati di fanteria, addette alla contraerea, carriste, sminatrici, aviatrici, tiratrici scelte, tutte vestite come uomini, tutte a contatto con il sangue, tutte pronte a rinunciare alla propria femminilità e a mettere a rischio consapevolmente la propria vita.
Svetlana Aleksievic ha raccolto le testimonianze di queste donne dopo 40 anni e Makasima Boeva,
L’Amleto  di Adam Walny invece ci immerge in una dimensione completamente nuova. E immergere è la parola chiave del nostro ragionamento. L’attore e drammaturgo polacco infatti lavora con le marionette nell’acqua (soluzione originale e mai vista nelle nostre latitudini) e immerge (appunto) i suoi personaggi in grosse e pensati teche trasparenti mosse da un sistema di carrucole con cui viene allestita la scena. Sei personaggi (Polonio, Claudio e Gertrude in un’unica bacheca, Laerte, Ofelia e Rosencrantz) in cinque vetrine, sommersi, boccheggianti, annegati eppure ancora vivi che Walny muove con dinamismo e piccole raffinatezze estetiche che hanno colpito la nostra attenzione (come le bolle che escono dalla bocca delle grandi marionette nell’acqua).
di Adam Walny invece ci immerge in una dimensione completamente nuova. E immergere è la parola chiave del nostro ragionamento. L’attore e drammaturgo polacco infatti lavora con le marionette nell’acqua (soluzione originale e mai vista nelle nostre latitudini) e immerge (appunto) i suoi personaggi in grosse e pensati teche trasparenti mosse da un sistema di carrucole con cui viene allestita la scena. Sei personaggi (Polonio, Claudio e Gertrude in un’unica bacheca, Laerte, Ofelia e Rosencrantz) in cinque vetrine, sommersi, boccheggianti, annegati eppure ancora vivi che Walny muove con dinamismo e piccole raffinatezze estetiche che hanno colpito la nostra attenzione (come le bolle che escono dalla bocca delle grandi marionette nell’acqua).
L’unico soggetto al di fuori di questa bagnata realtà è proprio Amleto che in questa rappresentazione ci appare ancora più dannato a trascendente. L’attore, in panni vittoriani, lo manovra e lo fa suo, amplificando le sue ossessioni, le sue paure, spesso sovrapponendosi ad esso in uno scambio continuo tra sogno e realtà, tra visioni e sentimenti, giocando sempre al limite di un filo sottilissimo che spesso ci induce a pensare che i personaggi “annegati” siano tutti frutto dei ricordi di Amleto, della sua follia, messi in vetrina come spettri, a ricordargli per sempre la sua ossessione. La separazione tra il protagonista e gli  altri pupi è spiazzante e le due dimensioni in cui si muovono, quella subacquea e quella terrena, sembrano voler sottolineare tutte le imperfezioni del Principe di Danimarca, perso tra i riverberi dello Spirito del Padre, alla ricerca costante di esso e di se stesso ma sempre più solo e isolato, come un pesce fuori dall’acqua.
altri pupi è spiazzante e le due dimensioni in cui si muovono, quella subacquea e quella terrena, sembrano voler sottolineare tutte le imperfezioni del Principe di Danimarca, perso tra i riverberi dello Spirito del Padre, alla ricerca costante di esso e di se stesso ma sempre più solo e isolato, come un pesce fuori dall’acqua.
Uno spettacolo originale, potente, capace di entrare sotto la nostra pelle, dentro la nostra comprensione più profonda nonostante l’handicap della lingua (in polacco senza sottotitoli) che qui, però, non abbiamo minimamente percepito, come solo il grande teatro riesce a fare.
Chiudiamo il nostro resoconto con la messinscena (fuori competizione) che ha suscitato maggior stupore e meraviglia: “The last man”, tratto da “1984” di George Orwell, una delle due produzioni presentate al Pierrot della compagnia organizzatrice, lo State Puppet Theatre di Stara Zagora.
Un’ora e mezzo di teatro distopico, sfolgorante, creativo estremamente contemporaneo e visionario che mette in luce un futuro annichilente e un’umanità ridotta allo stremo con uomini che diventano numeri, perdendo qualsiasi capacità di ragionamento autonomo (pena l’elettroshock) e di coscienza.
Comandati dalla voce del Grande Fratello – un’attrice e soprano che campeggia la scena senza mai scendere tra i comuni mortali, esplosiva e corroborante – i sette personaggi (gli attori sono una squadra perfetta ed estremamente dinamica) diventano meri esecutori di una vita che non hanno scelto, esempio del genere umano lobotomizzato dai mezzi di comunicazione di massa (esemplificativa infatti la scena del grande quiz), dai meri bisogni materiali comandati dall’alto, privato di sentimenti, privato di scelte e quindi privato della capacità di essere unici. L’individualismo cede il passo, in questo mondo furibondo e infernale, alla globalizzazione delle mente, alla depersonalizzazione, ai gesti meccanici ripetuti in serie fino a distorcere la realtà dei fatti. Il tutto attraversato da un mantra, una sorta di nuovo comandamento moderno dettato dal deus-ex-machina invisibile che i protagonisti sono obbligati a ripetere.
– un’attrice e soprano che campeggia la scena senza mai scendere tra i comuni mortali, esplosiva e corroborante – i sette personaggi (gli attori sono una squadra perfetta ed estremamente dinamica) diventano meri esecutori di una vita che non hanno scelto, esempio del genere umano lobotomizzato dai mezzi di comunicazione di massa (esemplificativa infatti la scena del grande quiz), dai meri bisogni materiali comandati dall’alto, privato di sentimenti, privato di scelte e quindi privato della capacità di essere unici. L’individualismo cede il passo, in questo mondo furibondo e infernale, alla globalizzazione delle mente, alla depersonalizzazione, ai gesti meccanici ripetuti in serie fino a distorcere la realtà dei fatti. Il tutto attraversato da un mantra, una sorta di nuovo comandamento moderno dettato dal deus-ex-machina invisibile che i protagonisti sono obbligati a ripetere.
La ripetizione dei gesti e delle parole dà il suono e il ritmo allo spettacolo, una struttura circolare (inizia e finisce, infatti, nello stesso modo) come fosse un rosario laico composto da sudore, paure, violenze, fughe, ritorni, uccisioni, che ci trascina sulla scena senza lasciarci scampo.
Gli elementi scenici - la grande impalcatura nel fondale, le scatole che diventano gabbie – gli effetti sonori stranianti, le voci distorte, il tappeto musicale perfettamente equilibrato e l’uso delle luci sapientemente integrato ai fini della comprensione della narrazione rendono questa grande macchina un organismo teatrale perfetto capace di moltiplicare le visioni, le strade della sperimentazione, aprendone di nuove e impreviste. “The last man” è un fermento drammaturgico che difficilmente incontriamo nelle nostre esperienze teatrali, uno  spettacolo essenziale che meriterebbe i palchi di tutto il mondo.
spettacolo essenziale che meriterebbe i palchi di tutto il mondo.
Il Pierrot, nella sua settimana di programmazione e grazie alla sensibilità della direzione artistica, si è dimostrato un festival ampio, ben organizzato, che ha ricevuto plausi unanimi da parte di addetti ai lavori provenienti da tutta Europa (e non solo) e dal pubblico sempre nutrito, e a cui riconosciamo, soprattutto, la capacità di aver posto grande attenzione alle drammaturgie e ai linguaggi contemporanei applicati al teatro di figura, andandosi così a ritagliare certamente un posto sul podio delle migliori rassegne europee sul genere.
Giulia Focardi
"Incanti", a Torino si ripete la magia del teatro di figura: Mummenschanz, Sacchi di Sabbia, La tortue noire
TORINO – E con questa sono ventisei le edizioni del “Festival Incanti” (3-10 ottobre) dislocato tra Torino, Grugliasco e Rivoli con la centralità della Casa del Teatro ma anche, sempre nel capoluogo piemontese, il magnifico Circolo dei Lettori, il Teatro Astra e il Cinema Massimo. Il direttore Alberto Jona ha stilato un cartellone (supportato e sostenuto da Compagnia di San Paolo) con ospitalità da Perù, Canada, Spagna, Svizzera, Francia e Italia per un giro del mondo attorno e dentro al teatro di figura, piccole e grandi scoperte capaci di meravigliare, far sobbalzare o semplicemente sognare: non è poco.
Grande colpo per “Incanti” quest'anno è stato quello di essere riusciti a portare a Torino il memorabile gruppo svizzero dei Mummenschanz, storica compagnia  (riconosciuta a livello globale al pari di Cirque du Soleil, Stomp o Momix) da cinquant'anni in giro per il mondo con le loro creazioni, compreso Broadway. In un Teatro Astra gremito e traboccante (la rassegna si è aperta nel teatro del TPE diretto da Valter Malosti) si è sciolta e diffusa la loro ingenua e colorata vitalità con “You & Me”, vero inno fanciullesco, leggero e trasognante. Quasi due ore, ma godibilissime e scorrevoli, pur senza una parola né una musica, per un impianto gigantesco dalle mani bianche del mimo, su uno sfondo nero perfetto, che fanno il “muro”, si danno il cinque, si stringono in segno di saluto, indicano il pubblico, vagamente e gentilmente minacciose. Nascono, crescono e proliferano creature curiose e fuori dall'ordinario in questo universo che ribolle sul palco: grandi vermi verdi con la faccia da pesce e pavoni, farfalle e fantasmi, spermatozoi e murene, esseri marini stranissimi e meduse che lottano, giocando, tra cromatismi sfavillanti e spumeggianti. Una gioia per gli occhi. Un habitat primordiale, un terreno sommerso, forse primitivo e ancestrale, prima, molto prima della comparsa dell'uomo e di qualsiasi genere animale che conosciamo oggi. Orecchie blu
(riconosciuta a livello globale al pari di Cirque du Soleil, Stomp o Momix) da cinquant'anni in giro per il mondo con le loro creazioni, compreso Broadway. In un Teatro Astra gremito e traboccante (la rassegna si è aperta nel teatro del TPE diretto da Valter Malosti) si è sciolta e diffusa la loro ingenua e colorata vitalità con “You & Me”, vero inno fanciullesco, leggero e trasognante. Quasi due ore, ma godibilissime e scorrevoli, pur senza una parola né una musica, per un impianto gigantesco dalle mani bianche del mimo, su uno sfondo nero perfetto, che fanno il “muro”, si danno il cinque, si stringono in segno di saluto, indicano il pubblico, vagamente e gentilmente minacciose. Nascono, crescono e proliferano creature curiose e fuori dall'ordinario in questo universo che ribolle sul palco: grandi vermi verdi con la faccia da pesce e pavoni, farfalle e fantasmi, spermatozoi e murene, esseri marini stranissimi e meduse che lottano, giocando, tra cromatismi sfavillanti e spumeggianti. Una gioia per gli occhi. Un habitat primordiale, un terreno sommerso, forse primitivo e ancestrale, prima, molto prima della comparsa dell'uomo e di qualsiasi genere animale che conosciamo oggi. Orecchie blu  giganti, anemoni di mare e cavallucci marini tenerissimi e trasparenti, perfetti nella loro dolcezza e vulnerabilità, o pesci luminosi che vivono nelle profondità degli abissi o nella Fossa delle Marianne. Ma sono le meduse le vere attrici principali, sinuose, melliflue, seducenti come sirene, volanti, caracollanti in questa loro danza continua di tentacoli come braccia della Dea Kali. E ancora uova e rane e umanoidi stilizzati e segmentati che ci hanno ricordato la mascotte del campionato del mondo di calcio di Italia '90. Teste che diventano violini, volti di gong o di triangolo, che si trasformano in formiche o nell'urlo di Munch, tubi che sono lombrichi, mostri gonfiabili e bocche che ingoiano rifiuti. L'unica regola è che non ci sono regole, non cercare spiegazioni, segui soltanto il fluire, lasciati trasportare nella corrente.
giganti, anemoni di mare e cavallucci marini tenerissimi e trasparenti, perfetti nella loro dolcezza e vulnerabilità, o pesci luminosi che vivono nelle profondità degli abissi o nella Fossa delle Marianne. Ma sono le meduse le vere attrici principali, sinuose, melliflue, seducenti come sirene, volanti, caracollanti in questa loro danza continua di tentacoli come braccia della Dea Kali. E ancora uova e rane e umanoidi stilizzati e segmentati che ci hanno ricordato la mascotte del campionato del mondo di calcio di Italia '90. Teste che diventano violini, volti di gong o di triangolo, che si trasformano in formiche o nell'urlo di Munch, tubi che sono lombrichi, mostri gonfiabili e bocche che ingoiano rifiuti. L'unica regola è che non ci sono regole, non cercare spiegazioni, segui soltanto il fluire, lasciati trasportare nella corrente.
Mettere i sacchi di sabbia vicino alla finestra come diceva Lucio Dalla ne “L'Anno che verrà” non servirà. Il gruppo pisano rimane travolgente, sempre elettrico ed eclettico, riesce sempre a stupire, coerenti all'interno di una loro poetica riconoscibile e congrua ma sempre spiazzanti, proseguendo nel loro percorso brillante, alto e popolare, insistendo sull'altra loro vena artistica, quella del disegno, del fumetto, del segno sulla carta. I loro “I quattro moschettieri in America” è un inno al cartoon, alle storie lette da ragazzi, che poi sono quelle che costruiscono un immaginario e ci fanno sognare, alle figure con le quali giocavamo, non supereroi ma terreni, fallimentari, umani. I Sacchi di Sabbia miscelano i moschettieri di Dumas con la New York in bianco e nero del cinema del dopoguerra, cappa e spada e pistole, fioretto e le magnum dei mafiosi d'Oltreoceano con cognomi italiani. E l'incrocio e l'incontro sono fertili perché le risate e i colpi di scena appaiono come pop up (meravigliose opere d'arte) che si aprono dai libroni posti su un tavolino centrale. C'è il canto in rima, altra peculiarità e scelta del leader Giovanni Guerrieri,
sulla carta. I loro “I quattro moschettieri in America” è un inno al cartoon, alle storie lette da ragazzi, che poi sono quelle che costruiscono un immaginario e ci fanno sognare, alle figure con le quali giocavamo, non supereroi ma terreni, fallimentari, umani. I Sacchi di Sabbia miscelano i moschettieri di Dumas con la New York in bianco e nero del cinema del dopoguerra, cappa e spada e pistole, fioretto e le magnum dei mafiosi d'Oltreoceano con cognomi italiani. E l'incrocio e l'incontro sono fertili perché le risate e i colpi di scena appaiono come pop up (meravigliose opere d'arte) che si aprono dai libroni posti su un tavolino centrale. C'è il canto in rima, altra peculiarità e scelta del leader Giovanni Guerrieri,  c'è un'emigrazione al contrario, dall'Europa negli Stati Uniti, c'è la disoccupazione e la disperazione con la conseguente presa di posizione di farla finita decorosamente: “Spesso ci scambiano con i Fratelli Karamazov”. Personaggi involontariamente invincibili. Appare anche una battuta tratta da “Chi ha incastrato Roger Rabbit”, altro caposaldo che mischiava attori in carne ed ossa e cartoni animati: “Hai una pistola lì sotto o sei soltanto contento di vedermi?”. Un road movie pieno di inseguimenti, di disegni mirabolanti (bel tratto di Guido Bartoli), di fumetti eccitanti, una graphic novel di fuggiaschi e gangster senza scrupoli, dove per una volta vincono i più scalcinati e cialtroneschi: per bambini di tutte le età.
c'è un'emigrazione al contrario, dall'Europa negli Stati Uniti, c'è la disoccupazione e la disperazione con la conseguente presa di posizione di farla finita decorosamente: “Spesso ci scambiano con i Fratelli Karamazov”. Personaggi involontariamente invincibili. Appare anche una battuta tratta da “Chi ha incastrato Roger Rabbit”, altro caposaldo che mischiava attori in carne ed ossa e cartoni animati: “Hai una pistola lì sotto o sei soltanto contento di vedermi?”. Un road movie pieno di inseguimenti, di disegni mirabolanti (bel tratto di Guido Bartoli), di fumetti eccitanti, una graphic novel di fuggiaschi e gangster senza scrupoli, dove per una volta vincono i più scalcinati e cialtroneschi: per bambini di tutte le età.
Sia nel 2017 che questa estate siamo stati invitati e abbiamo seguito il Festival Biennale della Marionetta di Saguenay, il Fiams in Canada, su un fiordo in Quebec. Proprio nell'ultima edizione abbiamo avuto la fortuna di assistere, della compagnia La tortue noire che organizza l'impegnativa rassegna nel Canada francofono, al monumentale “Ogre”. Se l'Orco del titolo era un pupazzone di quattro metri e la scena aveva  necessità di spazio per aprirsi ed esprimersi, questo “Le grand Oeuvre” si presenta in tutta la sua ristrettezza e piccolezza. Uno spettacolo per pochi spettatori, tutti a contatto con questa struttura magica, affatto semplice, dove tutto si trasforma, prende vita, si anima. Un teatro da camera che ci porta dentro gli esperimenti e le alchimie di un monaco incappucciato che già ci conduce all'interno dei misteri, delle penombre e dei chiaroscuri del “Nome della Rosa”. Una postazione dove il frate (Martin Gagnon, somiglia a Kevin Spacey) mischia, sposta, confabula, aggiunge pozioni e intrugli, crea, cupo e fosco e losco, in una serie di rituali esoterici e fumi e nebbie. Due sono i “palchi” a disposizione dentro questa minuta cabina: lo spazio sul tavolo davanti al religioso e il mondo dei suoi pensieri che si manifestano e solidificano e diventano reali e tangibili e prendono vita
necessità di spazio per aprirsi ed esprimersi, questo “Le grand Oeuvre” si presenta in tutta la sua ristrettezza e piccolezza. Uno spettacolo per pochi spettatori, tutti a contatto con questa struttura magica, affatto semplice, dove tutto si trasforma, prende vita, si anima. Un teatro da camera che ci porta dentro gli esperimenti e le alchimie di un monaco incappucciato che già ci conduce all'interno dei misteri, delle penombre e dei chiaroscuri del “Nome della Rosa”. Una postazione dove il frate (Martin Gagnon, somiglia a Kevin Spacey) mischia, sposta, confabula, aggiunge pozioni e intrugli, crea, cupo e fosco e losco, in una serie di rituali esoterici e fumi e nebbie. Due sono i “palchi” a disposizione dentro questa minuta cabina: lo spazio sul tavolo davanti al religioso e il mondo dei suoi pensieri che si manifestano e solidificano e diventano reali e tangibili e prendono vita  sulla sua testa calva, rasata come il Mondo, sferica come la Terra, rotonda come il nostro Pianeta. Lì le idee prendono corpo. L'alchimista è governato da due mini droni, il Bene e il Male che si scontrano e cozzano infondendo le loro volontà e verità alle azioni dell'ecclesiastico. Nascono tanti piccoli oggetti (il manovratore invisibile alle sue spalle è il regista Dany Lefrancois, un lavoro millimetrico e precisissimo il suo), quasi una creazione del mondo in sette giorni. L'alchimista è Dio che gioca sia con gli uomini che a dadi, sul suo tavolo da esperimenti e prove: ecco gli alberi, ecco una coppia, presumibilmente una sorta di Adamo ed Eva, e poi ancora alambicchi e bilancini, centrifughe e spume, ricette e ingredienti segreti e fatati e fatali, incantati e prodigiosi. Sulla sua testa spuntano missili e lampi di guerra fino ad una croce e ad un inquietante umanoide: la storia, complessa e articolata, di Dio e dell'uomo in mezz'ora, vitale ed esplosiva, colma di effetti artigianali e pirotecnici: magico.
sulla sua testa calva, rasata come il Mondo, sferica come la Terra, rotonda come il nostro Pianeta. Lì le idee prendono corpo. L'alchimista è governato da due mini droni, il Bene e il Male che si scontrano e cozzano infondendo le loro volontà e verità alle azioni dell'ecclesiastico. Nascono tanti piccoli oggetti (il manovratore invisibile alle sue spalle è il regista Dany Lefrancois, un lavoro millimetrico e precisissimo il suo), quasi una creazione del mondo in sette giorni. L'alchimista è Dio che gioca sia con gli uomini che a dadi, sul suo tavolo da esperimenti e prove: ecco gli alberi, ecco una coppia, presumibilmente una sorta di Adamo ed Eva, e poi ancora alambicchi e bilancini, centrifughe e spume, ricette e ingredienti segreti e fatati e fatali, incantati e prodigiosi. Sulla sua testa spuntano missili e lampi di guerra fino ad una croce e ad un inquietante umanoide: la storia, complessa e articolata, di Dio e dell'uomo in mezz'ora, vitale ed esplosiva, colma di effetti artigianali e pirotecnici: magico.
Tommaso Chimenti 07/10/2019
Fiams 2019: tutta l’umanità delle marionette nel festival internazionale in Quebec
Quindici edizioni per il Festival Internazionale delle Arti della Marionetta a Saguenay. Quindici edizioni per questa manifestazione biennale che attrae da svariate parti del globo compagnie, performer, direttori artistici e giornalisti nella regione del fiordo della regione in Quebec, a quasi sei ore di viaggio da Montreal. Un viaggio, appunto, sia esteriore, fatto di strade dritte e sicure e boschi infiniti, che interiore: quello che il teatro di figura ci porta a fare ogni volta che ci relazioniamo con esso attraverso marionette, pupi, pupazzi, ombre, oggetti, disegni, ma soprattutto tanta immaginazione, consentendoci un passo indietro, anzi un passo dentro la nostra capacità di fare i conti con la nostra fantasia.
Circa trentacinque spettacoli per il Fiams 2019 (andato in scena l’ultima settimana di luglio) tra la programmazione principale – tra centri culturali e auditorium di scuole e università – e un’altra off e gratuita organizzata negli spazi esterni di Chicoutimi e Jounquiere, lungo il fiume; alle perfomance si sono aggiunte poi numerose attività professionali e di formazione, indirizzate soprattutto a far conoscere il lavoro delle compagnie locali (interessante anche il grande supporto e scambio con la scena francese, connessione incentivata da Institute Francaise del Quebec), e collaterali, come la presentazione dell’emblematica e profonda mostra fotografica di Alice Laloy, Pinocchio(s), che ci ha turbati e spinto alla riflessione.
In questo nostro percorso abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con molteplici forme di teatro di figura, ma abbiamo deciso di soffermarci su quattro spettacoli che maggiormente ci hanno ampliato il cuore e lo sguardo, rendendolo più attento e profondo, necessariamente umano.
Ed è proprio  sull’umanità che l’artista catalano David Espinoza punta la sua lente di ingrandimento nello spettacolo “Mi gran obra”, una rara e perfetta macchina di geometrie interiori e di lillipuziane misure. L’idea iniziale è geniale: costruire il teatro più piccolo del mondo, un teatro trasportabile che raggiunga il pubblico di tutto il mondo e non il contrario (in questo caso un trolley da viaggio) in cui veniamo metaforicamente invitati ad entrare. Con binocolo alla mano (se il teatro è il più piccolo del mondo anche gli “attori” ne rispettano le dimensioni) siamo pronti ad immergerci in cinquanta minuti di un teatro a misura d’uomo, non per la grandezza dei minuscoli pupazzini manipolati dal demiurgo Espinoza ma per il contenuto che è capace di far penetrare nelle nostre menti. Il regista, vero e proprio deus ex machina del suo micromondo, dirige la propria umanità con abilità e delicatezza costruendo, scena dopo scena, azioni, sentimenti, sacramenti, vizi, virtù, peccati e peccatori, passato, presente e futuro della nostra società miope. Coadiuvato da alcuni video su tablet, da un gioco di luci intelligente e dalla musica come perfetta cucitura della sua drammaturgia e necessaria nel condurre il nostro pensiero, l’artista catalano compone per rapida e minuziosa sottrazione di elementi grandi raduni di piazza, feste, balli, matrimoni, orge, marce militari, l’assassinio del Presidente degli Stati Uniti, i Mariachi che suonano (il pensiero va d’istinto al muro americano) storie d’amore, l’andamento di una vita intera fino alla morte.
sull’umanità che l’artista catalano David Espinoza punta la sua lente di ingrandimento nello spettacolo “Mi gran obra”, una rara e perfetta macchina di geometrie interiori e di lillipuziane misure. L’idea iniziale è geniale: costruire il teatro più piccolo del mondo, un teatro trasportabile che raggiunga il pubblico di tutto il mondo e non il contrario (in questo caso un trolley da viaggio) in cui veniamo metaforicamente invitati ad entrare. Con binocolo alla mano (se il teatro è il più piccolo del mondo anche gli “attori” ne rispettano le dimensioni) siamo pronti ad immergerci in cinquanta minuti di un teatro a misura d’uomo, non per la grandezza dei minuscoli pupazzini manipolati dal demiurgo Espinoza ma per il contenuto che è capace di far penetrare nelle nostre menti. Il regista, vero e proprio deus ex machina del suo micromondo, dirige la propria umanità con abilità e delicatezza costruendo, scena dopo scena, azioni, sentimenti, sacramenti, vizi, virtù, peccati e peccatori, passato, presente e futuro della nostra società miope. Coadiuvato da alcuni video su tablet, da un gioco di luci intelligente e dalla musica come perfetta cucitura della sua drammaturgia e necessaria nel condurre il nostro pensiero, l’artista catalano compone per rapida e minuziosa sottrazione di elementi grandi raduni di piazza, feste, balli, matrimoni, orge, marce militari, l’assassinio del Presidente degli Stati Uniti, i Mariachi che suonano (il pensiero va d’istinto al muro americano) storie d’amore, l’andamento di una vita intera fino alla morte.
Espinoza costruisce uno spettacolo prezioso con un’impronta fortemente politica, una vena polemica, ironica, senza  l’uso di parole e questo è un valore aggiunto; sono le mani a imbandire frasi, i gesti leggeri, precisi e millimetrici a creare quel montaggio delizioso e irriverente di metafore e immagini potenti e immediate che fanno luce nella nostra mente. Sono le mani a dettare il ritmo, a creare l’azione, a cambiare la fisionomia dei personaggi e anche il nostro sentire che muta tra divertimento, senso di solitudine, empatia, imbarazzo, vergogna rendendoci tutti piccoli, minuscoli, vulnerabili. Una piccola grande opera necessaria.
l’uso di parole e questo è un valore aggiunto; sono le mani a imbandire frasi, i gesti leggeri, precisi e millimetrici a creare quel montaggio delizioso e irriverente di metafore e immagini potenti e immediate che fanno luce nella nostra mente. Sono le mani a dettare il ritmo, a creare l’azione, a cambiare la fisionomia dei personaggi e anche il nostro sentire che muta tra divertimento, senso di solitudine, empatia, imbarazzo, vergogna rendendoci tutti piccoli, minuscoli, vulnerabili. Una piccola grande opera necessaria.
Se vogliamo tratteggiare una linea immaginaria di senso che colleghi gli spettacoli di cui parliamo, sullo stesso piano di intensità di “Mi gran obra” abbiamo trovato “Vida” dello spagnolo Javier Aranda, sia per l’uso esclusivo delle mani nella costruzione della narrazione, sia per l’immediatezza e l’essenzialità dei messaggi veicolati che per quel clima di vicinanza e di forte intimità che l’artista è stato in grado di creare con il pubblico, aiutato anche dallo spazio in cui è stato presentato lo spettacolo: il piccolo teatro cabaret Coté-Cour, caldo e accogliente, forse la venue che abbiamo maggiormente apprezzato al Fiams.
“Vida” è un fiore che sboccia con delicatezza proprio davanti ai nostri occhi e che, come ci suggerisce il titolo, parla dell’esistenza nella più semplice delle concezioni: il nostro protagonista cresce, diventa un adulto, si innamora di colei che gli resterà accanto per tutta la vita, diventa padre, diventa anziano, sopravvive alla morte della moglie per poi spegnersi dopo poco tempo. La vita nei suoi tratti più essenziali, negli aspetti universali che sappiamo riconoscere, nella sua semplicità appunto; anche se tanto semplice alla fine non lo è mai, nessuno si salva dal dolore, dai tormenti, dalle perdite, dalle partenze senza ritorno, ma soprattutto – e anche su questo sembra vertere il cuore della drammaturgia di Aranda – “nessuno si salva da solo”.
semplicità appunto; anche se tanto semplice alla fine non lo è mai, nessuno si salva dal dolore, dai tormenti, dalle perdite, dalle partenze senza ritorno, ma soprattutto – e anche su questo sembra vertere il cuore della drammaturgia di Aranda – “nessuno si salva da solo”.
Il performer spagnolo mette in scena la storia dei suoi protagonisti, che assomiglia alla vita di ciascuno di noi, usando le proprie mani: tre abili tocchi e al posto delle dieci dita vengono fuori naso, occhi, bocca e capelli, tre abili tocchi e l’uomo che sta dietro alla macchineria scompare lasciandoci di fronte ai due personaggi, ai loro umori, alle loro sensibilità, ai loro sentimenti, i quali, grazie anche agli efficaci costumi, prendono corpo a se stante. Corpi che dialogano con il proprio regista, che dialogano con noi, che sanno essere ironici, sferzanti, teneri, sognatori, vicini alla nostra umanità, a quel sentire diffuso e condiviso che ci unisce e ci fa commuovere.
Una pièce delicata e profondissima che ci ha confermato i confini illimitati del teatro di figura, universale e potente.
Un’esperienza altrettanto immersiva è stata quella del piccolo teatro d’appartamento Ephémère Chez dove la compagnia Théatre Cri ha presentato, in prima assoluta, il piccolo ed esplosivo “Aisseselles et bretelles”, letteralmente “ascelle e bretelle” cioè gli elementi utili a Guylaine Rivard (regista, unica attrice in scena, e fondatrice della compagnia) per costruire il suo spettacolo o meglio per costruirselo addosso. Costumi vittoriani, collari elisabettiani, gonne voluminose, pantaloni ottocenteschi, giacche, giacchine, camicie sempre più sottili e accessori di scena utilizzati con sagacia per un teatro a strati, una narrazione modulata addosso alla sua interprete istrionica e creativa che crea su di sé uno scenario immaginifico e fantastico. 
L’impianto drammaturgico si basa sulla più classica delle fiabe: la storia di un principe ereditario e di una regina madre bellissima e cattivissima. Ma la Rivard, eccellente trasformista, manipola l’universalità della favola impastando tutto con irriverenza (il principe si chiama Adolph e ha il volto di Trumph), un tono dissacratorio irresistibile e un montaggio di figure, disegni pop up, piccoli pupazzi e burattini di grande qualità. Ci sono Biancaneve con tutti i nani, Raperonzolo, Cenerentola, Ali Babà, Alice, Cappuccetto Rosso, il genio della lampada, la principessa sul pisello, Buchettino, Pinocchio, il Principe Ranocchio, il Pifferaio magico e molti inserti pop (tra tutti il riferimento a Zombie di Michael Jackson) in questo mosaico piccolo e infinito, questo patchwork quasi casalingo di alto livello che a ogni strato, a ogni passaggio cambia forma ma mai volto come fosse una matrioska di storie. L’attrice è il grande libro di tutte le storie e anche della nostra storia, le indossa, le cambia a suo piacimento, le distorce, le amplifica, le comprime, le distilla con sapienza; è la parola e l’immaginario che scopriamo non coincide con quello che avevamo da bambini e che qui diventa grottesco.
C’è alta artigianalità in “Aisselles et bretelles” e una capacità di costruzione della drammaturgia “alla Monty Python” che trasforma fiabe universali in una commedia sferzante e visionaria, ironica e politica da cui veniamo inevitabilmente travolti. Un format geniale che ci piacerebbe vedere anche in Italia.
Concludiamo il nostro resoconto con quello che consideriamo lo spettacolo di punta di tutto il cartellone, “Ogre”, portato in scena dalle due compagnie quebecchesi La Tortue Noire e Théatre la Rubrique (produttrice del festival), diretto da Dany Lefrançois (direttore artistico del Fiams insieme a Benoît Lagrandeur) e basato sul testo di Larry Tremblay.
Una pièce  che rientra nel grande mare magnum del teatro di figura ma che potrebbe essere certamente presentato in programmazioni di teatro contemporaneo che travalichino generi e modalità di rappresentazione, essendo caratterizzata da una drammaturgia per adulti dai temi scabrosi e contemporanei (il testo ha vent’anni): un uomo, credendosi filmato dalle telecamere, umilia sua moglie portando a casa l'amante straniera, commette un incesto con sua figlia, spinge suo figlio al suicidio, uccide la sua amante per eccesso di amore e firma un contratto per dodici spettacoli. Ci troviamo di fronte a una sorta di Truman Show rivisitato in chiave grottesca e noir che ci impegna in un’indagine profonda anche dentro noi stessi, tutti fortemente “mediatizzati” e tendenti all’egocentrismo per “virtù” o necessità, schiavi del nostro tempo, contemporaneamente vittime e carnefici.
che rientra nel grande mare magnum del teatro di figura ma che potrebbe essere certamente presentato in programmazioni di teatro contemporaneo che travalichino generi e modalità di rappresentazione, essendo caratterizzata da una drammaturgia per adulti dai temi scabrosi e contemporanei (il testo ha vent’anni): un uomo, credendosi filmato dalle telecamere, umilia sua moglie portando a casa l'amante straniera, commette un incesto con sua figlia, spinge suo figlio al suicidio, uccide la sua amante per eccesso di amore e firma un contratto per dodici spettacoli. Ci troviamo di fronte a una sorta di Truman Show rivisitato in chiave grottesca e noir che ci impegna in un’indagine profonda anche dentro noi stessi, tutti fortemente “mediatizzati” e tendenti all’egocentrismo per “virtù” o necessità, schiavi del nostro tempo, contemporaneamente vittime e carnefici.
L’impatto è forte e immediato: un pupazzo imbottito di schiuma di oltre quattro metri sta seduto al centro della scena, con le spalle rivolte al pubblico; inerme ma paradossalmente vivo. A muoverlo tre performer che assumono, nel corso della narrazione, le caratteristiche e i ruoli degli altri personaggi. A dargli anima un attore vero e proprio (Éric Chalifour, potente), alla voce e al mixer, vero e proprio alter ego del gigante.
Un monologo per una “marionetta egocentrica”, squallida e detestabile che però scopriamo capace di un umorismo spietato: rivolta alle telecamere che immagina vomita la propria verità, la propria vita discutibile e agisce seguendo una fame perenne di visibilità e centralità. L’orco è enorme e grasso, sfama il proprio ego e la propria follia con l’illusione della televisione e sentendosi sicuro del plauso del pubblico non segue la morale ma i bassi istinti animali. Si rivolge a sua figlia, sua moglie, suo figlio, ma loro non rispondono e la differenza di dimensioni tra il pupazzo e gli attori caratterizza questi momenti e sottolinea anche  la grande solitudine del protagonista; il gigante e le formiche, il megalomane e i fantasmi che ruotano attorno alla sua vita e che, immancabilmente, finisce per schiacciare. Gli altri personaggi non hanno voce, sembra tutto e solo isolato nella sua mente, in quella bolla di finzione controllata dal grande occhio della televisione che lo induce a una forma di paranoia evidente e ossessiva. Il regista costruisce lo spettacolo sul rapporto tra il pupazzo e l’attore, tra il demone e il super-io, tra l’istinto e la morale; l’attore e il pupazzo si spostano insieme fino a separare movimenti e intenzioni, dall’essere una cosa sola diventano due entità distinte che dialogano tra loro, in contrasto e antagoniste. È la coscienza dell’orco che tenta di ribellarsi al suo “involucro” in un coinvolgente corpo a corpo di parole tra l’attore e il pupazzo che annullano le distanze, in scena e fuori, tra la finzione e la realtà, tra l’essere animato e quello inanimato.
la grande solitudine del protagonista; il gigante e le formiche, il megalomane e i fantasmi che ruotano attorno alla sua vita e che, immancabilmente, finisce per schiacciare. Gli altri personaggi non hanno voce, sembra tutto e solo isolato nella sua mente, in quella bolla di finzione controllata dal grande occhio della televisione che lo induce a una forma di paranoia evidente e ossessiva. Il regista costruisce lo spettacolo sul rapporto tra il pupazzo e l’attore, tra il demone e il super-io, tra l’istinto e la morale; l’attore e il pupazzo si spostano insieme fino a separare movimenti e intenzioni, dall’essere una cosa sola diventano due entità distinte che dialogano tra loro, in contrasto e antagoniste. È la coscienza dell’orco che tenta di ribellarsi al suo “involucro” in un coinvolgente corpo a corpo di parole tra l’attore e il pupazzo che annullano le distanze, in scena e fuori, tra la finzione e la realtà, tra l’essere animato e quello inanimato.
“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.” (Victor Hugo). E cuori umani anche nelle marionette.
Giulia Focardi
Photo: Sophie Lavoie
Alpe Adria Puppet: la laguna esalta marionette e burattini
GRADO – Cominciamo a dire che a Grado non ci sono gradini. Tutto scorre liscio tra il lungomare chilometrico che porta dalla tozza e corpulenta Spiaggia Costa Azzurra fino alla lunghissima Principale passando tra fontane, ville novecentesche, terme, parchi, pinete e giardini. Le zanzare invece pascolano allegramente. A fine agosto i gradi sono tanti. La cappa sfrutta tutta la forza di gravità per pesarti addosso. Tanti turisti, tedeschi, austriaci, dell'Est europeo: dopotutto questo lembo di terra è, storicamente e geograficamente, il primo approdo al mare, al Mar Mediterraneo. Il mare è basso per un centinaio di metri e da lontano i bagnanti sembrano novelli Gesù che camminano sulle acque. Le alghe dell'Adriatico non si fanno attendere e germogliano tra gli immensi frangiflutti posti a barriera. Grado è un dedalo di isolotti dove, se escudiamo la parte nuova e turistica, spuntano i "Casoni", vecchie baracche caratteristiche dei pescatori. Siamo tra Venezia e Trieste, il confine è ancora vicino, Schengen o meno. A Grado non è riuscita ad arrivare né la peste né Attila. In queste zone, da quasi trent'anni il Cta di Gorizia (diretto con gentilezza saggia da Roberto Piaggio:  hanno appena vinto il bando europeo "Puppet and Design" insieme a strutture di Praga, Madrid e Lubiana) organizza tra Grado e, successivamente, Aquileia, Gorizia (interessantissimo il progetto sul teatro nei luoghi della Comunità Ebraica colpita dal rastrellamento del '43) e Nova Gorica (26 agosto – 8 settembre) l'"Alpe Adria Puppet Festival".
hanno appena vinto il bando europeo "Puppet and Design" insieme a strutture di Praga, Madrid e Lubiana) organizza tra Grado e, successivamente, Aquileia, Gorizia (interessantissimo il progetto sul teatro nei luoghi della Comunità Ebraica colpita dal rastrellamento del '43) e Nova Gorica (26 agosto – 8 settembre) l'"Alpe Adria Puppet Festival".
Come imprinting e varo ci accoglie un "Piccolo Principe" modificato che qui diventa "Il Piccolo Esploratore" e pone, in questa casetta-cabina ad oggetti a scomparsa e ante magiche (per la bravura di Alice Melloni, affabulatrice con grazia e delicatezza), tutta la vicenda partendo proprio dagli occhi, in prima persona, del bambino che vaga per la galassia in cerca di amicizia, escludendo così la figura (Saint-Exupery stesso) del pilota dalla narrazione. Il bimbo è un mix tra Playmobil con un panciotto in Lego e dentro il suo razzo fluttua tra i vari Pianeti-Regni-Paesi. Nessuno è un'isola, si direbbe, metafora valida anche in Laguna. Ecco l'incontro con il Re che cercava disperatamente un suddito al quale impartire ordini, ecco che sbarca sul Pianeta dell'Uomo indaffarato, ecco che arriva dal Vanitoso che agogna consensi e complimenti, ecco infine il Geografo che gli spiega (e qui entrano in gioco fotografie di mari, l'onda di Hokusai, o animali; gli oggetti sono di Virginia Di Lazzaro) come quel pianeta, dove si trovano adesso,  fosse un tempo lontano bellissimo, accogliente, verde, rigoglioso, pieno di vita e come ora invece sia arido, spoglio, povero, corrotto dall'inquinamento e dalla plastica. Ma quel pianeta è gemello di un altro che si chiama Terra e che il Piccolo Esploratore raggiungerà poco dopo incontrando il peluche-Volpe. La favola, giustamente, lascia i suoi contorni esistenziali e si sposta sul piano ecologista-ambientalista: dopotutto tra il pubblico ci sono i cittadini di domani.
fosse un tempo lontano bellissimo, accogliente, verde, rigoglioso, pieno di vita e come ora invece sia arido, spoglio, povero, corrotto dall'inquinamento e dalla plastica. Ma quel pianeta è gemello di un altro che si chiama Terra e che il Piccolo Esploratore raggiungerà poco dopo incontrando il peluche-Volpe. La favola, giustamente, lascia i suoi contorni esistenziali e si sposta sul piano ecologista-ambientalista: dopotutto tra il pubblico ci sono i cittadini di domani.
Se la dolcezza del primo spettacolo ci ha cullato e carezzato non possiamo dire altrettanto del secondo, il belga "Post Scriptum", che doveva essere, nelle intenzioni, un Cappuccetto Rosso dissacrante e politicamene scorretto. Soltanto in parte ha soddisfatto queste aspettative risultando invece un confusionario agglomerato-patchwork che avrebbe avuto bisogno di uno spazio protetto, al chiuso, piccolo ed intimo per poter essere valorizzato. Un minimal teatro da camera che messo in piazza, peraltro gremita, è scomparso lasciando la performer isolata tra i suoi pupazzi e le sue gag non sempre riuscite. Su una base di legno verticale, quasi una recinzione da cortile, appaiono oggetti vari senza che il loro significato venga valorizzato: una casa rossa, una montagna, un castello. Posto che Cappuccetto doveva passare per una foresta, un bosco, simbolo della crescita, del passaggio dall'infanzia all'adolescenza e quindi l'entrata nel mondo degli adulti, qui invece viene sostituito da una montagna con le sue vette che non nasconde le stesse inquietudini esistenziali. L'attrice, che si era proposta all'inizio in veste timburtoniana quasi Frankenstein, si trasforma  in un lupo che purtroppo ha le fattezze di un coccodrillo con pelliccia, compreso muso allungato e coda. Il caos regna sovrano e molti abbandonano: parte Vivaldi poi sguito da una sorta di Sirtaki. Il risultato è faticoso con pupazzi e marionette attaccate e aggrappate a questa bacheca, non riuscendo a tenere alta la concentrazione né a eccitare l'attenzione (solo 30 minuti di spettacolo). Alcuni sprazzi da clown cattivo (ci ha vagamente ricordato i folgoranti Tony Clifton Circus) dal tirare fuori le budella del lupo squartato a due scene di sesso, anche tra il Lupo e la Nonna, che il pubblico dei più piccoli non poteva cogliere. Restiamo ancora ancorati alla bellezza, nostro punto di riferimento quando si parla di "Cappuccetto Rosso", della versione dei belgi del Tof Teatro intitolata "Bistouri", sanguigna come un'operazione a cuore aperto, palpitante come un'autopsia.
in un lupo che purtroppo ha le fattezze di un coccodrillo con pelliccia, compreso muso allungato e coda. Il caos regna sovrano e molti abbandonano: parte Vivaldi poi sguito da una sorta di Sirtaki. Il risultato è faticoso con pupazzi e marionette attaccate e aggrappate a questa bacheca, non riuscendo a tenere alta la concentrazione né a eccitare l'attenzione (solo 30 minuti di spettacolo). Alcuni sprazzi da clown cattivo (ci ha vagamente ricordato i folgoranti Tony Clifton Circus) dal tirare fuori le budella del lupo squartato a due scene di sesso, anche tra il Lupo e la Nonna, che il pubblico dei più piccoli non poteva cogliere. Restiamo ancora ancorati alla bellezza, nostro punto di riferimento quando si parla di "Cappuccetto Rosso", della versione dei belgi del Tof Teatro intitolata "Bistouri", sanguigna come un'operazione a cuore aperto, palpitante come un'autopsia.
Due i momenti senza piedi per terra, con il naso all'insù, senza poggiare la suola al terreno. Prima è stata la volta di "Appeso a un filo" dei Di Filippo  Marionette, lei australiana e lui marchigiano: "i costumi li costruisce mia mamma", tenerissimi come le loro creature esili e leggiadre. Esiste il fil rouge e il filo della storia, qui invece queste figurine sono legate ai loro demiurghi e vivono, si muovono, compongono il loro delicato, tenue numero: c'è la marionetta che fatica ad alzarsi ma poi una volta in piedi balla in maniera sfrenata tutto il giorno per poi, stanchissima, rimettersi a dormire, ogni giorno in loop, c'è il violinista matto ma timido, un Paganini gitano flamenchista claudicante, c'è un Arlecchino che balla il tip tap che cade, piange e si rialza, c'è una sorta di Frank Sinatra, c'è una casalinga anziana che spazza e la sua scopa diventa remo per pagaiare sulle nuvole, diviene altalena per tornare bambina o, come strega buona, per volare in alto, ci sono due ragazzini che ballano hip hop e fanno la break dance e free style con mosse e pose da slang, skretch e acrobazie, coreografie nei loro piumini smanicati, infine il ciclista che fa gimkane e salti ad ostacoli ricordandoci la celebre scena di ET, un ciclista che ha la maglia gialla e la bandana rossa e ci piace pensare che sia un ricordo per l'indimenticato Pirata Pantani. Tutti dolcissimi. Centinaia le persone tra il pubblico (nonostante le sedute scomodissime), una vera folla oceanica, impressionante massa.
Marionette, lei australiana e lui marchigiano: "i costumi li costruisce mia mamma", tenerissimi come le loro creature esili e leggiadre. Esiste il fil rouge e il filo della storia, qui invece queste figurine sono legate ai loro demiurghi e vivono, si muovono, compongono il loro delicato, tenue numero: c'è la marionetta che fatica ad alzarsi ma poi una volta in piedi balla in maniera sfrenata tutto il giorno per poi, stanchissima, rimettersi a dormire, ogni giorno in loop, c'è il violinista matto ma timido, un Paganini gitano flamenchista claudicante, c'è un Arlecchino che balla il tip tap che cade, piange e si rialza, c'è una sorta di Frank Sinatra, c'è una casalinga anziana che spazza e la sua scopa diventa remo per pagaiare sulle nuvole, diviene altalena per tornare bambina o, come strega buona, per volare in alto, ci sono due ragazzini che ballano hip hop e fanno la break dance e free style con mosse e pose da slang, skretch e acrobazie, coreografie nei loro piumini smanicati, infine il ciclista che fa gimkane e salti ad ostacoli ricordandoci la celebre scena di ET, un ciclista che ha la maglia gialla e la bandana rossa e ci piace pensare che sia un ricordo per l'indimenticato Pirata Pantani. Tutti dolcissimi. Centinaia le persone tra il pubblico (nonostante le sedute scomodissime), una vera folla oceanica, impressionante massa.
Ancora in aria e fluttuante è stata "La città sospesa" installazione del gruppo Flash Art a conclusione di un interessante laboratorio tra genitori e figli sulla "costruzione" della loro casa ideale: decine e decine di case, addobbate, disegnate, dipinte, con le finestre di ogni colore e forma, illuminate da dentro, mosse leggermente dal vento della sera, erano appese, come palle di Natale, alle fronde di un grande albero che ricordava quello della Cuccagna o ancora quello dove fu impiccato Pinocchio. Sembrano casette per uccellini, dondolano, fremono al passaggio, tremano; sono i sogni dei bambini che vedono nella casa la famiglia, la sicurezza, la protezione, un nido dal quale partire per poi farvi ritorno. Una favola in piena città. Come l'Alpe Adria Puppet.
Tommaso Chimenti 04/09/2019
Un "Menelao" azzoppato alla ricerca della risata facile
BOLOGNA – Del Teatrino Giullare abbiamo sempre apprezzato lo stile artigianale, le idee feconde, le ombre fervide, le costruzioni di giochi scenici illuminanti e disarmanti nell'incastro obliquo tra attori e manichini fino a perdersi gli uni negli altri, fino a scambiarsi e confondersi, in quel sottile filo di fondo giocoso e inquietante che faceva delle loro messinscene parentesi cult originali nella drammaturgia italiana contemporanea. Fin dall'esplosivo ed eccezionale, e ancora ricordato e menzionato nei foyer, “Finale di partita” da Beckett, una partitura ritmata e ridotta, che la esaltava, su una scacchiera, passando per “Alla meta” di Bernhard o l'oscuro pinteriano “La stanza” (mentre “Le amanti” della Jelinek e “Coco” ci lasciarono dubbiosi), il duo Giullare (da Sasso Marconi) hanno costruito uno stile riconoscibile, incarnando una cifra solida personale. L'attesa per questo “Menelao”, testo (fragile e non convincente) di Davide Carnevali e produzione Ert Fondazione, era tanta, spettacolo inserito anche nel prossimo festival “Vie”. L'ironia però, possiamo dirlo, non è per loro il miglior terreno di battaglia sul quale argomentare, muoversi, lasciar correre le loro visioni, le loro ombre, la loro dimensione onirica.
Il progetto nasce e si dipana dalla domanda esistenziale centrale dell'uomo che ha tutto, appunto Menelao, fulgido, potente, vittorioso, amato da una donna bellissima, ricco, eppure insoddisfatto cronico, sente che gli manca qualcosa ma non sa decodificarla. “Ha tutto ed è infelice e non sa perché” e “Cerca di risolvere un problema che non esiste” ed è proprio il non aver più niente da prendere e conquistare che lo prosciuga, lo azzera, lo svuota, senza più orizzonti né obbiettivi da raggiungere, è un corpo che non freme più, corazza senza un'anima che gli vibri dentro. Se l'incipit è altamente interessante e lascia aperte finestre e lancia possibilità, riflessioni filosofiche e digressioni, non altrettanto si può dire sulla messinscena che da un lato prevede manichini e pupazzi di dimensioni mignon e in questo lo spazio (il ridotto dell'Arena del Sole) non aiuta affatto: siamo troppo lontani per apprezzarne movimenti e sfumature e tutto si perde in un indistinto fondale; dall'altro le vocine infantili che accompagnano i personaggi, quasi da teatro ragazzi didascalico e sottolineante, ci allontanano dalla dimensione mitologica e ovattata e da quell'attacco così poderoso, energico, tragico.
Il  conflitto senza soluzione tra la domanda perno e quello che avviene successivamente sulla scena è palese con inutili inserti contemporanei, il telefono, i giornali, l'analista, la pistola, che ci portano altrove o con un linguaggio che strizza l'occhio al gergo giovanile di strada con svariate interlocuzioni slang volgari che stonano, ridicolizzano i personaggi facendone banali e buffe macchiette da beffa, da risatina sottobanco semiseria. Tre i piani che si sovrappongono, tre i palchi accatastati
conflitto senza soluzione tra la domanda perno e quello che avviene successivamente sulla scena è palese con inutili inserti contemporanei, il telefono, i giornali, l'analista, la pistola, che ci portano altrove o con un linguaggio che strizza l'occhio al gergo giovanile di strada con svariate interlocuzioni slang volgari che stonano, ridicolizzano i personaggi facendone banali e buffe macchiette da beffa, da risatina sottobanco semiseria. Tre i piani che si sovrappongono, tre i palchi accatastati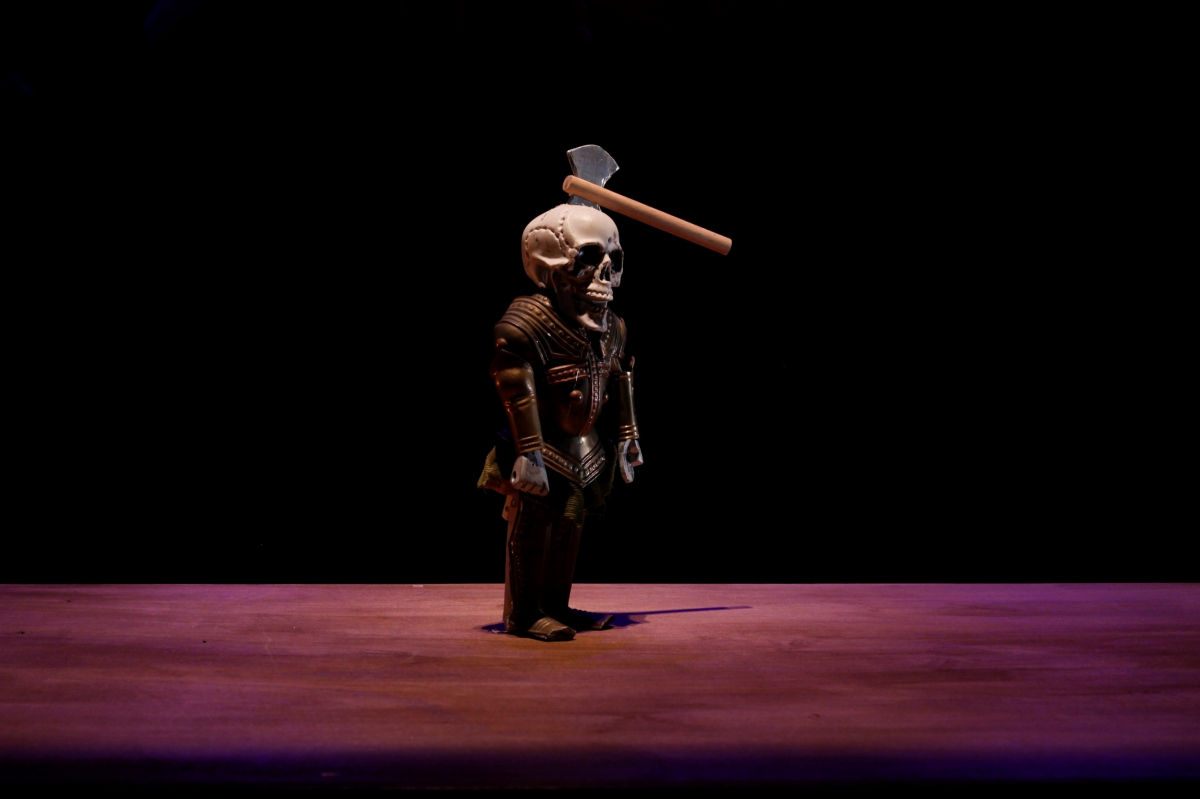 piramidali: la testa di Zeus (sembra la bocca della verità) dalla quale esce l'Idea-carillon, quello centrale con i burattini, e la teca sottostante, camera da letto-bara dove Menelao si ritrova con Elena scivolando in un dialogo-match battutistico alla Sandra e Raimondo desolante che solletica la pancia ma lascia assenti e svuotati. Ecco, si può dire che questo “Menelao” cerca più la risata facile che il senso ultimo, è più propenso e concentrato nel voler divertire ad ogni costo, senza riuscirci, e con ogni mezzo scontato, che a perseguire l'essenza profonda del canovaccio iniziale lavico. Ottimi i giochi di luce che però non risollevano il torpore acido e la delusione amara che sa di involuzione. Beckett, Bernhard e Pinter si confacevano maggiormente alle loro dinamiche, alla loro ricerca intima, a tutto quell'immaginario che riescono a creare, a materializzare che qui, purtroppo, esce schiacciato e compromesso, da una scrittura penalizzante, da un “contemporaneo” stucchevole che affossa e appesantisce. Ne usciamo perplessi.
piramidali: la testa di Zeus (sembra la bocca della verità) dalla quale esce l'Idea-carillon, quello centrale con i burattini, e la teca sottostante, camera da letto-bara dove Menelao si ritrova con Elena scivolando in un dialogo-match battutistico alla Sandra e Raimondo desolante che solletica la pancia ma lascia assenti e svuotati. Ecco, si può dire che questo “Menelao” cerca più la risata facile che il senso ultimo, è più propenso e concentrato nel voler divertire ad ogni costo, senza riuscirci, e con ogni mezzo scontato, che a perseguire l'essenza profonda del canovaccio iniziale lavico. Ottimi i giochi di luce che però non risollevano il torpore acido e la delusione amara che sa di involuzione. Beckett, Bernhard e Pinter si confacevano maggiormente alle loro dinamiche, alla loro ricerca intima, a tutto quell'immaginario che riescono a creare, a materializzare che qui, purtroppo, esce schiacciato e compromesso, da una scrittura penalizzante, da un “contemporaneo” stucchevole che affossa e appesantisce. Ne usciamo perplessi.
Tommaso Chimenti 20/02/2019
"Arrivano dal mare": non chiamateli pupazzi, i burattini hanno un'anima
RAVENNA – Sarebbe troppo semplice definire il burattino un pezzo di legno inanimato. E sarebbe alquanto sbagliato descrivere il connubio tra il burattinaio e il pupazzo dipingendolo come un uomo e il suo strumento di lavoro. Qui non si tratta di unire carne e sangue al legno. Da quell'innesto nasce la magia, la poesia, qualcosa di difficilmente riproducibile, ne sgorga polvere di stelle in un unico, indissolubile legame tra la pelle, che presta il suo movimento, e la stoffa che si anima, prende vita e colore, assume un'anima, una coscienza, una consapevolezza, diventa un essere a sé stante, con le sue ambizioni e pulsioni, gioie e tensioni. Alchimia, non c'è altra parola per descrivere il filo che lega burattinaio e marionetta, due cose distanti che, sul palco nel momento dello spettacolo, si fondono senza più riuscire a capire dove comincia l'uno e dove finisce l'altro. In molti modi è declinabile il Teatro di Figura e il “Festival Internazionale Arrivano dal Mare” (titolo di questa edizione: GenerAzioni), rinnovato e rinvigorito dalla Famiglia Monticelli, grande longevità alla 43esima edizione (tra Ravenna, Cervia, Gambettola, Gatteo e Longiano), ce ne ha mostrato le varie sfumature e discipline in un ventaglio di proposte alte e popolari insieme: il filo, il cunto, i piedi, la mano, i disegni animati.
senza più riuscire a capire dove comincia l'uno e dove finisce l'altro. In molti modi è declinabile il Teatro di Figura e il “Festival Internazionale Arrivano dal Mare” (titolo di questa edizione: GenerAzioni), rinnovato e rinvigorito dalla Famiglia Monticelli, grande longevità alla 43esima edizione (tra Ravenna, Cervia, Gambettola, Gatteo e Longiano), ce ne ha mostrato le varie sfumature e discipline in un ventaglio di proposte alte e popolari insieme: il filo, il cunto, i piedi, la mano, i disegni animati.
Di solito quando diciamo che una cosa è fatta con i piedi intendiamo che è fatta male anche se con i piedi si danza sulle punte, si corre a perdifiato, si gioca a calcio. I piedi sono libertà, ma nel linguaggio comune sono bistrattati e messi sempre in secondo piano rispetto alle mani. Ad esempio tutti conoscono i nomi delle dita di una mano, mignolo, anulare, medio, indice e pollice, e pochi quelli dei piedi. Eccoli: alluce, illice, trillice, pondulo e mellino. Ma anche con i piedi è possibile fare molto, fare tanto, fare qualcosa di eccezionale come Laura Kibel con il suo sensibile “Va dove ti porta il piede” che riprende, parodiandolo, il successo della Tamaro, mostrandoci quante cose possono diventare alluci e  calcagni. Nessun feticismo. Decine le valige colorate sul palco ed ognuna delle quali contiene mondi e universi di personaggi e spettacoli. La Kibel, vera Maestra e artista di questa particolare branchia che ha un lato acrobatico, da ginnasta e circense, sciorina, facendo diventare i suoi piedi angeli e diavoli, un anziano sul ginocchio, un simpatico toreador spagnolo che lotta con un toro picassiano, che grazie alle note di Besame mucho riesce a trasformare la bandiera di McDonald che gli viene sventolata in faccia in quella del WWF. Spettacolare il parterre di pappagalli e tucani sudamericani come il Pulcinella arrestato dai Carabinieri (come non pensare prima a Pinocchio e poi al “Giudice” di De Andrè?), il direttore d'orchestra dai capelli a pagliaio e le mani gigantesche come il clown a metà strada tra Profondo Rosso, ispirato all'It di Stephen King, e i Simpson, suggerito da Krusty. Un lavoro intelligente.
calcagni. Nessun feticismo. Decine le valige colorate sul palco ed ognuna delle quali contiene mondi e universi di personaggi e spettacoli. La Kibel, vera Maestra e artista di questa particolare branchia che ha un lato acrobatico, da ginnasta e circense, sciorina, facendo diventare i suoi piedi angeli e diavoli, un anziano sul ginocchio, un simpatico toreador spagnolo che lotta con un toro picassiano, che grazie alle note di Besame mucho riesce a trasformare la bandiera di McDonald che gli viene sventolata in faccia in quella del WWF. Spettacolare il parterre di pappagalli e tucani sudamericani come il Pulcinella arrestato dai Carabinieri (come non pensare prima a Pinocchio e poi al “Giudice” di De Andrè?), il direttore d'orchestra dai capelli a pagliaio e le mani gigantesche come il clown a metà strada tra Profondo Rosso, ispirato all'It di Stephen King, e i Simpson, suggerito da Krusty. Un lavoro intelligente.
Piccolo e gentile quanto affascinante e vintage è il mini carrozzone del norvegese Teater Fusentast dove, per quattro spettatori alla volta immersi in una sorta di cannocchiale, al suo interno si svolgono le vicende del “Parisian pillow case”, ovvero il caso del cuscino parigino. E' una storia semplice di amore e nostalgia per le cose vecchie ma che hanno importanza anche se non hanno valore, passando per una critica all'arte contemporanea e alla stupidità delle mode e di come gli esseri umani possano essere influenzabili. Un uomo che, durante un viaggio a
Ci sono incontri che cambiano la vita o almeno mutano la percezione del reale, delle prospettive, delle priorità. E la marionetta riesce sempre, con la sua plasticità e ingenuità, e rimettere le cose a posto, a rintracciare i fili, far capire le dinamiche, cercare traiettorie più vere. E' la storia di Horacio Peralta, rocambolesca e avventurosa, dall'Argentina passando per Panama, approdando a Parigi, girovagando con la sua valigia di personaggi, ed oggi stanziale a Valencia. Che poi “Il Burattinaio”, il titolo del suo spettacolo che riassume la sua vita artistica e personale, inevitabilmente intrecciate, non può essere stanziale e sedentario in un unico luogo, deve andare, muoversi, ce l'ha nel dna il movimento, a volte  la fuga. Horacio ci parla di amore per la vita, del lasciarsi andare all'oggi, del prendere da ogni casuale incontro, del sapere vedere la fortuna ad ogni bivio, di abbracciare il domani con ottimismo, lui scappato dalla dittatura argentina diretto a Panama con pochi averi. In un continuo palleggiarsi tra la vita reale, i suoi ricordi, le sue memorie, e le figure da lui ideate, che si affacciano sul palco, presentandosi e prendendo forma, ci fa conoscere Maria e Pier due personaggi che Horacio ha fatto vivere lavorando nelle carrozze del metrò nei freddi inverni parigini. E' quest'arte d'arrangiarsi che fa in modo di trovare soluzioni e nuove direzioni, senza mai fermarsi, senza mai abbandonare, senza mai mollare o sentirsi sconfitti o demoralizzati. Ripercorre la sua vita, che è la sua carriera, di personaggi stralunati e teneri come lo scultore o come il dolcissimo mostro peloso, simile ad uno struzzo, che s'imbatte in una sua simile e scatta l'amore a prima vista. Pupazzi che hanno un'anima come il suo “Idiota” scimmiesco e stupido che si ribella al suo creatore e richiede un'autonomia tutta sua, come la “Vecchia” che sta sempre in una scatola e quando esce non ne vuol sapere di rientrarvi, protestando e mettendo in dubbio le facoltà intellettive e “psichiche” del burattinaio in uno sdoppiamento della personalità che apre la porta a molte riflessioni. Infine “La Morte” che ci lascia con quelle che potrebbero essere le parole che meglio riescono a descrivere la vita di Horacio: “Buon viaggio, approfittatene”. Una leggerezza profonda ci pervade, commozione e riso si mischiano.
la fuga. Horacio ci parla di amore per la vita, del lasciarsi andare all'oggi, del prendere da ogni casuale incontro, del sapere vedere la fortuna ad ogni bivio, di abbracciare il domani con ottimismo, lui scappato dalla dittatura argentina diretto a Panama con pochi averi. In un continuo palleggiarsi tra la vita reale, i suoi ricordi, le sue memorie, e le figure da lui ideate, che si affacciano sul palco, presentandosi e prendendo forma, ci fa conoscere Maria e Pier due personaggi che Horacio ha fatto vivere lavorando nelle carrozze del metrò nei freddi inverni parigini. E' quest'arte d'arrangiarsi che fa in modo di trovare soluzioni e nuove direzioni, senza mai fermarsi, senza mai abbandonare, senza mai mollare o sentirsi sconfitti o demoralizzati. Ripercorre la sua vita, che è la sua carriera, di personaggi stralunati e teneri come lo scultore o come il dolcissimo mostro peloso, simile ad uno struzzo, che s'imbatte in una sua simile e scatta l'amore a prima vista. Pupazzi che hanno un'anima come il suo “Idiota” scimmiesco e stupido che si ribella al suo creatore e richiede un'autonomia tutta sua, come la “Vecchia” che sta sempre in una scatola e quando esce non ne vuol sapere di rientrarvi, protestando e mettendo in dubbio le facoltà intellettive e “psichiche” del burattinaio in uno sdoppiamento della personalità che apre la porta a molte riflessioni. Infine “La Morte” che ci lascia con quelle che potrebbero essere le parole che meglio riescono a descrivere la vita di Horacio: “Buon viaggio, approfittatene”. Una leggerezza profonda ci pervade, commozione e riso si mischiano.
Una vera lectio magistralis è quella che intavola invece Mimmo Cuticchio, voce imponente tenorile così come la figura che incute rispetto e autorevolezza, voce solida gassmaniana, barba da Mangiafoco, è deciso e intenso, ha carisma, potenza, presenza. E' un viaggio il suo a ritroso nelle origini della sua famiglia, nella Sicilia degli anni '50, '60 e '70, ma anche un caleidoscopio per capire l'arte, il teatro, le sue trasformazioni sociali durante il dopoguerra, mentre l'Italia stava cambiando grazie al cinema, alla televisione, al turismo. Siamo in una chiesa, consacrata, ed è affollata come difficilmente lo sono questi luoghi la domenica. Starlo a sentire è una gioia per le orecchie. Un uomo che si è fatto da solo, che ha messo a frutto gli insegnamenti, sul campo, del padre e di un Maestro. Cuticchio, qui senza pupi, nel suo circolare “recitar cantando”, ad occhi chiusi, nella sua armoniosa voce dei carrettieri, ora rude altre enfatica, con quei colpi di spada nell'aria e a terra con il piede da far risvegliare i morti da far rimbombare le pareti e l'anima, la rottura sincopata in apnea delle frasi, ci racconta dei genitori e dei sette fratelli, di una gioventù sul palco, a montarlo, recitarci, dormirci, dei 371 canovacci e trame su Carlo Magno e i Paladini di Francia nei quali il padre aveva suddiviso le gesta eroiche, dei 400 pupi che avevano appesi alle pareti. L'arrivo dei Cuticchio nei paesini, quando cinema e tv non c'erano, era un appuntamento atteso tutto l'anno, come una soap anni '80, come una fiction anni '90, come una serie tv d'oggi. Nelle sue parole c'è la storia del teatro ma anche quella sociologica di un Paese che stava uscendo dalla miseria. Dopo tanto girovagare i Cuticchio tornano a Palermo stanziali perché i pupi non attirano più nei piccoli centri soppiantati dalla televisione ma anche da biliardini, flipper e juke box che attirano i più giovani. Una sconfitta che diventa rinascita e possibilità: a Palermo i Cuticchio attirano i turisti, siamo nei '70, che arrivano da tutto il mondo. Ma i turisti, soprattutto i tour operator, anche se alle origini, chiedono ai pupari di portare in scena sempre lo stesso copione. Il giovane Mimmo invece vuole recuperare la tradizione e non si accontenta dei biglietti garantiti dai turisti. Dopo una lite generazionale con il padre, Mimmo lascia la famiglia e incontra Don Peppino Celano, ultimo cuntista, drammaturgo e costruttore di pupi. I due aedi cominciano un'alleanza, una ditta che vede il giovane Mimmo carpire e “rubare” i segreti della scena a Don Peppino fino all'investitura con lo spadino del '700 (che Cuticchio tutt'oggi usa nei suoi spettacoli) regalatogli proprio dal Maestro che segna il vero e proprio passaggio di consegne. Una fortuna avere la possibilità di stare ad ascoltarlo, la bocca aperta e gli occhi sgranati.
autorevolezza, voce solida gassmaniana, barba da Mangiafoco, è deciso e intenso, ha carisma, potenza, presenza. E' un viaggio il suo a ritroso nelle origini della sua famiglia, nella Sicilia degli anni '50, '60 e '70, ma anche un caleidoscopio per capire l'arte, il teatro, le sue trasformazioni sociali durante il dopoguerra, mentre l'Italia stava cambiando grazie al cinema, alla televisione, al turismo. Siamo in una chiesa, consacrata, ed è affollata come difficilmente lo sono questi luoghi la domenica. Starlo a sentire è una gioia per le orecchie. Un uomo che si è fatto da solo, che ha messo a frutto gli insegnamenti, sul campo, del padre e di un Maestro. Cuticchio, qui senza pupi, nel suo circolare “recitar cantando”, ad occhi chiusi, nella sua armoniosa voce dei carrettieri, ora rude altre enfatica, con quei colpi di spada nell'aria e a terra con il piede da far risvegliare i morti da far rimbombare le pareti e l'anima, la rottura sincopata in apnea delle frasi, ci racconta dei genitori e dei sette fratelli, di una gioventù sul palco, a montarlo, recitarci, dormirci, dei 371 canovacci e trame su Carlo Magno e i Paladini di Francia nei quali il padre aveva suddiviso le gesta eroiche, dei 400 pupi che avevano appesi alle pareti. L'arrivo dei Cuticchio nei paesini, quando cinema e tv non c'erano, era un appuntamento atteso tutto l'anno, come una soap anni '80, come una fiction anni '90, come una serie tv d'oggi. Nelle sue parole c'è la storia del teatro ma anche quella sociologica di un Paese che stava uscendo dalla miseria. Dopo tanto girovagare i Cuticchio tornano a Palermo stanziali perché i pupi non attirano più nei piccoli centri soppiantati dalla televisione ma anche da biliardini, flipper e juke box che attirano i più giovani. Una sconfitta che diventa rinascita e possibilità: a Palermo i Cuticchio attirano i turisti, siamo nei '70, che arrivano da tutto il mondo. Ma i turisti, soprattutto i tour operator, anche se alle origini, chiedono ai pupari di portare in scena sempre lo stesso copione. Il giovane Mimmo invece vuole recuperare la tradizione e non si accontenta dei biglietti garantiti dai turisti. Dopo una lite generazionale con il padre, Mimmo lascia la famiglia e incontra Don Peppino Celano, ultimo cuntista, drammaturgo e costruttore di pupi. I due aedi cominciano un'alleanza, una ditta che vede il giovane Mimmo carpire e “rubare” i segreti della scena a Don Peppino fino all'investitura con lo spadino del '700 (che Cuticchio tutt'oggi usa nei suoi spettacoli) regalatogli proprio dal Maestro che segna il vero e proprio passaggio di consegne. Una fortuna avere la possibilità di stare ad ascoltarlo, la bocca aperta e gli occhi sgranati.
Tommaso Chimenti 24/09/2018
Libro della settimana
-
 "Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…











