“Ago” il ritratto commovente di Ariele Vincenti per Agostino Di Bartolomei
ROMA – “Enjoy the silence”, cantavano i Depeche Mode, anche se qui, in questa storiaccia non soltanto romana, c'è poco da godere. Perché Agostino Di Bartolomei non era soltanto un giocatore e non era solo un calciatore della Roma, era un patrimonio del calcio e dell'Italia ma, ampliando lo sguardo e il respiro, un patrimonio delle brave persone, di quelle sensibili, di quelle schive e introverse, parole che oggi suonano quasi come offese perché dobbiamo essere tutti iperesposti, sovradimensionati, esageratamente, in foto, nei video, nelle pose sparate. Agostino era un  ragazzo cresciuto a Roma, un ragazzo di quartiere che però crescendo, accanto al pallone, si era appassionato di libri e di arte e che apriva bocca se aveva qualcosa di intelligente da dire, altrimenti se ne restava volentieri in silenzio. “Il silenzio è una discussione portata avanti con altri mezzi”, battagliava Che Guevara. Ecco il perno di tutto lo spettacolo di Ariele Vincenti, convincente e solido come sempre proprio perché racconta soltanto quello che gli appartiene e ciò che gli si muove attorno, accanto, dentro. Ariele (ha nel nome il germe del teatro, Ariel come il personaggio de “La Tempesta” shakespeariana), con la maglia targata Barilla dell'epoca, è uno vero, sincero, onesto con i propri valori e con il suo pubblico che è popolare e fatto non tanto di addetti ai lavori ma di gente comune che si appassiona alle sue storie e ne riconosce il marchio di genuinità, con trasporto, entusiasmo.
ragazzo cresciuto a Roma, un ragazzo di quartiere che però crescendo, accanto al pallone, si era appassionato di libri e di arte e che apriva bocca se aveva qualcosa di intelligente da dire, altrimenti se ne restava volentieri in silenzio. “Il silenzio è una discussione portata avanti con altri mezzi”, battagliava Che Guevara. Ecco il perno di tutto lo spettacolo di Ariele Vincenti, convincente e solido come sempre proprio perché racconta soltanto quello che gli appartiene e ciò che gli si muove attorno, accanto, dentro. Ariele (ha nel nome il germe del teatro, Ariel come il personaggio de “La Tempesta” shakespeariana), con la maglia targata Barilla dell'epoca, è uno vero, sincero, onesto con i propri valori e con il suo pubblico che è popolare e fatto non tanto di addetti ai lavori ma di gente comune che si appassiona alle sue storie e ne riconosce il marchio di genuinità, con trasporto, entusiasmo.
Questo suo “Ago. Capitano coraggioso” (visto al Teatro di Villa Lazzaroni), dedicato alla memoria e a ricordare quel numero 10 giallorosso mai scordato e dalla fine così tragica, fortunatamente non ha replicato soltanto a Roma e nel Lazio (in un verace romanesco, ma comprensibilissimo) ma delle sue, per adesso, quaranta repliche molte sono state messe in scena fuori dai confini regionali, e questo ha dato una grande  dignità al lavoro che non si è chiuso in steccati faziosi di colori calcistici o in stupidi recinti linguistici o dialettali o ancora in reticolati provinciali. Si racconta la storia di un uomo, non di un calciatore. Un uomo che aveva coronato il suo sogno di giocare a calcio e di farlo per quella maglia che, fin da piccolo, aveva agognato, idolatrato, sognato: la Roma, la sua Roma. La fama e i soldi non lo avevano cambiato. Il suo pregio più grande era l'umiltà, low profile si direbbe oggi. E quel “Silenzio”, che campeggia nello striscione dietro Vincenti per tutto il tempo dello spettacolo, è quella quiete che ha usato come arma Agostino nella sua vita contro le banalità ipocrite del sistema e quel silenzio che siamo stati costretti a sentire con la sua mancanza e ancora quel silenzio pudico e rispettoso che tutti hanno dovuto ad un uomo sensibile che la vita aveva compresso e schiacciato come pentola a pressione.
dignità al lavoro che non si è chiuso in steccati faziosi di colori calcistici o in stupidi recinti linguistici o dialettali o ancora in reticolati provinciali. Si racconta la storia di un uomo, non di un calciatore. Un uomo che aveva coronato il suo sogno di giocare a calcio e di farlo per quella maglia che, fin da piccolo, aveva agognato, idolatrato, sognato: la Roma, la sua Roma. La fama e i soldi non lo avevano cambiato. Il suo pregio più grande era l'umiltà, low profile si direbbe oggi. E quel “Silenzio”, che campeggia nello striscione dietro Vincenti per tutto il tempo dello spettacolo, è quella quiete che ha usato come arma Agostino nella sua vita contro le banalità ipocrite del sistema e quel silenzio che siamo stati costretti a sentire con la sua mancanza e ancora quel silenzio pudico e rispettoso che tutti hanno dovuto ad un uomo sensibile che la vita aveva compresso e schiacciato come pentola a pressione.
La sua parabola sa di discesa agli inferi: il sogno della serie A, il desiderio realizzato di giocare per la sua città, per la sua squadra del cuore, l'ambizione compiuta di farsi capitano e responsabile di quei colori. Sembra una fiaba a lieto fine, di quelle da e tutti vissero felici e contenti. Oltre dieci anni alla Roma, le Coppe Italia e addirittura uno scudetto. Dove sta la fregatura? Arriva nel momento più doloroso, dopo la finale di Coppa Campioni (si chiamava ancora così perché vi partecipavano soltanto chi aveva vinto lo scudetto in patria) persa in casa  (ancora più luttuoso) dopo i terribili e strazianti rigori contro il Liverpool (30 maggio '84), viene ceduto al Milan, dove giocherà per tre anni. Fu proprio un suo gol, con sonora esultanza, contro la sua Roma che scatenò l'odio cittadino verso quel figlio adesso ripudiato. Dal Milan ancora un gradino sotto al Cesena e poi ancora più giù in serie C alla Salernitana. A fine carriera lasciato il calcio lascia anche Roma per stabilirsi in un paesino della Campania, il tracollo è definitivo, il viaggio verso l'abisso è compiuto, concluso. Da lì allo sparo passeranno poche stagioni (30 maggio '94, 10 anni esatti dopo quella finale!)
(ancora più luttuoso) dopo i terribili e strazianti rigori contro il Liverpool (30 maggio '84), viene ceduto al Milan, dove giocherà per tre anni. Fu proprio un suo gol, con sonora esultanza, contro la sua Roma che scatenò l'odio cittadino verso quel figlio adesso ripudiato. Dal Milan ancora un gradino sotto al Cesena e poi ancora più giù in serie C alla Salernitana. A fine carriera lasciato il calcio lascia anche Roma per stabilirsi in un paesino della Campania, il tracollo è definitivo, il viaggio verso l'abisso è compiuto, concluso. Da lì allo sparo passeranno poche stagioni (30 maggio '94, 10 anni esatti dopo quella finale!)
Esemplare e significativo che giocasse con il numero del trequartista, il dieci, ma facesse il libero, giocasse in difesa, una contraddizione in quegli anni di numeri rigidi e di schemi fissi; e viene in mente la battuta finale, che poi darà il titolo alla pellicola, “Anche libero va bene”, di Kim Rossi Stuart, del bambino detta al padre. Ed è emblematico il suo soprannome-diminutivo, che poi dà il nome all'avvincente piece di Ariele Vincenti, “Ago” che sa di esplosione, di bucare la bolla costruita attorno alle menzogne che il calcio alimenta colpevolmente, il money facile, la gente che ti vede come un semidio, che bacia la terra che calpesti, che ti cerca, ti esalta per poi sostituirti con altri volti, altri calciatori più giovani, e ti dimentica, ti posiziona tra le figurine nostalgiche. Di Bartolomei in definitiva era un uomo deluso da come era andato il suo percorso, calcistico e vitale,  depresso proprio perché emarginato dal mondo del pallone, che era, fin da piccolo, tutto il suo mondo. Lui che, in maniera romantica (anche scomponibile in Roma-antica), voleva soltanto giocare a calcio come aveva fatto in strada fin da ragazzo. E i calciatori, si sa, rimangono sempre un po' eterni bambini e la chiusura della carriera è sempre drammatica. Totti, con il microfono in mano in uno stadio Olimpico piangente nel suo addio al calcio, disse: “Concedetemi un po’ di paura e stavolta sono io che ho bisogno del vostro aiuto e del vostro calore”. Ecco forse quell'aiuto e quel calore dei quali aveva tremendamente bisogno anche Ago che si è sentito abbandonato ma che non ha saputo chiedere se non con quel gesto finale.
depresso proprio perché emarginato dal mondo del pallone, che era, fin da piccolo, tutto il suo mondo. Lui che, in maniera romantica (anche scomponibile in Roma-antica), voleva soltanto giocare a calcio come aveva fatto in strada fin da ragazzo. E i calciatori, si sa, rimangono sempre un po' eterni bambini e la chiusura della carriera è sempre drammatica. Totti, con il microfono in mano in uno stadio Olimpico piangente nel suo addio al calcio, disse: “Concedetemi un po’ di paura e stavolta sono io che ho bisogno del vostro aiuto e del vostro calore”. Ecco forse quell'aiuto e quel calore dei quali aveva tremendamente bisogno anche Ago che si è sentito abbandonato ma che non ha saputo chiedere se non con quel gesto finale.
Questo monologo dovrebbero vederlo i suoi ex compagni di squadra, Conti, Pruzzo, Graziani, e tutti i romanisti e tutti gli appassionati di calcio e gli appassionati di sport e anche quelli che in uno stadio non ci sono mai entrati e quelli che Di Bartolomei non sanno neanche chi sia. Le parole dolorose di questo straordinario affabulatore (andate a cercarvi nei teatri anche altri suoi lavori come “Le Marocchinate” o “La tovaglia di Trilussa”) vanno assaporate fino in fondo, fino all'amaro che ti lasciano, insieme alle lacrime, uscendo. Era un calcio diverso, meno muscolare e meno fisico, con meno tatuaggi e meno simulazioni, con meno pose ad uso delle telecamere e meno meches e brand e sponsor. Agostino ci insegnava con il suo calcio pulito l'attaccamento alla maglia, il rispetto delle regole e dell'avversario. E adesso rimane solo quel gigantesco, divorante assordante silenzio che è un'occasione per ascoltare perché “è nel silenzio che accadono le cose”. Se siete pronti a commuovervi questo è il vostro spettacolo. E oggi, come ieri, c'è sempre bisogno di commuoversi per riequilibrarsi internamente, per ripulirsi da tante inutili parole, per cercare un respiro e una pace nuova.
Tommaso Chimenti 20/11/2022
"Il rigore che non c'era": il penalty sbagliato da Federico Buffa
SCANDICCI – Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Non è esente da questo proverbio Federico Buffa, volto di Sky con le sue narrazioni piene di enfasi, pathos ed empatia, che, da qualche tempo sbarcato a teatro, non è riuscito a bissare i successi delle “Olimpiadi del '36” né di “A night in Kinshasa”. La differenza salta agli occhi, cantava De Gregori. Se nei primi due spettacoli di story telling e affabulazione c'era un tema solido e portante lungo tutto l'arco della drammaturgia, i Giochi nazisti e Jesse Owens il primo, l'incontro del secolo tra Alì e Foreman il secondo, infarciti con interessanti divagazioni geografico, politico, culturali e di costume, che davano quel tocco di colore e spinta, brio e brividi alle sue parole calde, in questo nuovo “Il rigore che non c'era” l'intreccio è debole, il plot è fragile e la costruzione narrativa che lo supporta praticamente inesistente. Non è deficitaria, è proprio mancante. E si sente anche nel pubblico questo gap, questo quid che non è stato colmato e più  va avanti nelle sue iperbole più capiamo che la serata sarà una sequela di aneddotica da almanacco, una sequenza di curiosità da “Non tutti sanno che” della Settimana Enigmistica. Per carità, adesso sappiamo perché si gioca in undici a calcio o perché Manhattan si chiami proprio così, ma non basta, non può bastare. L'attinenza con il titolo poi decade dopo i primi dieci minuti quando, appunto, l'argomento che avrebbe dovuto essere trainante si esaurisce.
va avanti nelle sue iperbole più capiamo che la serata sarà una sequela di aneddotica da almanacco, una sequenza di curiosità da “Non tutti sanno che” della Settimana Enigmistica. Per carità, adesso sappiamo perché si gioca in undici a calcio o perché Manhattan si chiami proprio così, ma non basta, non può bastare. L'attinenza con il titolo poi decade dopo i primi dieci minuti quando, appunto, l'argomento che avrebbe dovuto essere trainante si esaurisce.
L'escamotage di fondo che lega le varie gag e numeri, trovata per niente originale e abusata, è quello che ci troviamo in una sorta di limbo post mortem con due personaggi millenari (un attore, Marco Caronna bravo nel tentare di legare un quadro all'altro, nella regia invece pecca, e un pianista, Alessandro Nidi, virtuoso d'atmosfere che ci ha ricordato Novecento) che se ne stanno lì aspettando il Godot-Buffa da tempo immemore e che finalmente è giunto. Tu chiamalo, se vuoi, Messia. Una parentesi dalla quale si può solo entrare ma non si può uscire. “Meno male che sei arrivato tu”, lo incensano, lo investono di responsabilità, lo innalzano, lo esaltano. Less is more. La platea si aspetta storie legate al calcio, a qualche rigore che ha fatto storia, invece ci spostiamo vorticosamente da Comunardo Niccolai, difensore re delle autoreti, ai Beatles a Sonny Liston, a El Loco Houseman, ala destra argentina affezionato più alla bottiglia che ai dribbling sulla fascia. Ma il frullatore continua concentrico, il mosaico si arricchisce di nuovi sapori, sempre più disparati il che fa diventare sempre più arduo trovare un filo conduttore.  Semplicemente non esiste.
Semplicemente non esiste.
Appaiono Kareem Abdul Jabbar, che di rigori non ne ha mai battuti, Garrincha e Muhammad Alì, Billie Holiday e Sammy Davis Jr, poi ci spostiamo sul Perù prima con Francisco Pizarro fino a Sendero Luminoso e l'affresco di accozzaglia è servito. Ogni tanto, 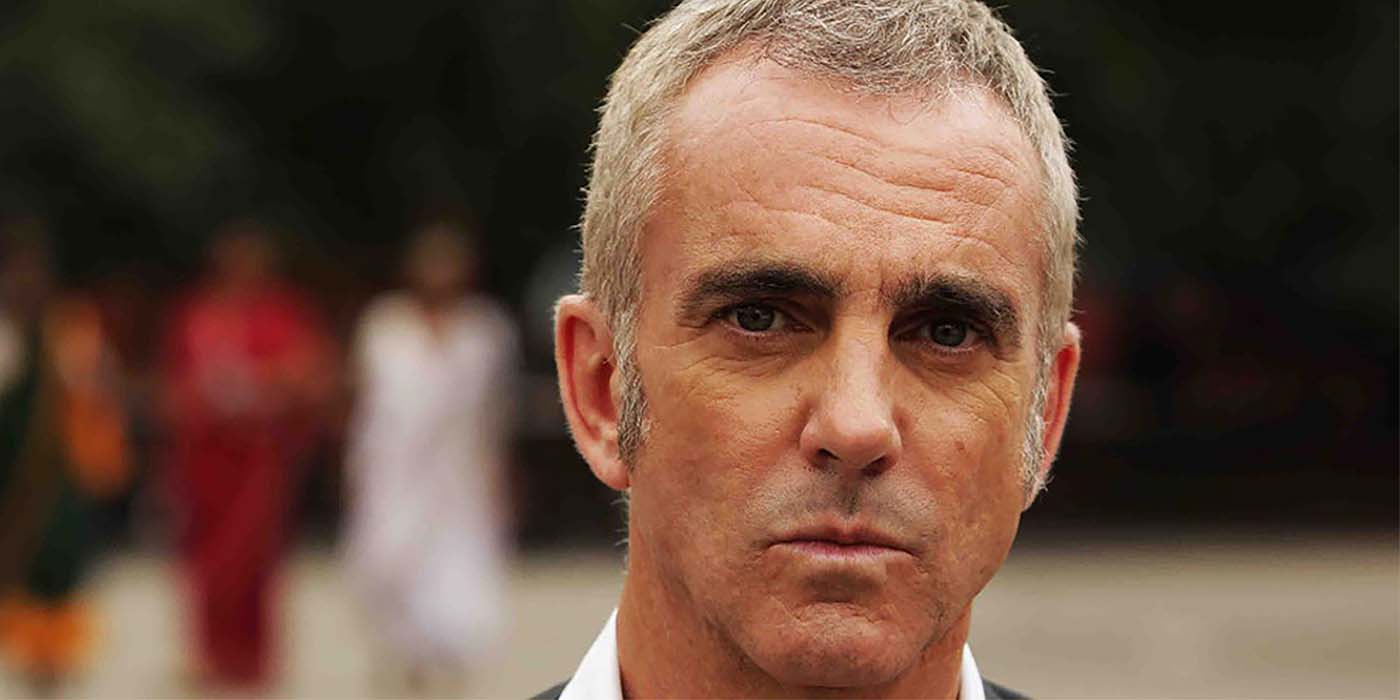 lateralmente, il discorso sembra scivolare sulla politica ma il tutto rimane in superficie, toccando molti punti senza analizzarli e senza andare a fondo veramente a nessuno di questi. Tutto sembra telefonato come un tiro floscio dal limite dell'area, di quelli che Sandro Ciotti avrebbe chiamato “di alleggerimento”. Ma non è finita qua, perché nel calderone finiscono Kennedy, evergreen che ci sta sempre bene e stuzzica le fantasie, e Jeff Buckley, gli ufo sopra l'Artemio Franchi nel '54 in occasione di Fiorentina-Pistoiese e Cristiano Ronaldo che la madre voleva abortire. Il focus non è centrato, anzi deborda e si scioglie, cade e sfora da ogni parte come sabbia in una mano. La cantante poi (Jvonne Giò), che ogni tanto vorrebbe arrivare a commuovere, è uno stop all'emozione, e, purtroppo, manca d'estensione (nel suo monologo finale non eccelle alzando i decibel). Per una facile commozione, di quelle che si sa già da prima da che parte stare, chi sono i buoni e chi i cattivi, eccovi sul piatto Hitler e Churchill, l'allunaggio del '69 e Paolo VI. Il guru questa volta non è riuscito ad indicarci la via. Il rigore non c'era, ma neanche lo spettacolo teatrale.
lateralmente, il discorso sembra scivolare sulla politica ma il tutto rimane in superficie, toccando molti punti senza analizzarli e senza andare a fondo veramente a nessuno di questi. Tutto sembra telefonato come un tiro floscio dal limite dell'area, di quelli che Sandro Ciotti avrebbe chiamato “di alleggerimento”. Ma non è finita qua, perché nel calderone finiscono Kennedy, evergreen che ci sta sempre bene e stuzzica le fantasie, e Jeff Buckley, gli ufo sopra l'Artemio Franchi nel '54 in occasione di Fiorentina-Pistoiese e Cristiano Ronaldo che la madre voleva abortire. Il focus non è centrato, anzi deborda e si scioglie, cade e sfora da ogni parte come sabbia in una mano. La cantante poi (Jvonne Giò), che ogni tanto vorrebbe arrivare a commuovere, è uno stop all'emozione, e, purtroppo, manca d'estensione (nel suo monologo finale non eccelle alzando i decibel). Per una facile commozione, di quelle che si sa già da prima da che parte stare, chi sono i buoni e chi i cattivi, eccovi sul piatto Hitler e Churchill, l'allunaggio del '69 e Paolo VI. Il guru questa volta non è riuscito ad indicarci la via. Il rigore non c'era, ma neanche lo spettacolo teatrale.
Tommaso Chimenti 16/03/2019
La fatica della bicicletta per capire quando sono "Tempi Maturi"
BOLOGNA – “La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili” (William Burroughs).
“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti” (Albert Einstein).
Il rumore delle ruote che scivolano sui cilindri, rimanendo in perfetto equilibrio dinamico, è il metronomo che fa rima con il battito del cuore, sono le virgole a questo flusso di coscienza che non conosce pause, è il misuratore di fatica e sudore che scansiona l'aria, che rimette in circolo endorfine, è la cadenza dei passi sempre più affrettati dentro il bosco della nostra esistenza, dentro la conoscenza di noi stessi. “Tempi maturi” (prod. Casa degli Alfieri, visto al Teatro delle Moline dell'Ert Fondazione a Bologna) ha una grande scrittura alle spalle e un grande interprete sul palco. Palcoscenico in questo caso è un eufemismo: Emanuele Arrigazzi, ottimo attore (qui performer per un'ora di pedalata sostenuta senza flessioni né cedimenti), è stato anche un buon ciclista dilettante, le sue gambe tradiscono questa sua prima passione, il quadricipite e il vasto mediale non mentono, gonfi, pompano, spingono senza sosta verso un traguardo che si sposta sempre un po' più in là, ad ogni passo.
pause, è il misuratore di fatica e sudore che scansiona l'aria, che rimette in circolo endorfine, è la cadenza dei passi sempre più affrettati dentro il bosco della nostra esistenza, dentro la conoscenza di noi stessi. “Tempi maturi” (prod. Casa degli Alfieri, visto al Teatro delle Moline dell'Ert Fondazione a Bologna) ha una grande scrittura alle spalle e un grande interprete sul palco. Palcoscenico in questo caso è un eufemismo: Emanuele Arrigazzi, ottimo attore (qui performer per un'ora di pedalata sostenuta senza flessioni né cedimenti), è stato anche un buon ciclista dilettante, le sue gambe tradiscono questa sua prima passione, il quadricipite e il vasto mediale non mentono, gonfi, pompano, spingono senza sosta verso un traguardo che si sposta sempre un po' più in là, ad ogni passo.
E' una corsa contro se stessi quella di Arrigazzi (corpose e piene le ombre create sul muro che sembrano altri sé che corrono al suo fianco, superandosi; le luci sono di Fabrizio Visconti) nei panni di un attore-ciclista che ha affrontato la vita per vincerla, per batterla, per combatterla, ma in fondo, e lui lo sa, non ha spinto fino al limite, non ha raschiato il barile, poteva dare di più e l'insoddisfazione, la frustrazione, il malessere deriva anche da questo, da quel quasi, dai tanti forse, dalla mancanza di decisione nei momenti che contavano come uno sprinter in volata sul traguardo.
 Come ne “La Maratona di NY” di Edoardo Erba, dove lì i due protagonisti corrono su un tapis roulant, come ne “Le regola del giuoco del tennis” di Mario Gelardi lo sport è il sottofondo, è l'azione mantra che mordicchia senza essere protagonista, è contesto e pretesto, cornice dentro la quale muoversi in gesti ripetitivi che creano un tappeto dentro il quale accordarsi, accomodarsi scomodi, movimenti che ritornano, che incantano, che trattengono.
Come ne “La Maratona di NY” di Edoardo Erba, dove lì i due protagonisti corrono su un tapis roulant, come ne “Le regola del giuoco del tennis” di Mario Gelardi lo sport è il sottofondo, è l'azione mantra che mordicchia senza essere protagonista, è contesto e pretesto, cornice dentro la quale muoversi in gesti ripetitivi che creano un tappeto dentro il quale accordarsi, accomodarsi scomodi, movimenti che ritornano, che incantano, che trattengono.
La bicicletta qui (grande lo sforzo fisico e la precisione, la dedizione e l'impegno di Arrigazzi) è sia compagno che aguzzino, sia confidente che avvoltoio, amico e sanguisuga che gli toglie le energie migliori. La bicicletta ha l'unica catena che ti rende libero. E' uno spettacolo non tanto sul ciclismo, nemmeno sullo sport, ma è un monologo sulla necessità di fare fatica, fatica come azione quotidiana per ripulirsi dai pensieri, fatica dosata per reggere meglio l'urto con l'oggi, fatica per essere più forti e più stanchi, più pronti e più tenaci. Ipnotizzano i raggi delle ruote che corrono come scorre il tempo sulle nostre rughe. Che poi i tempi non sono mai maturi oppure lo sono quando noi decidiamo di mettere un punto e cominciare a far sì che lo siano realmente invece di trascinarci tra mancate aspirazioni, cocenti delusioni, ambizioni fallite, chili di alibi, sensi di colpa senza prendersi le giuste responsabilità. Siamo noi stessi i primi grandi nostri nemici, ci freniamo, ci mettiamo i bastoni tra le ruote (appunto), ci fermiamo, ci facciamo paura.
“Tempi maturi” ci parla del cambiamento (dall'essere figlio a mettere al mondo un figlio, ad esempio), dei momenti di passaggio che vanno colti come papaveri di campo, di quegli attimi che è importante segnalare e selezionare, sottolineare e salvare nella nostra memoria, di tutti quegli scarti dove si percepisce chiaramente che gli ingranaggi hanno scattato all'unisono, di tutti quei crack che dentro di noi prima ci rompono per ricomporci più consapevoli. Ed il testo (scritto con abilità e cura, scelta delle parole e attenzione da Allegra de Mandato) è maschile e mascolino, muscolare e diretto che pare vergato da un uomo e allo stesso tempo presenta quella sensibilità delle cose perdute, dei margini sfuggiti, della non messa a fuoco, dell'impossibilità, della manchevolezza.
segnalare e selezionare, sottolineare e salvare nella nostra memoria, di tutti quegli scarti dove si percepisce chiaramente che gli ingranaggi hanno scattato all'unisono, di tutti quei crack che dentro di noi prima ci rompono per ricomporci più consapevoli. Ed il testo (scritto con abilità e cura, scelta delle parole e attenzione da Allegra de Mandato) è maschile e mascolino, muscolare e diretto che pare vergato da un uomo e allo stesso tempo presenta quella sensibilità delle cose perdute, dei margini sfuggiti, della non messa a fuoco, dell'impossibilità, della manchevolezza.
Mentre il protagonista corre, ininterrottamente in questo equilibrio precario, nel flusso del racconto di Arrigazzi (attore di razza, sempre concentrato e coriaceo ma anche permeabile alle emozioni che passano dalle parole sudate alle ruote e da queste al nostro ascolto sempre più partecipato: siamo tutti in bici con lui, tifiamo per lui, il nostro antieroe) si inseriscono dei piccoli sottocapitoli, capoversi illuminanti dove è percepibile il cambio di registro, la crescita dell'uomo anche grazie alle sconfitte, sempre mal digerite, alle cadute, mai accettate, ai lutti: si passa dai “Tempi Felici” di un passato recente, e ci sovvengono i giorni di Beckett, che diventano “Tempi Duri”, ci si impantana nei “Tempi Fermi” si  crede che i “Tempi stanno per cambiare”, si passa dagli agognati “Tempi di Guadagni” ai “Tempi Superficiali”, si incrociano i “Tempi d'attesa” pensando che siano ancora “Tempi Acerbi”, ed ancora i “Tempi Difficili” che lasciano il posto ai “Tempi di Confusione”, fin quando, finalmente, i “Tempi sono Maturi”. In questa grande galoppata, in questa cavalcata su quest'asfalto virtuale, passando dal lavoro dell'attore, gli amori leggeri, le piccole grandi prove che la vita ci pone davanti, la bicicletta (potremmo sostituirla con lo sport, la fatica, che è comunque prendersi cura, volersi bene, non lasciarsi scivolare nel torpore dell'oblio, dell'indifferenza) c'è sempre, come confronto con gli altri, termine di paragone, droga sana, palliativo, esigenza, tormento, necessità. Lo sport ti dice chi sei e a che punto sei, ti dice che se hai fatto molto non hai ancora fatto niente perché domani si ricomincia, ti dice che se molli non perdi contro gli altri ma perdi il rispetto di te stesso, ti dice che vincere o perdere vale ma vale di più dare tutto e sentirsi beatamente stanco e soddisfatto perché hai fatto il massimo. “Tempi maturi” è una dose di coraggio, è una spinta a non abbattersi, è un incentivo a pedalare anche quando non ce la fai più, anche quando, soprattutto, la salita si fa più ripida. I tempi sono maturi per vincersi, per battersi, per respirare: commovente.
crede che i “Tempi stanno per cambiare”, si passa dagli agognati “Tempi di Guadagni” ai “Tempi Superficiali”, si incrociano i “Tempi d'attesa” pensando che siano ancora “Tempi Acerbi”, ed ancora i “Tempi Difficili” che lasciano il posto ai “Tempi di Confusione”, fin quando, finalmente, i “Tempi sono Maturi”. In questa grande galoppata, in questa cavalcata su quest'asfalto virtuale, passando dal lavoro dell'attore, gli amori leggeri, le piccole grandi prove che la vita ci pone davanti, la bicicletta (potremmo sostituirla con lo sport, la fatica, che è comunque prendersi cura, volersi bene, non lasciarsi scivolare nel torpore dell'oblio, dell'indifferenza) c'è sempre, come confronto con gli altri, termine di paragone, droga sana, palliativo, esigenza, tormento, necessità. Lo sport ti dice chi sei e a che punto sei, ti dice che se hai fatto molto non hai ancora fatto niente perché domani si ricomincia, ti dice che se molli non perdi contro gli altri ma perdi il rispetto di te stesso, ti dice che vincere o perdere vale ma vale di più dare tutto e sentirsi beatamente stanco e soddisfatto perché hai fatto il massimo. “Tempi maturi” è una dose di coraggio, è una spinta a non abbattersi, è un incentivo a pedalare anche quando non ce la fai più, anche quando, soprattutto, la salita si fa più ripida. I tempi sono maturi per vincersi, per battersi, per respirare: commovente.
Tommaso Chimenti 13/02/2019
Andrea Muzzi ci racconta l'arte della sconfitta
FIRENZE – “In occidente non esiste la cultura del perdente, solo l’esaltazione del vincitore. Ma è nella sconfitta che si manifesta la gloria dell’uomo” (Leonard Cohen).
“Conosco un ciclista di Rovigo così sfortunato che quando stava per battere il record dell’ora di Moser è scattata l’ora legale” (Gene Gnocchi).
La Storia, si sa, la fanno i vincenti. Gli ultimi saranno i primi è ormai un vecchio motto ideato per far tacere e silenziare, con la paura dell'Aldilà, le masse povere e ignoranti. Gli ultimi saranno ultimi, è questa la triste verità. Ma c'è anche della poesia, della filosofia di vita, del pensiero strutturato in chi, per scelta o, nella maggior parte dei casi, per mancanza di talento o sfortuna, occupa gli ultimi spazi della graduatoria, o chi, peggio ancora, arriva sempre lì, talmente vicino da poter sfiorare la coppa agognata e, all'ultimo tuffo, all'ultimo balzo, all'ultimo tiro, fallisce, perde, arriva secondo, cade nel dimenticatoio, nell'anonimato o peggio nel catalogo di chi non ce l'ha fatta, di chi non ha avuto forza e “palle” per reggere la pressione o precisione per portare a casa il trofeo. Ci sta di perdere, certo, che perdere nella vita è la normalità mentre vincere è l'eccezione. Vince soltanto uno, tutti gli altri ne escono sconfitti. Gli “zeru tituli” che Mourinho imputava, con fierezza e arroganza (l'umiltà non è la qualità migliore della maggior parte dei vincenti, dei quali viene apprezzata anche la spregiudicatezza e la superbia: Ibrahimovic) alle altre squadre in lotta per lo scudetto. “We are the champions, no time for losers” (Queen, “We are the Champions”)
ultimi, è questa la triste verità. Ma c'è anche della poesia, della filosofia di vita, del pensiero strutturato in chi, per scelta o, nella maggior parte dei casi, per mancanza di talento o sfortuna, occupa gli ultimi spazi della graduatoria, o chi, peggio ancora, arriva sempre lì, talmente vicino da poter sfiorare la coppa agognata e, all'ultimo tuffo, all'ultimo balzo, all'ultimo tiro, fallisce, perde, arriva secondo, cade nel dimenticatoio, nell'anonimato o peggio nel catalogo di chi non ce l'ha fatta, di chi non ha avuto forza e “palle” per reggere la pressione o precisione per portare a casa il trofeo. Ci sta di perdere, certo, che perdere nella vita è la normalità mentre vincere è l'eccezione. Vince soltanto uno, tutti gli altri ne escono sconfitti. Gli “zeru tituli” che Mourinho imputava, con fierezza e arroganza (l'umiltà non è la qualità migliore della maggior parte dei vincenti, dei quali viene apprezzata anche la spregiudicatezza e la superbia: Ibrahimovic) alle altre squadre in lotta per lo scudetto. “We are the champions, no time for losers” (Queen, “We are the Champions”)
Certo Woodberry diceva che “la sconfitta non è il peggior fallimento. Non aver tentato è il peggior fallimento”. Però Martina Navratilova aveva un'altra visione della faccenda: "Chi dice che vincere o perdere non conta, probabilmente ha perso”. Fallire vuol comunque dire averci provato, ma provare, ormai, nel nostro mondo fatto tutto da sorrisi a mille denti, apparenti, e di gente felice che “racconta dei successi e dei fischi non parlarne mai”, come strimpellava Ron, non basta più. La gente, il pubblico, la platea, l'audience, anche solo di un social network adorano e adulano i primi della lista e denigrano chi non è salito sul gradino più alto del podio. Salire sul carro del vincitore, che da lì le cose, sotto, si vedono più minute e piccole, insignificanti nascoste, confuse nella massa indistinta dei volti che guardano su in alto. “Più su”, volteggiava Renato. “I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno ne vengono dieci” (Woody Allen)
“All'alba perderò” (visto al Teatro Puccini il 27 aprile), parodiando l'ugola di Pavarotti e Puccini, è l'elogio della sconfitta di Muzzi, attraverso casi più o meno celebri, di uomini resi ancora più umani e fallaci e per questo simpatici ai nostri occhi solidali. Dell'aria della Turandot però Muzzi estrapola e si sofferma su quel “tramontate stelle”, perché le star prima o poi cadono e non si può sempre stare in cima alla classifica e se non si comincia ad accettare la sconfitta il tonfo sarà ancora più sonoro e la depressione e la delusione ancor più cocente. Non si vince l'argento ma si è perso soltanto l'oro. E' la dura legge della giungla dove uno solo, nel branco, è il maschio alfa dominatore e inseminatore e gli altri devono fuggire. Ayrton Senna diceva che “arrivare secondo è essere il primo degli sconfitti”. I nomi dopo il primo non hanno cittadinanza, si afflosciano nel tempo, si sciolgono al sole. Ma siamo tutti perdenti, ogni giorno, in ogni momento, è per questo che, nelle rare occasioni in cui capita di vincere, esultiamo a perdifiato come se non ci fosse un domani. “Se qualcosa può andare storto, lo farà” (Legge di Murphy)
Nella semplice ma suggestiva scenografia, fatta di grucce che sembrano tergicristalli sospesi per cacciare via i sogni infranti, paiono oggetti volanti come nella “Fantasia” disneyana, gabbiani con le ali spiegate come i desideri infranti e volati via. Ecco il rigore di Baggio ai mondiali americani, tirato alle stelle. Ci ricordiamo più delle sconfitte, sono quelle che lasciano il brivido, il segno, la lacrima. Lo sconfitto è nel posto sbagliato al momento sbagliato. C'è il samoano lanciatore del peso che ai mondiali di atletica viene segnato nelle batterie dei 100 metri con tutto il suo armamentario di ciccia e muscoli da dover spostare sul lungo rettilineo, c'è il pugile sconfitto sempre alla prima ripresa con decine di ko sulle spalle, la squadra di bob jamaicana, il nuotatore della Nuova Guinea che aveva imparato a nuotare poco prima delle Olimpiadi di Sidney dove partecipò nello stile libero, il Brasile sconfitto in casa per 1 a 7 dalla Germania. “I vincitori sono sempre colpevoli, e va bene. Ma gli sconfitti, è sicuro che siano innocenti?” (Gesualdo Bufalino)
con le ali spiegate come i desideri infranti e volati via. Ecco il rigore di Baggio ai mondiali americani, tirato alle stelle. Ci ricordiamo più delle sconfitte, sono quelle che lasciano il brivido, il segno, la lacrima. Lo sconfitto è nel posto sbagliato al momento sbagliato. C'è il samoano lanciatore del peso che ai mondiali di atletica viene segnato nelle batterie dei 100 metri con tutto il suo armamentario di ciccia e muscoli da dover spostare sul lungo rettilineo, c'è il pugile sconfitto sempre alla prima ripresa con decine di ko sulle spalle, la squadra di bob jamaicana, il nuotatore della Nuova Guinea che aveva imparato a nuotare poco prima delle Olimpiadi di Sidney dove partecipò nello stile libero, il Brasile sconfitto in casa per 1 a 7 dalla Germania. “I vincitori sono sempre colpevoli, e va bene. Ma gli sconfitti, è sicuro che siano innocenti?” (Gesualdo Bufalino)
Ci sarebbe stato anche da raccontare del maratoneta Dorando Petri al quale fu tolta la medaglia d'oro nella 42 km alle Olimpiadi di Londra ad inizio secolo scorso perché sorretto dai giudici. Oppure quella del ciclista Franco Bitossi fattosi rimontare nel mondiale del '72 a pochi metri dal traguardo. O l'Inter di Cuper del 5 maggio 2002. O l'Argentina di Messi per due anni consecutivi sconfitta ai rigori, dal meno quotato Cile, in Coppa America. O ancora il Brasile sconfitto dall'Uruguay nei mondiali di calcio del '50 proprio al Maracanà. O l'Atletico Madrid di Simeone, storie di questi ultimi anni, che ha perso due finali di Champion's League, e sempre contro gli odiati rivali cittadini del Real. Chiamalo karma, chiamala malasuerte, chiamala sfiga. “Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio” (Samuel Beckett)
Tommaso Chimenti 30/04/2017
Libro della settimana
-
 "Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…







