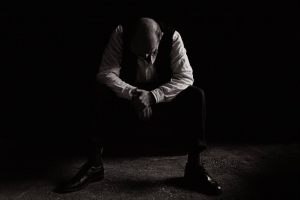Il berlusconismo pervade il “Don Chisciotte” di Latella e il “Napoleone” di Lino Guanciale
NAPOLI – Non poteva essere altrimenti. Non poteva che andare così. Proprio nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, Napoli rende il suo omaggio, del tutto involontario e inconsapevole, all'uomo di Arcore così innamorato di Napoli e della canzone napoletana. Due spettacoli diversissimi e lontani che però sono stati lapalissianamente un rimando alla contingenza dell'attualità: se nel “Circus Don Chiosciotte” di Antonio Latella in platea erano posizionati una ventina di televisori analogici con davanti varie poltrone, nel secondo, “Napoleone. La morte di Dio” di Davide Sacco, si parla della “morte di un dio, di un Imperatore” ed è forse impossibile oggi, in Italia, non pensare alla figura del fondatore di Mediaset. Due pièce che potrebbero apparire imbevute di berlusconismo latente e inconscio, intrise di quest'atmosfera da fine Impero, di opulenza e oblio di un Regno che perde i pezzi.  Il titolo di questa edizione del “Campania Teatro Festival” è “Battiti per la bellezza”, che potrebbe essere letto come i battiti del cuore o come coniugazione del verbo battere, battersi meglio, lottare. Programma leggermente ridotto rispetto alle versioni monstrate fino allo scorso anno, budget lievemente compresso per un mese di programmazione senza toccare più Capodimonte ma andando nei tanti teatri cittadini, dal Politeama al Mercadante, dalla Sala Assoli al Teatro Nuovo, dal Trianon Viviani al TAN Teatro Area Nord e il Museo Madre fino a Villa Floridiana.
Il titolo di questa edizione del “Campania Teatro Festival” è “Battiti per la bellezza”, che potrebbe essere letto come i battiti del cuore o come coniugazione del verbo battere, battersi meglio, lottare. Programma leggermente ridotto rispetto alle versioni monstrate fino allo scorso anno, budget lievemente compresso per un mese di programmazione senza toccare più Capodimonte ma andando nei tanti teatri cittadini, dal Politeama al Mercadante, dalla Sala Assoli al Teatro Nuovo, dal Trianon Viviani al TAN Teatro Area Nord e il Museo Madre fino a Villa Floridiana.
Nel “Don Chisciotte” (prod. Teatro di Napoli, CTF) per la regia di Antonio Latella due uomini, due facce della stessa medaglia, abbigliati in maniera uguale speculare, si muovono in una platea vuota da poltroncine che diventa palco dove stazionano appunto i citati televisori, diversi uno dall'altro, posizionati davanti a sedie o poltrone anch'esse differenti una dall'altra. Un uomo parla napoletano (il piacentino Marco Cacciola) e dovrebbe essere Sancho, l'altro spagnoleggiante, vetusto, forbito, arcaico (Michelangelo Dalisi) è Chisciotte di cervantesiana memoria. Ed è tutto un gioco tra le due parti, di rincorse, di sberleffi, calembour, giochi di parole alla Totò e Peppino, alla Franco e Ciccio, con perifrasi che sembrano uscire dalle rime del Cirano, assurdo, grottesco, surreale, anche vestiti come Ghostbuster con aspirapolvere sulle spalle, abatjour, ombrello, bastone da rabdomante, pantaloni da guardie svizzere o figuranti del calcio Storico fiorentino, fruste da cucina e scovolino per la polvere ovviamente arcobaleno. Salviamo il bel monologo iniziale (il testo è di Ruggero  Cappuccio) di Cacciola sul proprio paese (che potrebbe essere scritto indifferentemente con la minuscola, il paesello, o la maiuscola, lo Stato), sull'emigrazione nostalgica (ci ha ricordato alcuni passaggi degli scritti di Franco Arminio) che diventa rabbia astiosa, un'arringa che da allegra diventa sfogo amaro, arrabbiato anche se rassegnato e sconfitto. La scena vista dall'alto dei palchetti, con i televisori e le luci cangianti (passano dal giallo, rosa, rosso, blu, bianco, un'aria rarefatta e misteriosa da sogno felliniano) e il grande tabellone dove ruotano le lettere in stile stazione ferroviaria, è già di per sé una profonda installazione d'arte contemporanea dove gli anni delle tv spalleggiano il lento cambiamento meccanico, faticoso, quasi ingrippato, che gira alla ricerca delle lettere per fissare una prossima destinazione smarrita. Ulteriore innesto di senso sono questa ventina di signore e signori anziani che vengono accompagnati sulle varie poltrone e che seguiranno tutta la piece da quella posizione privilegiata. Questo “Don Chisciotte” a tratti potrebbe sembrare andare contro il pubblico: più formalismi che sostanza, più ricerca della trovata che essenza.
Cappuccio) di Cacciola sul proprio paese (che potrebbe essere scritto indifferentemente con la minuscola, il paesello, o la maiuscola, lo Stato), sull'emigrazione nostalgica (ci ha ricordato alcuni passaggi degli scritti di Franco Arminio) che diventa rabbia astiosa, un'arringa che da allegra diventa sfogo amaro, arrabbiato anche se rassegnato e sconfitto. La scena vista dall'alto dei palchetti, con i televisori e le luci cangianti (passano dal giallo, rosa, rosso, blu, bianco, un'aria rarefatta e misteriosa da sogno felliniano) e il grande tabellone dove ruotano le lettere in stile stazione ferroviaria, è già di per sé una profonda installazione d'arte contemporanea dove gli anni delle tv spalleggiano il lento cambiamento meccanico, faticoso, quasi ingrippato, che gira alla ricerca delle lettere per fissare una prossima destinazione smarrita. Ulteriore innesto di senso sono questa ventina di signore e signori anziani che vengono accompagnati sulle varie poltrone e che seguiranno tutta la piece da quella posizione privilegiata. Questo “Don Chisciotte” a tratti potrebbe sembrare andare contro il pubblico: più formalismi che sostanza, più ricerca della trovata che essenza.
Abbiamo detto del funerale dell'Imperatore che si ricollega al Signore di Milano Due. In questo “Napoleone. La morte di Dio”, scritto e diretto da Davide Sacco (che gestisce il Teatro Manini e il festival Narni Città Teatro nella cittadina umbra), presenta una scena cupa, scura, nera, ombrosa e imponente a fare da sfondo a queste amare riflessioni, non così chiare e limpide, sulla vita e sulla morte, sull'essere figli e sui padri che se ne vanno lasciando vuoti da gestire. Più vicende si intrecciano, più piani temporali si affastellano. Lino Guanciale (sempre amatissimo dal pubblico) ci mette anima e corpo in questo addio, tra obitorio e cimitero, su questa panca che si trasforma in catafalco (molto shakespeariano). A tratti la recitazione può apparire urlata, agitata, concitata e la sua voce (in alcuni passaggi ricorda i filmati dell'Istituto Luce) si sovrappone a quella della cantante (la bravissima Simona Boo) che ci porta dentro le atmosfere di Modugno o intona “Lascia ch'io pianga”. La scena costruita in altezza da tubi innocenti e impalcature e orizzontalmente con cumuli di terriccio per la sepoltura inneggia e richiama ora al cielo adesso alle profondità, al mistero del dopo. Le varie storie, in un flusso di parole copioso, che si incastrano forse non aiutano la comprensione (abbiamo visto la piece sia a Napoli che a Narni) di questo figlio in lotta tra il sentirsi un orfano ormai adulto e un padre che spegnendosi si è portato via il segreto della vita, nell'impossibilità di un nuovo incontro, nel dolore della perdita che difficilmente si può razionalizzare.
del funerale dell'Imperatore che si ricollega al Signore di Milano Due. In questo “Napoleone. La morte di Dio”, scritto e diretto da Davide Sacco (che gestisce il Teatro Manini e il festival Narni Città Teatro nella cittadina umbra), presenta una scena cupa, scura, nera, ombrosa e imponente a fare da sfondo a queste amare riflessioni, non così chiare e limpide, sulla vita e sulla morte, sull'essere figli e sui padri che se ne vanno lasciando vuoti da gestire. Più vicende si intrecciano, più piani temporali si affastellano. Lino Guanciale (sempre amatissimo dal pubblico) ci mette anima e corpo in questo addio, tra obitorio e cimitero, su questa panca che si trasforma in catafalco (molto shakespeariano). A tratti la recitazione può apparire urlata, agitata, concitata e la sua voce (in alcuni passaggi ricorda i filmati dell'Istituto Luce) si sovrappone a quella della cantante (la bravissima Simona Boo) che ci porta dentro le atmosfere di Modugno o intona “Lascia ch'io pianga”. La scena costruita in altezza da tubi innocenti e impalcature e orizzontalmente con cumuli di terriccio per la sepoltura inneggia e richiama ora al cielo adesso alle profondità, al mistero del dopo. Le varie storie, in un flusso di parole copioso, che si incastrano forse non aiutano la comprensione (abbiamo visto la piece sia a Napoli che a Narni) di questo figlio in lotta tra il sentirsi un orfano ormai adulto e un padre che spegnendosi si è portato via il segreto della vita, nell'impossibilità di un nuovo incontro, nel dolore della perdita che difficilmente si può razionalizzare.
Tommaso Chimenti 19/06/2023
“Il Teorema della Rana”: truffa allo Stato per salvare il teatro
ROMA – La rana è uno degli animali che, nella storia dell'Uomo, è stata più volte presa ad esempio e utilizzata per parabole, metafore, allegorie, favole e fiabe. C'è il principio della rana bollita di Noam Chomsky: una rana immersa in un pentolone pieno d’acqua fredda con il fuoco acceso si gode la temperatura accogliente, poi l’acqua si riscalda pian piano, diventando tiepida e gradevole; la temperatura sale e la rana si stanca, non è spaventata, ma adesso l'acqua è davvero troppo calda e la rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire e finisce bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua bollente avrebbe fatto un balzo e sarebbe saltata subito fuori dal pentolone. Oppure c'è la storia della rana dalla bocca larga con l'anfibio che incontra l'uccello e il topolino vantandosi di mangiare vermi con quelle sue fauci gigantesche fin quando non incontra il coccodrillo, ghiotto proprio di rane dalla bocca larga. E ancora la favola della rana e dello scorpione di Esopo: uno scorpione chiede a una rana di farlo salire sulla sua schiena per trasportarlo sull'altra sponda di un fiume. La rana rifiuta temendo di essere punta durante il tragitto. L'aracnide però la convince a non aver paura perché se la pungesse anche lui annegherebbe. La rana si fida e porta lo scorpione sulla sua schiena ma a metà percorso la punge condannando entrambi. La rana allora gli chiede perché e lo scorpione risponde: “Non posso farci nulla, è la mia natura”.
Infine ci sono le storie della rana sorda, sul non farsi demoralizzare da chi non ha fiducia in noi, della rana e il bue di Fedro sul non cercare di essere ciò che non siamo, e quella cinese della rana in fondo al pozzo che ci fa riflettere su chi ha le vedute strette e ottuse: la nostra rana viveva felice in un pozzo dal quale non era mai uscita. Un giorno una tartaruga marina passò di lì e la rana la chiamò invitandola a entrare. La tartaruga, invece di scendere nel pozzo, iniziò a raccontare alla rana della vastità del mare, suggerendo alla rana di andare con lei nell’oceano, molto più grande e bello di uno stagno in fondo a un pozzo. La rana non riusciva a capire come poteva essere possibile che ci fossero posti migliori del suo e rimase dov’era.
Perché la rana salta e zampetta e zampilla da un posto all'altro, pare inafferrabile quanto naif, scarta, si sposta, imprendibile quanto ingenua. Insomma la rana crede di essere la più furba del reame ma alla fine viene scoperta. Quello che succede nelle mirabolanti avventure de “Il Teorema della Rana” (testo di N.L. White; prod. Alt Academy e Compagnia Attori & Tecnici, visto al Teatro Vittoria; ha tutte le potenzialità per poter diventare un altro felice “tormentone” teatrale da repertorio come il loro classico e ormai cult “Rumori fuori scena”) dove un direttore di teatro, e il suo staff, per salvare la propria struttura dai debiti post pandemia e dagli scarsi finanziamenti alla cultura, decide di frodare il Ministero e la Previdenza Sociale non per bieco tornaconto personale ma per far quadrare i conti e far respirare la propria creatura, il palcoscenico, le maestranze, l'arte della scena. La trama è bella ingarbugliata tra scambi di persona e fraintendimenti, piccole e grandi truffe e l'ansia che monta e che porta tutti i personaggi al limite dell'agitazione, del patema, delle palpitazioni. Il testo è un connubio di ilarità intelligente e finissime trovate che si incastrano alla perfezione, dialoghi pungenti ed entrate e uscite che scatenano il panico nella finzione della storia e grandi risate in platea. Ogni scena è una nuova esaltazione, un'altra esagerazione, proficua drammaturgicamente, per far esplodere le dinamiche interne, quelle lavorative, quelle parentali, quelle con i controllori dello Stato.
In un teatro vuoto da scenografie, che sta attendendo il montaggio della nuova commedia da provare, serpeggiano telefonate sibilline e misteriose sospensioni, si parla di personaggi ormai scomparsi e di morti di persone invece vive e vegete. Gli otto attori in scena, uniti, compatti e omogenei, sono un concentrato di vitalità ed entusiasmo, tutto è spericolato e spumeggiante, mentre il sogno dei soldi facili si tramuta in un incubo e la confusione prende il sopravvento in un continuo disordine dinamico, parapiglia elettrico, scompiglio frenetico, trambusto alacre e camaleontico. Daniele Gargiulo (Luca Ferrini pirotecnico, anche regista) è, insieme con la moglie Giulia (Chiara Bonome scrosciante) il direttore del teatro che si trova a navigare in cattive acque. Nel tempo, con la complicità del cugino, Raul (Simone Balletti croccante e tramortito) addetto alle luci, ha creato un “sistema”, secondo loro infallibile (come lo fu il Titanic), per frodare l'INPS e incassare soldi per malattie, infortuni gravi, morti sul lavoro, invalidità permanenti, sussidi per attori anziani, famiglie a carico, il tutto inventato. Un castello di bugie immenso che nel tempo si è gonfiato a dismisura e si è autoalimentato diventando incontrollabile e ingovernabile. E il palcoscenico (per l'ora e mezza di rappresentazione) diventa un Far West brioso ed esuberante, un tutti contro tutti dove le menzogne (che notoriamente hanno le gambe corte) si rincorrono creando un enorme caos ironico degenerando in risse dialettiche sarcastiche. Di fondo, tra i sorrisi e la leggerezza che aleggiano e albergano costanti per tutta la durata e la tenuta della piece, una granitica accusa sia al Ministero, per come ha gestito il post Covid, e a tutto il comparto cultura italiano, sia nei confronti dell'estrema burocrazia di Previdenza Nazionale e Sindacati, che dovrebbero fornire aiuto e supporto amministrativo e che invece complicano tutto con moduli, timbri, nuove firme, rimanendo impersonali e metaforiche, assenze più che presenze. In questo caso i due esponenti statali sembrano essere, proprio per sottolineare la parodistica distanza con la realtà, molto coinvolti e partecipi, presenti al limite dell'invadenza.
C'è un grande rapporto tra il palco e la platea da dove provengono, e recitano, in sequenza tutti gli attori come una sorta di vera prosecuzione del palcoscenico stesso. Ma alla fine i nodi vengono necessariamente al pettine: il tecnico di scena, Mattia Badalamenti (Alberto Melone gagliardo) che è stato fatto credere morto è invece arzillo, il vecchio attore Ruggero Rosati, per il quale percepiscono ogni mese gli assegni, è invece in una casa di cura all'estero, mentre il Dottor Martini (Paolo Roca Rey frizzante) ispettore della Previdenza, entra in teatro con varie scartoffie da firmare per elargire nuove sovvenzioni. Il direttore Gargiulo fa finta di essere Rosati mentre non si trova nessuno che si travesta da lui per apporre anche la sua firma. La temperatura sale, gli equivoci fioccano e si moltiplicano, i malintesi abbondano in una girandola di piccoli e grandi colpi di scena che ribaltano, ad ogni quadro, la situazione già contorta e critica tra imbarazzi e gli escamotage dei personaggi per salvarsi dalla catastrofe imminente perché è chiaro a tutti che il sistema truffaldino è stato scoperto e tutto il loro mondo, basato su fondamenta di argilla e cartapesta, sta per liquefarsi e sciogliersi. Al Dottor Martini si aggiunge pure la solerte e zelante assistente sociale Angela (Valentina Martino Ghiglia decisa e risoluta) che con la sua energia si impegna ad aggrovigliare e intricare ancora maggiormente i fili della trama.
grande rapporto tra il palco e la platea da dove provengono, e recitano, in sequenza tutti gli attori come una sorta di vera prosecuzione del palcoscenico stesso. Ma alla fine i nodi vengono necessariamente al pettine: il tecnico di scena, Mattia Badalamenti (Alberto Melone gagliardo) che è stato fatto credere morto è invece arzillo, il vecchio attore Ruggero Rosati, per il quale percepiscono ogni mese gli assegni, è invece in una casa di cura all'estero, mentre il Dottor Martini (Paolo Roca Rey frizzante) ispettore della Previdenza, entra in teatro con varie scartoffie da firmare per elargire nuove sovvenzioni. Il direttore Gargiulo fa finta di essere Rosati mentre non si trova nessuno che si travesta da lui per apporre anche la sua firma. La temperatura sale, gli equivoci fioccano e si moltiplicano, i malintesi abbondano in una girandola di piccoli e grandi colpi di scena che ribaltano, ad ogni quadro, la situazione già contorta e critica tra imbarazzi e gli escamotage dei personaggi per salvarsi dalla catastrofe imminente perché è chiaro a tutti che il sistema truffaldino è stato scoperto e tutto il loro mondo, basato su fondamenta di argilla e cartapesta, sta per liquefarsi e sciogliersi. Al Dottor Martini si aggiunge pure la solerte e zelante assistente sociale Angela (Valentina Martino Ghiglia decisa e risoluta) che con la sua energia si impegna ad aggrovigliare e intricare ancora maggiormente i fili della trama.
Gli scambi sono scoppiettanti e vulcanici tra morti presunti, funerali da preparare, nozze che saltano, scoperte scomode e delicate, nuove falsità architettate per coprire le falle e le crepe sorte da altre fandonie. Il quadro non può che essere una tela di Pollock dove niente è lineare, come un gomitolo che si è arruffato e legato su se stesso. A far sobbollire ancora di più il tutto ci si mette anche anche la Dottoressa Cometti (Chiara David, divertentemente svampita) mediatrice di coppia, chiamata per risolvere i problemi coniugali tra i due direttori, perché la moglie crede che il marito, nel tempo libero, si travesta da donna. Una valanga irresistibile di inconvenienti senza freni che tutto travolge, aumentando i giri del motore ad ogni battuta. Nessuno è chi dice di essere e la commedia non può che finire in tragedia perché l'unica soluzione plausibile per uscire dalla farsa è la confessione dove tutti sono colpevoli, criminali amatoriali, lestofanti da tre soldi e manigoldi dilettanti ma a fin di bene, imbroglioni con il fine ultimo di riuscire a difendere con i denti la loro passione, proteggere allo stremo il loro/nostro amato teatro.
Tommaso Chimenti 16/06/2023
“Primavera dei Teatri”: Napoli, Palermo, Argentina, il Sud ha una marcia in più
CASTROVILLARI – Anche quest'anno è la locandina il miglior biglietto da visita per “Primavera dei Teatri” (dal 27 maggio al 4 giugno), che da ventitré anni porta il teatro contemporaneo nel nord della Calabria: un manichino, una bambola gonfiabile dentro un cellophane su un divano, in attesa di essere usato o buttato lì proprio perché non interessa più a nessuno. Una sorta di azzeramento dei desideri, come quando si lasciano le case delle vacanze e si coprono i mobili per non farli aggredire dalla polvere. Quindi cura ma anche dimenticanza, preoccupazione e abbandono. Tre gli spettacoli che più ci hanno colpito all'interno del cartellone messo a punto dai tre direttori artistici, Dario De Luca, Saverio La Ruina, Settimio Pisano. Il Sud (italiano e del mondo) ha da sempre una marcia in più, teatralmente e non solo. Sicuramente ha ancora qualcosa da dire. Ha le viscere, la pancia, il sentimento, il sangue che ribolle, la lotta, il fermento, la rivoluzione, la grinta, la ribellione sotto pelle.
Questo nostro viaggio parte da Napoli, nasce da “Giorni Felici” di Samuel Beckett e diventa questo “Felicissima jurnata” (prod. Cranpi, Teatro di Napoli) dei Puteca Celidonia: poteva essere una nuova trasposizione in un dialetto regionale di uno dei tanti lavori del maestro irlandese come furono “U' jocu sta finiscennu” dei Krypton in calabrese o “Aspettando Godot” in abruzzese del  Teatro Immediato, ancora Godot che in dialetto bresciano divenne “Che fom? ...Spetom!” di Faustino Ghirardini, o ancora Daniele Benati in reggiano. Invece i Puteca prendono spunto dalla veste beckettiana e ne immettono il proprio contesto, il quartiere napoletano dal quale provengono, il rione Sanità, e ancora più dentro, fino al cuore del loro vicolo (diventando immediatamente un testo eduardiano), applicando a Winnie e ai suoi giorni felici le interviste, le vere parole degli abitanti dei bassi che lì attorno brulicano, le persone che lì nascono e muoiono con quell'unico immaginario visivo negli occhi per decenni, memorie storiche e popolari di un universo bloccato, asfittico, attorcigliato come è la protagonista (dai mille risvolti e atmosfere Antonella Morea con la forza espressiva di Milvia Marigliano e l'efficacia ruvida di Barbara Valmorin) logorroica sepolta dalla vita in giù dentro questo triangolo, impilata e impalata in un cumulo di sabbia che in questa versione partenopea s'ingigantisce divenendo un vulcano (l'iconica scena che riempie le retine è di Rosita Vallefuoco), ovviamente il Vesuvio, ma anche un igloo per il gelo dei sentimenti o una grande gonna-appartamento-ripostiglio sotto la quale traffica e s'ingegna il marito che non proferisce parole, soverchiato dall'abbondanza di quelle a raffica della coniuge, ma soltanto grugniti gutturali e poco più. La drammaturgia (di Emanuele D'Errico) si bilancia con le voci in audio delle interviste che ci raccontano di queste povere, semplici esistenze, di queste sempre uguali giornate tipo composte da riposo, rosario, televisione in case abusive, vite al limite in equilibrio sul poter mettere un piatto in tavola o meno. “Che giornata felicissima” ripete lei per autoconvincersi, per dirsi anche questo giorno siamo sopravvissuti e “Questa giornata deve finire prima o poi” non è altro che la trasposizione del celebre “Adda passà 'a nuttata” di “Napoli milionaria”. Queste persone che si accontentano di poco hanno un'anima, non chiedono,
Teatro Immediato, ancora Godot che in dialetto bresciano divenne “Che fom? ...Spetom!” di Faustino Ghirardini, o ancora Daniele Benati in reggiano. Invece i Puteca prendono spunto dalla veste beckettiana e ne immettono il proprio contesto, il quartiere napoletano dal quale provengono, il rione Sanità, e ancora più dentro, fino al cuore del loro vicolo (diventando immediatamente un testo eduardiano), applicando a Winnie e ai suoi giorni felici le interviste, le vere parole degli abitanti dei bassi che lì attorno brulicano, le persone che lì nascono e muoiono con quell'unico immaginario visivo negli occhi per decenni, memorie storiche e popolari di un universo bloccato, asfittico, attorcigliato come è la protagonista (dai mille risvolti e atmosfere Antonella Morea con la forza espressiva di Milvia Marigliano e l'efficacia ruvida di Barbara Valmorin) logorroica sepolta dalla vita in giù dentro questo triangolo, impilata e impalata in un cumulo di sabbia che in questa versione partenopea s'ingigantisce divenendo un vulcano (l'iconica scena che riempie le retine è di Rosita Vallefuoco), ovviamente il Vesuvio, ma anche un igloo per il gelo dei sentimenti o una grande gonna-appartamento-ripostiglio sotto la quale traffica e s'ingegna il marito che non proferisce parole, soverchiato dall'abbondanza di quelle a raffica della coniuge, ma soltanto grugniti gutturali e poco più. La drammaturgia (di Emanuele D'Errico) si bilancia con le voci in audio delle interviste che ci raccontano di queste povere, semplici esistenze, di queste sempre uguali giornate tipo composte da riposo, rosario, televisione in case abusive, vite al limite in equilibrio sul poter mettere un piatto in tavola o meno. “Che giornata felicissima” ripete lei per autoconvincersi, per dirsi anche questo giorno siamo sopravvissuti e “Questa giornata deve finire prima o poi” non è altro che la trasposizione del celebre “Adda passà 'a nuttata” di “Napoli milionaria”. Queste persone che si accontentano di poco hanno un'anima, non chiedono,  non sperano più, sussurrano “Non ci possiamo lamentare” in una costante ansia/asma di vivere, respiro corto e affannato nelle preoccupazioni, nella fatica di tirare a campare, nel domani incerto che si spera sia monotono e incolore come il giorno prima che almeno significa salvezza, che un altro giorno lo abbiamo messo in cascina, nell'ammasso dei giorni felici. Onirico e concreto, “Felicissima jurnata” è uno schiaffo al capitalismo, alle lamentazioni dell'uomo contemporaneo, al surplus consumistico che ha schiacciato e azzerato i sentimenti.
non sperano più, sussurrano “Non ci possiamo lamentare” in una costante ansia/asma di vivere, respiro corto e affannato nelle preoccupazioni, nella fatica di tirare a campare, nel domani incerto che si spera sia monotono e incolore come il giorno prima che almeno significa salvezza, che un altro giorno lo abbiamo messo in cascina, nell'ammasso dei giorni felici. Onirico e concreto, “Felicissima jurnata” è uno schiaffo al capitalismo, alle lamentazioni dell'uomo contemporaneo, al surplus consumistico che ha schiacciato e azzerato i sentimenti.
Da Napoli ci spostiamo un po' più giù, a Palermo dove troviamo un Giuseppe Provinzano che è, attorialmente e teatralmente, visibilmente cresciuto e maturato padroneggiando meglio la scena, la materia e avendo ideato e architettato davvero un'opera che recupera sì la memoria dei giudici Falcone e Borsellino ma lo fa attraverso storie piccole, laterali, appunto “Storie di noi” di Beatrice Monroy (prod. Babel, Fondazione Giovanni Falcone, Spazio Franco). Storie minime, storie di palermitani che hanno visto, vissuto o anche solamente sentito il fragore, il frastuono, il boato dei due ordigni che cambiarono la geografia, il sentire degli abitanti. Provinzano, anche attraverso la maniera del cunto di Mimmo Cuticchio, dà voce a vicende cittadine, a eventi quotidiani che si sono trasformati in epica, in leggenda. Tra il 23 maggio 1992, la bomba di Capaci, e il 19 luglio 1992, l'autobomba di via D'Amelio, distano 57 giorni, come 57 sono i minuti dello spettacolo che si appoggia su un bel tappeto sonoro, su tante voci off, su una scenografia che ipnotizza: lui al centro ci aspetta palleggiando, attorno distese diverse sagome  come corpi uccisi, stracci che diventeranno lenzuoli immacolati da stendere sul fondale ad ogni capitolo, tanti lumini cimiteriali tutt'attorno, e due macchinine telecomandate che s'inseguono, una Fiat Croma bianca uguale a quella sulla quale viaggiava Falcone, una come la Centoventisei rossa che era stata imbottita di tritolo per l'attentato a Borsellino sotto casa della madre. E ci sono i bambini che giocano in strada, e c'è Giusy che si è appena sposata, e c'è una partita sentitissima di calcio tra due condomini rivali (e qui sembra Davide Enia in “Italia-Brasile 3-2”), e ci sono le figlie piccole di un giudice, e c'è una giornata al mare a Mondello, e c'è lo scagnozzo che prepara le case per i latitanti. Un testo che gronda poesia e sangue, sudore e afa, il tutto accompagnato dall'inquietante filastrocca: “Trema la terra, trema il mondo e tutti giù per terra”.
come corpi uccisi, stracci che diventeranno lenzuoli immacolati da stendere sul fondale ad ogni capitolo, tanti lumini cimiteriali tutt'attorno, e due macchinine telecomandate che s'inseguono, una Fiat Croma bianca uguale a quella sulla quale viaggiava Falcone, una come la Centoventisei rossa che era stata imbottita di tritolo per l'attentato a Borsellino sotto casa della madre. E ci sono i bambini che giocano in strada, e c'è Giusy che si è appena sposata, e c'è una partita sentitissima di calcio tra due condomini rivali (e qui sembra Davide Enia in “Italia-Brasile 3-2”), e ci sono le figlie piccole di un giudice, e c'è una giornata al mare a Mondello, e c'è lo scagnozzo che prepara le case per i latitanti. Un testo che gronda poesia e sangue, sudore e afa, il tutto accompagnato dall'inquietante filastrocca: “Trema la terra, trema il mondo e tutti giù per terra”.
Da Napoli a Palermo e infine un salto in Argentina, un altro pezzo di Italia nel continente americano. Frutto di una residenza e di uno scambio tra il Sud America e la Calabria, Micaela Farina, con autoironia e passione, ci racconta la sua storia, i suoi fallimenti, le sue cadute, la sua voglia di non mollare. Vuole, da sempre, fare la cantante lirica ma da una parte soffre d'asma e dall'altra viene rifiutata in tutti i provini ai quali partecipa. Un po' Paperino,  un po' Calimero, un po' Mafalda (non a caso personaggio disegnato dall'argentino Quino). Ne “La consagration de nadie” (scritto insieme a Gonzalo Quintana), ovvero “l'affermazione di nessuno”, perché l'hanno fatta sentire una nullità, ci racconta la sua parabola, l'Argentina, la famiglia, i corsi di canto, il passaporto italiano, lo studio lirico nella terra di Verdi e Puccini: tutto inutile. Una storia di orgoglio ma anche una richiesta d'amore e di affetto, di vicinanza, di partecipazione, di essere vista, guardata, ascoltata, di avere la sua dose di applausi (ne ha avuti moltissimi dal pubblico commosso di Castrovillari), di sentirsi viva. Lei inciampa, cade e si rialza sempre, fino alla prossima delusione, senza fare progressi nel canto e neanche nell'amore (forse le due cose sono connesse), ma non rinuncia testardamente ai suoi sogni. “Mi dicono di no, e io insisto” come una minaccia, un monito a se stessa e al mondo, è il suo lei motiv, il suo refrain, il suo loop, il suo mantra, rivincita e maledizione. Ma è un continuo abisso nel quale annegare e sentirsi sola e abbandonata, dove piangere senza consolazione. Quando parte il video di lei che da adolescente suona e canta la canzone colonna sonora di “Titanic” di Celine Dion è impossibile non avere gli occhi lucidi e bagnati perché siamo stati tutti almeno una volta (mille volte) come Micaela nel sentirsi imbranati, sbagliati mentre avremmo voluto soltanto attenzioni e abbracci, complimenti ed elogi, una pacca sulla spalla, almeno un bravo. Avrebbe soltanto voluto un po' d'amore. “Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio”, diceva Samuel Beckett. E Napoli si ricongiunge all'Argentina.
un po' Calimero, un po' Mafalda (non a caso personaggio disegnato dall'argentino Quino). Ne “La consagration de nadie” (scritto insieme a Gonzalo Quintana), ovvero “l'affermazione di nessuno”, perché l'hanno fatta sentire una nullità, ci racconta la sua parabola, l'Argentina, la famiglia, i corsi di canto, il passaporto italiano, lo studio lirico nella terra di Verdi e Puccini: tutto inutile. Una storia di orgoglio ma anche una richiesta d'amore e di affetto, di vicinanza, di partecipazione, di essere vista, guardata, ascoltata, di avere la sua dose di applausi (ne ha avuti moltissimi dal pubblico commosso di Castrovillari), di sentirsi viva. Lei inciampa, cade e si rialza sempre, fino alla prossima delusione, senza fare progressi nel canto e neanche nell'amore (forse le due cose sono connesse), ma non rinuncia testardamente ai suoi sogni. “Mi dicono di no, e io insisto” come una minaccia, un monito a se stessa e al mondo, è il suo lei motiv, il suo refrain, il suo loop, il suo mantra, rivincita e maledizione. Ma è un continuo abisso nel quale annegare e sentirsi sola e abbandonata, dove piangere senza consolazione. Quando parte il video di lei che da adolescente suona e canta la canzone colonna sonora di “Titanic” di Celine Dion è impossibile non avere gli occhi lucidi e bagnati perché siamo stati tutti almeno una volta (mille volte) come Micaela nel sentirsi imbranati, sbagliati mentre avremmo voluto soltanto attenzioni e abbracci, complimenti ed elogi, una pacca sulla spalla, almeno un bravo. Avrebbe soltanto voluto un po' d'amore. “Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio”, diceva Samuel Beckett. E Napoli si ricongiunge all'Argentina.
Tommaso Chimenti 07/06/2023
Foto: Angelo Maggio
A Torino si rinnova la magia del Fringe: la città invasa dal teatro indipendente
TORINO – Torino è una città che cambia di anno in anno. Un'anima sempre in costante mutamento che la pioggia di questa edizione non è riuscita ad ingrigire né smorzare. Torino è viva, è verdissima, è colorata. E questa undicesima edizione del Torino Fringe Festival ha confermato proprio questa straordinaria empatia e simbiosi tra città e rassegna con freschezza, gioventù, attenzione, aperture, accessibilità, nuove visioni. Tanti gli spazi toccati dalla manifestazione diretta da Cecilia Bozzolini, dall'Unione Culturale Franco Antonicelli al Magazzino sul Po, dal Museo Storico Reale Mutua allo Spazio Ferramenta, dal Bunker a San Pietro in Vincoli, dallo Spazio Kairos al Cubo Teatro Off Topic, da Casa Fools al Vinile, dal Teatro Astra al Beeozanam, un giro di Torino per conoscerla meglio attraverso luoghi nascosti e tutti da scoprire in un itinerario diverso tra i vari quartieri. Organizzazione perfetta, pochissimi ritardi sull'inizio degli spettacoli, sorrisi in quantità, due spettacoli a sera  in ogni spazio per due settimane di repliche (dal 12 al 28 maggio).
in ogni spazio per due settimane di repliche (dal 12 al 28 maggio).
Nel Fringe puoi trovare un po' di tutto, dal monologo al teatro di strada, dalla stand up comedy al dramma. Ad esempio la compagnia Teatro Strappato, italo-venezuelana con il loro “Betun” (prod. Teatro Strappato) ci ha mostrato come la piazza sia diversa da un palcoscenico. Anche se qui lo spettacolo ha festeggiato le centocinquanta repliche ha mostrato tutte le sue lacune lasciando fredda la platea nelle timide interazioni degli attori verso il pubblico. Una pièce senza parole, cupa e fosca, che non è riuscita a comunicare il senso di straniamento e violenza dei bambini di strada sudamericani con scene e quadri che hanno sottolineato un difetto di molti gruppi indipendenti: la mancanza di un occhio esterno, quel “primo spettatore” fondamentale per capire che cosa si sta passando a chi non conosce la materia che si sta raccontando; da dentro molte cose e passaggi vengono dati per scontati. “Betun” soffre di grandi vuoti drammaturgici e le tanto glorificate maschere non riescono a sopperire a queste mancanze lasciandoci interdetti, delusi e naufraghi. Se non avessimo letto il foglio di sala o se l'attore a fine replica non ci avesse spiegato a che cosa facevano riferimento le loro evoluzioni sul palco non avremmo capito a che cosa si stavano riferendo. Non è un dettaglio da poco. Forse la loro dimensione migliore è quella di uno spazio all'aperto e non chiusi tra le mura di un teatro dove occorrono altre esperienze.
Si può sempre prenderla con filosofia, così ci spiega Davide Grillo nel suo “Come se niente fosse” monologo su disastri e disillusioni. Timido quanto basta  per far scattare vicinanza e solidarietà alle sue gesta sfortunate. Strimpella la chitarra, suonicchia il trombone. Peccato per quel leggio che stoppa il flusso delle immagini e mette un freno al pathos, imbriglia la risata, rallenta i cuori. Il suo è un racconto profondo in tono leggero sul nostro mondo ormai invaso da scetticismo, insignificanze, disorientamento, incertezze, vuoto, panico, straniamento dove al suo interno fanno capolino i rapporti sentimentali ovviamente andati al macero, i fascisti (perché ci stanno sempre bene), il poliamore, l'inadeguatezza, i sensi di colpa, l'ansia di vivere. In qualche passaggio, per qualche verso sottopelle e sentore sconosciuto ci ha ricordato, come senso di abbandono e disfatta, la pellicola “Siccità” di Virzì. Tre momenti esilaranti: la fidanzata che parla del loro rapporto come farebbe un calciatore in un'intervista nel dopo partita, lo spot dello spray “Adito” (super), il coro dei cattolici in stile ultrà in trasferta: “Che ce frega del futuro noi c'abbiamo l'Aldilà”. E poi tante belle verità da appuntarsi e conservarsi e tatuarsi (perché la scrittura c'è eccome): “C'è il male di vivere e il vivere male” o “Di fronte all'indifferenza bisogna fare la differenza” e infine “Se non trovi il punto di riferimento forse il punto di riferimento sei tu”. Mai banale, generazionale ma neanche troppo. Grillo ci deve credere un po' di più, spingere ulteriormente, essere più convinto. I mezzi ci sono.
per far scattare vicinanza e solidarietà alle sue gesta sfortunate. Strimpella la chitarra, suonicchia il trombone. Peccato per quel leggio che stoppa il flusso delle immagini e mette un freno al pathos, imbriglia la risata, rallenta i cuori. Il suo è un racconto profondo in tono leggero sul nostro mondo ormai invaso da scetticismo, insignificanze, disorientamento, incertezze, vuoto, panico, straniamento dove al suo interno fanno capolino i rapporti sentimentali ovviamente andati al macero, i fascisti (perché ci stanno sempre bene), il poliamore, l'inadeguatezza, i sensi di colpa, l'ansia di vivere. In qualche passaggio, per qualche verso sottopelle e sentore sconosciuto ci ha ricordato, come senso di abbandono e disfatta, la pellicola “Siccità” di Virzì. Tre momenti esilaranti: la fidanzata che parla del loro rapporto come farebbe un calciatore in un'intervista nel dopo partita, lo spot dello spray “Adito” (super), il coro dei cattolici in stile ultrà in trasferta: “Che ce frega del futuro noi c'abbiamo l'Aldilà”. E poi tante belle verità da appuntarsi e conservarsi e tatuarsi (perché la scrittura c'è eccome): “C'è il male di vivere e il vivere male” o “Di fronte all'indifferenza bisogna fare la differenza” e infine “Se non trovi il punto di riferimento forse il punto di riferimento sei tu”. Mai banale, generazionale ma neanche troppo. Grillo ci deve credere un po' di più, spingere ulteriormente, essere più convinto. I mezzi ci sono.
Presenza scenica che ne ha da vendere Rossella Pugliese che, con il suo “Ultimo Strip” (prod. Deneb), ci parla di famiglia ma anche di  patologie psichiatriche in una Calabria (suo habitat linguistico naturale) che fa da sfondo e avvolge, stritolando, i protagonisti della vicenda. Narrazione per la verità alquanto contorta, con nomi e date ed eventi che si incastrano e sovrappongono, contorcendo i fatti a tratti non risultando lineare e scorrevole. Il percorso di una madre e una figlia, che sembrano accavallarsi e ricalcare un modello e un esempio anche se osceno e negativo, troppo frammentato e, in alcuni passaggi chiave, di difficile comprensione. Comunque il play è onirico e sensuale, la Pugliese, che gira come la bambola da carillon, governa la scena e la doma tra l'abito da sposa e questo piedistallo che si fa cassapanca dei ricordi, come cilindro del mago, il palo della lap dance, le catene, il body a rete e le altalene da Luna Park. Miscelate con sesso e autodistruzione, con sottomissione e rapporti sentimentali corrotti e tossici, caustici e corrosivi, tradimenti e una grande insoddisfazione di vivere di una ragazza maltrattata diventata adulta troppo presto. Le doti attoriali della Pugliese non si discutono ma chiarire alcuni momenti testuali e sottolineare meglio, forse asciugando e snellendo, alcuni nodi focali per una comprensione migliore del fatto che si sta raccontando. Ed è un peccato se il pubblico non riesce pienamente ad entrare nella storia nelle pieghe e nelle sfumature.
patologie psichiatriche in una Calabria (suo habitat linguistico naturale) che fa da sfondo e avvolge, stritolando, i protagonisti della vicenda. Narrazione per la verità alquanto contorta, con nomi e date ed eventi che si incastrano e sovrappongono, contorcendo i fatti a tratti non risultando lineare e scorrevole. Il percorso di una madre e una figlia, che sembrano accavallarsi e ricalcare un modello e un esempio anche se osceno e negativo, troppo frammentato e, in alcuni passaggi chiave, di difficile comprensione. Comunque il play è onirico e sensuale, la Pugliese, che gira come la bambola da carillon, governa la scena e la doma tra l'abito da sposa e questo piedistallo che si fa cassapanca dei ricordi, come cilindro del mago, il palo della lap dance, le catene, il body a rete e le altalene da Luna Park. Miscelate con sesso e autodistruzione, con sottomissione e rapporti sentimentali corrotti e tossici, caustici e corrosivi, tradimenti e una grande insoddisfazione di vivere di una ragazza maltrattata diventata adulta troppo presto. Le doti attoriali della Pugliese non si discutono ma chiarire alcuni momenti testuali e sottolineare meglio, forse asciugando e snellendo, alcuni nodi focali per una comprensione migliore del fatto che si sta raccontando. Ed è un peccato se il pubblico non riesce pienamente ad entrare nella storia nelle pieghe e nelle sfumature.
Paolo  Faroni ci sorprende ancora una volta con il suo nuovo “Perle ai porci” (prod. Bluscint) con la sua verve aggressivo-passiva e quella “cattiveria” dialettica profonda e ispida, mai stucchevole, bilanciata tra una sana risata e una riflessione sorridendo a denti stretti. Ha questa fisicità debordante, incute timore la sua voce profonda ma il suo sciorinare tra i meccanismi del teatro e quelli della vita affascina la platea che lo acclama come suo mentore e guru. Pare un pugile arrabbiato, lancia i suoi jab ficcanti, ci porta a spasso con una scrittura che funziona toccando temi alti, fascismo e sinistra, gli alieni (che hanno la voce di Sandro Ciotti), politica e mafia, Capaci, Cucchi, la Val di Susa con battute al vetriolo, non urticanti ma ustionanti. Montagne russe tra il comico e il drammatico, applausi festanti, traboccanti e scoppiettanti. Inutile sottolineare che le Perle sono le sue e i Porci noi.
Faroni ci sorprende ancora una volta con il suo nuovo “Perle ai porci” (prod. Bluscint) con la sua verve aggressivo-passiva e quella “cattiveria” dialettica profonda e ispida, mai stucchevole, bilanciata tra una sana risata e una riflessione sorridendo a denti stretti. Ha questa fisicità debordante, incute timore la sua voce profonda ma il suo sciorinare tra i meccanismi del teatro e quelli della vita affascina la platea che lo acclama come suo mentore e guru. Pare un pugile arrabbiato, lancia i suoi jab ficcanti, ci porta a spasso con una scrittura che funziona toccando temi alti, fascismo e sinistra, gli alieni (che hanno la voce di Sandro Ciotti), politica e mafia, Capaci, Cucchi, la Val di Susa con battute al vetriolo, non urticanti ma ustionanti. Montagne russe tra il comico e il drammatico, applausi festanti, traboccanti e scoppiettanti. Inutile sottolineare che le Perle sono le sue e i Porci noi.
A volte nella vita è questione di accenti. Ad esempio vénti e vènti, pésca e pèsca. Oppure, ed è il nostro caso, Péne o Pène. Organo sessuale maschile o sofferenze. E gioca proprio sulla doppia accezione questo “Pene” (prod. Fools) con Stefano Sartore (lussureggiante e sfolgorante) che brillantemente punge il tema dell'identità, picchiando forte il maschio. L'aria si fa subito frizzante nel suo nudo esposto. La tesi di fondo è che nel mondo c'è troppa violenza e disagio e guerre ed è tutta colpa del maschio e del suo testosterone. Lo dice testualmente: “Vogliamo dimostrare quanto sia nocivo il cazzo” e poi suggella: “Ci sono anche cazzi che hanno fatto buone cose” citando il passato. Non che le sue teorie (testo scritto insieme a Luigi Orfeo e Roberta Calia) non possano avere fondamenti di verità ma spesso si tracima nelle espressioni, “L'unica possibilità è evirare tutti gli uomini alla nascita”, o nel mostrare una tipologia di uomo che rafforza la tesi proposta: l'uomo violento finiti alla sbarra, il padre possessivo e geloso patologico con bambina in braccio, il generale guerrafondaio, l'omosessuale anziano che racconta le sue peripezie e  geometrie euclidee per incastrarsi meglio. Quando la cabina dei cambi d'abito si gira troviamo la scatola-confezione di Ken a grandezza naturale. E il cerchio si chiude. Forse il compagno di Barbie soffre dell'“invidia del pene” freudiana? Quasi un “Brevi interviste con uomini schifosi” o un “Monologhi della vagina” in versione maschile o ancora un “Quello che le donne non dicono” di mannoiana memoria ma molto più incarognito e radicale.
geometrie euclidee per incastrarsi meglio. Quando la cabina dei cambi d'abito si gira troviamo la scatola-confezione di Ken a grandezza naturale. E il cerchio si chiude. Forse il compagno di Barbie soffre dell'“invidia del pene” freudiana? Quasi un “Brevi interviste con uomini schifosi” o un “Monologhi della vagina” in versione maschile o ancora un “Quello che le donne non dicono” di mannoiana memoria ma molto più incarognito e radicale.
Nella vita ci vogliono eccitazione, esaltazione, foga e fervore non come il personaggio (assente) di “Entusiasmozero” scritto, diretto e prodotto da Fabio Marchisio con un eccellente e generoso, spiritato e esagerato e esagitato Lorenzo Bartoli (ci ha ricordato un mix tra Scimone/Sframeli, Antonio Albanese, Antonio Conte e Johnny Stecchino) in scena lanciato in un dialogo surreale ad una voce tra un piccolo malavitoso locale e un “picciotto”, appunto silenzioso. Anche qui la veste leggera nasconde un animo contemporaneo e tagliente in un racconto sulla mafia, sulle regole e i rapporti  non scritti con la politica, la corruzione, gli appalti, il tutto in salsa pentastellata, una rivoluzione taciturna, più un auspicio, un sogno rispetto a quello che poi effettivamente nella realtà è accaduto.
non scritti con la politica, la corruzione, gli appalti, il tutto in salsa pentastellata, una rivoluzione taciturna, più un auspicio, un sogno rispetto a quello che poi effettivamente nella realtà è accaduto.
Ed eccoci al migliore, secondo noi, visto nei quattro giorni di permanenza al Torino Fringe (ma perché non inserire un Premio della Critica e uno del Pubblico e varie menzioni? Renderebbe il tutto più frizzantino): “Don Chisciotte sulla Luna” (prod. Elmo di Mambrino, A.M.A. Factory). La scrittura di Angelo Tronca è pantagruelica, dadaista, irrazionale, paura e delirio, una follia ben architettata in scena dallo stesso Tronca affiancato da costole del Mulino di Amleto, Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo in questa pazzia teatrale dissennata, una chimica spasmodica, una miscela giocosa tra Cervantes e l'Ariosto. Inventiva e invettive, trovate ed escamotage, arringhe, citazioni e poesia, tra Mario Bros e Celentano, una piece sul coraggio, sul non avere paura, un'alchimia emozionante, un respiro commovente, irriverente: sicuramente spassoso.
Tommaso Chimenti 31/05/2023
“Le Marocchinate”: quando i liberatori si trasformarono in aguzzini
ROMA – Di alcuni argomenti in Italia è difficile parlare, anzi è meglio non parlarne proprio, perché alla politica fa più comodo mettere la polvere sotto il tappeto invece che affrontare il tema e aiutare chi ha subito danni e ingiustizie. E' capitato con le Foibe, è successo con “Le Marocchinate”, frutto di un'indagine sul campo che il narratore (attore è troppo semplicistico) Ariele Vincenti ha condotto per oltre un anno insieme a Simone Cristicchi. Perché ci vuole coraggio a far riemergere queste pagine talmente assurde e vergognose da far accapponare la pelle, violenze su gente inerme da parte di chi era stato chiamato per liberare, aiutare, dare una speranza. Vincenti ha una sua verità intima, profonda, non va in scena ma fa teatro (è profondamente diverso), scandaglia le storie, le fa proprie, le annusa, le indossa, le veste, diventando una cosa unica con l'argomento, lo studia, lo approfondisce, diventa una sua seconda pelle. E la sua passione non è effimera per la resa sul palcoscenico ma gli rimane attaccata addosso, alle ossa, e questo si vede quando, a fine di ogni replica, decine di persone lo aspettano per conoscere ancora altri aspetti legati delle vicende narrate, sapere oltre lo spettacolo visto.
Per Ariele (con la regia di Nicola Pistoia) la rappresentazione non inizia a teatro né finisce con gli applausi, le storie gli abitano dentro e le porta avanti con il sorriso dell'uomo buono (quello che subisce le angherie della vita) e con la coscienza pulita e l'animo candido sa che, prima o poi, ci sarà una Giustizia che riequilibri lo schifo patito, i traumi, le malefatte. Il suo è un racconto per portare alla luce, e far conoscere, un pezzo di Storia tutta nostrana che è stata celata e messa da parte, perché non faceva comodo che si sapesse, considerata dalle alte sfere politiche come un “effetto collaterale”, un necessario inferno contro una popolazione senza difese. Vincenti ha un'umanità e un'umiltà che traspare, che trasborda dal palcoscenico alla platea (e questo la gente lo sente chiaramente, per questo è così amato e trattato come uno di famiglia), una pulizia di sentimenti, un animo limpido non di chi sa arrogantemente di essere dalla parte della ragione né di chi cerca vendetta ma di chi, attraverso la Verità, vuole soltanto mettere sul piatto i fatti, esporre senza strumentalizzazione politica gli accadimenti senza cercare plausi e allori personali, con la semplicità di chi sta facendo un servizio ad una collettività alla quale era stata nascosta la realtà per decenni.
Con l'espediente di un pastore-narratore, un quasi San Francesco (c'è stata una grande ricerca anche sulla lingua da usare sul palco, uno studio su un dialetto verace e sgrammaticato ma sincero della Ciociaria), ci fa entrare poco a poco dentro la vicenda e ci culla in questo stato ipnotico e bucolico al quale ci lasciamo volentieri andare, fatto di pecore e di vita sana all'aperto, dei frutti della terra, di balle di fieno, di contadini. A piccoli passi a ritroso il verdeggiante e frescheggiato affresco di campagna lascia il posto al terrore più infimo e profondo, all'offesa più marcia, alla paura senza scampo. Durante la Liberazione dai tedeschi, americani e inglesi avevano perso migliaia di uomini sulle colline laziali non riuscendo a stanare i nazisti che lì si asserragliavano e si arroccavano. L'idea venne all'alleato francese: assoldare le “bestie marocchine” che, abituate ai corpo a corpo nella boscaglia e a condizioni di guerra estreme, avrebbero potuto sconfiggere quelle armate nei boschi ispidi e difficilmente raggiungibili.
Così  fu; l'ignobile premio dei francesi ai marocchini per aver portato a termine la missione fu che per due giorni avrebbero potuto fare qualsiasi cosa, sul terreno di conquista e alle popolazioni di quei paesi. Piccoli centri dove gli uomini o erano morti in battaglia o erano lontano a combattere, piccoli centri dove erano rimaste donne, anziani e bambini. Fu un massacro di migliaia di donne violentate e uccise come furono trucidati i nonni o i figli che tentarono inutilmente di salvare dalle sevizie quelle ragazze umiliate, vilipese, distrutte nel fisico e nell'anima. Uno scempio difficile da capire, una devastazione, un'angheria, una tragedia, una carneficina, una distruzione, uno sterminio, una strage degli innocenti che non può avere scusanti né giustificazioni. Una storia sconosciuta avvenuta in una terra sconosciuta. La povera gente andava incontro alle truppe marocchine (addirittura De Gaulle li incensò per la loro opera e il servizio prestato alla guerra) che entravano nei paesi trionfanti per aver cacciato i tedeschi, e andavano incontro loro con il sorriso della salvezza e la riconoscenza e i grazie e subito iniziava il martirio, le violenze indicibili, il sangue tra lo stupore di non riuscire a capire come il tuo salvatore si fosse trasformato immediatamente nel tuo peggior boia e aguzzino. Si sta male nell'ascoltare queste parole che non cedono alla morbosità ma comunque le urla, gli strepiti, lo strazio non possono non entrare sotto
fu; l'ignobile premio dei francesi ai marocchini per aver portato a termine la missione fu che per due giorni avrebbero potuto fare qualsiasi cosa, sul terreno di conquista e alle popolazioni di quei paesi. Piccoli centri dove gli uomini o erano morti in battaglia o erano lontano a combattere, piccoli centri dove erano rimaste donne, anziani e bambini. Fu un massacro di migliaia di donne violentate e uccise come furono trucidati i nonni o i figli che tentarono inutilmente di salvare dalle sevizie quelle ragazze umiliate, vilipese, distrutte nel fisico e nell'anima. Uno scempio difficile da capire, una devastazione, un'angheria, una tragedia, una carneficina, una distruzione, uno sterminio, una strage degli innocenti che non può avere scusanti né giustificazioni. Una storia sconosciuta avvenuta in una terra sconosciuta. La povera gente andava incontro alle truppe marocchine (addirittura De Gaulle li incensò per la loro opera e il servizio prestato alla guerra) che entravano nei paesi trionfanti per aver cacciato i tedeschi, e andavano incontro loro con il sorriso della salvezza e la riconoscenza e i grazie e subito iniziava il martirio, le violenze indicibili, il sangue tra lo stupore di non riuscire a capire come il tuo salvatore si fosse trasformato immediatamente nel tuo peggior boia e aguzzino. Si sta male nell'ascoltare queste parole che non cedono alla morbosità ma comunque le urla, gli strepiti, lo strazio non possono non entrare sotto pelle.
pelle.
Il nostro contadino racconta la sua vicenda personale ad un giornalista (che si scoprirà essere Enzo Biagi, l'unico che dette minimamente conto dell'accaduto, raccontando una storia laterale) che, nella finzione scenica, era arrivato in questo entroterra, per documentare quello che era successo: i preti impalati, una generazione dilaniata e distrutta, le malattie. Beffa nella beffa, negli anni '50 si chiese in Parlamento un risarcimento per le migliaia di vittime ma il caso fu derubricato perché non c'erano le denunce e i politici dicevano che erano storie inventate per ottenere soldi da parte dello Stato. Ulteriore scandalo e pena subita da queste donne fu anche il ritorno a casa degli uomini dal fronte che, avendo saputo delle violenze subite, non solo non ebbero nessun moto di vicinanza verso le loro compagne e mogli, ma anzi da quel giorno in avanti le trattarono con il disprezzo e con ulteriori violenze psicologiche e fisiche che si possono concedere a delle bestie appestate. Questa è una macchia nera indelebile e per fortuna ogni tanto c'è un narratore che ci ricorda a che cosa serve il teatro, a far passare le storie, ad indignarci, a chiedere giustizia. Abbiamo bisogno di dieci, cento, mille Ariele Vincenti.
Tommaso Chimenti 16/05/2023
Un “Riccardo III” nuovo, fresco, contemporaneo. Pierobon si esalta e illumina la scena
MODENA – Quando si parla di rilettura di un classico e di fedeltà ad un testo, di intenzioni originarie e allo stesso tempo universali quindi traslabili nelle epoche, il compito, la maggior parte delle volte, deborda in un atteggiamento che rivoluziona artificialmente per la voglia di stupire o strapazzare una drammaturgia bollata come stantia e vecchia. E' l'equilibrio, tra l'impianto primordiale e quella frescata di modernità necessaria, la cosa più complessa da ottenere senza forzare la mano, senza tradire, senza ribaltoni. Ecco, il “Riccardo III” (prod. Teatro Stabile Torino, Teatro Stabile Bolzano, ERT Fondazione) per la regia di Kriszta Szekely (che già aveva collaborato in Italia con lo Stabile di Torino con uno “Zio Vanja”) può riassumere felicemente le caratteristiche di unità e di difformità, di linearità e di testimonianza come di ricerca, di storicità come di attualizzazione in un lavoro continuo, certosino, paziente sulla limatura dei dettagli, sull'aggiustatura del tiro, sulla composizione delle singole scene senza perdere mai di vista l'ensemble. Per questo le tre ore filano via, nonostante il dramma, la tragedia e il sangue, come fosse un varietà, ma senza sforare nel ridicolo, saranno i colori e le luci sparate, sarà il filo rosso teso tra palco e platea, seppur nel dolore e nello strazio siamo coinvolti più in profondità rispetto alla commozione o alle lacrime superficiali, veniamo toccati nella disgrazia attuale che è diventata fondale e colonna sonora di quello che leggiamo, vediamo e che, come goccia cinese, non ci assuefà solamente ma ci cambia pian piano, modificandoci geneticamente, cinicamente, irrobustendo la nostra scorza-corazza ma quando,  come in questo caso, si riesce a creare una crepa è da lì che fa più male perché entra più luce bianca e dolente. Nei confronti della sofferenza sovraesposta abbiamo obbligatoriamente prodotto gli anticorpi; per questo sentimento che, mellifluo e dolce e meschino, si insinua nella nostra carne, siamo invece senza difese, senza scudo, senza pelle.
come in questo caso, si riesce a creare una crepa è da lì che fa più male perché entra più luce bianca e dolente. Nei confronti della sofferenza sovraesposta abbiamo obbligatoriamente prodotto gli anticorpi; per questo sentimento che, mellifluo e dolce e meschino, si insinua nella nostra carne, siamo invece senza difese, senza scudo, senza pelle.
In un'ambientazione di una casa-villa di campagna che può assomigliare anche ad una cattedrale, con le travi in legno a vista, quasi accogliente se non fosse luogo di morte, quasi colorata e allegra se non fosse luogo di cupezza delle emozioni, con sopra ad avvolgere tutto e tutti come un abbraccio fatato e fatale un lampadario che visivamente non può non apparire come una gigantesca aureola e sotto un tavolo da Ultima Cena o consiglio d'amministrazione, camino e televisione. Tutta la vicenda shakespeariana è volta ai nostri giorni tra dittatori (infiniti i ricorsi agli inserti dove riconoscere l'attualità stringente di volti e piccoli personaggi insignificanti che la Storia spazzerà via e polverizzerà nel dimenticatoio e nell'oblio) e comunicazione, tra strategie di guerra e marketing, bombe e propaganda che da molto tempo vanno a braccetto. Nelle trame, tra fondi illeciti e fake news, tra accuse di corruzione e spostamento dell'opinione pubblica, sembra davvero  di stare dentro la cronaca quotidiana nostrana, e per nostrana è possibile leggerci nazionale ma anche europea, del Primo Mondo ma anche mondiale. Infatti il nostro Riccardo qui non è tratteggiato (e come sempre quasi scusato e giustificato per la sua malvagità a causa dei suoi difetti fisici) per la sua claudicanza o il braccio offeso, qui non si forzano questi aspetti, non si gioca sulla deformità del corpo; Paolo Pierobon (una grandissima prova, sempre altissimo vigore e intelligenza scenica, mai una nota stonata o bassa; uno dei giganti maschili del nostro teatro) riesce a dare ora quello shining frizzante delle pupille che sfrigolano, adesso cambi bipolari della voce (po(po)lizianamente o po(po)liziescamente), ora quella pericolosità imprevedibile di un bacio di Giuda dato da Iago come dell'abbraccio di un cobra o dell'amplesso della mantide religiosa.
di stare dentro la cronaca quotidiana nostrana, e per nostrana è possibile leggerci nazionale ma anche europea, del Primo Mondo ma anche mondiale. Infatti il nostro Riccardo qui non è tratteggiato (e come sempre quasi scusato e giustificato per la sua malvagità a causa dei suoi difetti fisici) per la sua claudicanza o il braccio offeso, qui non si forzano questi aspetti, non si gioca sulla deformità del corpo; Paolo Pierobon (una grandissima prova, sempre altissimo vigore e intelligenza scenica, mai una nota stonata o bassa; uno dei giganti maschili del nostro teatro) riesce a dare ora quello shining frizzante delle pupille che sfrigolano, adesso cambi bipolari della voce (po(po)lizianamente o po(po)liziescamente), ora quella pericolosità imprevedibile di un bacio di Giuda dato da Iago come dell'abbraccio di un cobra o dell'amplesso della mantide religiosa.
Quello che impressiona è anche questo personaggio-non personaggio che troneggia sul palcoscenico in un angolo ma che si fa sempre più corposo e ingombrante, un corpo nero che cresce come un blob e non può non dare fastidio con la sua presenza all'occhio dello spettatore; è il cumulo dei morti uccisi per spazzare via (come Ubu roi) oppositori e pretendenti al titolo, osteggiatori o semplici contestatori,  assassinati brutalmente e chiusi dentro buste scure da obitorio che lì campeggiano come una pira indiana, un ammasso a più strati di morbidezza scomparsa. Gli inserti contemporanei (la palla da fitness, la pistola, i telefoni cellulari, le telecamere, l'inflazione, i titoli di Stato, la Corte Suprema, i blog, i profili falsi per spargere veleno online fino alla testata nel petto di RIII a Catesby in versione Zidane) portano in due direzioni: da una parte la guerriglia dialettica della regista verso il potere villano e orbo di casa propria, l'Ungheria (quando Riccardo con un completo verde e la camicia bianca ha al suo fianco il consigliere Buckingham in rosso si forma cromaticamente la bandiera di Budapest e dintorni, ma anche la nostra...), comandata da Orban, dall'altro lo schieramento netto a favore dell'Ucraina (con la richiesta di invio continuo di armi) contro la triade del Male Putin-Cina-Corea del Nord. In quest'atmosfera da talk show, in audio ad affrescare ancora meglio questo Riccardo pierobonesco (superbo, tendente a Jack Nicholson) che istiga e ordisce, calunnia e scredita e infanga, che si lancia in un moonwalk da applausi, ora simile a Nerone adesso a Mussolini, ora potrebbe essere Berlusconi adesso Trump, ora Putin fino ad Hitler nel bunker, quella che pare una manipolazione della “Psycho killer” dei Talking Heads. Tutti i componenti del cast, dalle parti più consistenti e solide, a quelle più scarne, hanno mostrato grande varietà di registri e sfaccettature su un piano di qualità altissimo senza divari, da Elisabetta Mazzullo, potentissima nel ruolo di Elisabetta, convincente, altera e materica, mai sopra le righe, lo scoppiettante Francesco Bolo Rossini e la straordinaria Manuela Kustermann, così come la avvolgente Marta Pizzigallo e Matteo Alì o Nicola Lorusso o l'efficace Alberto Malanchino, l'esplosiva Lisa Lendaro e Nicola Pannelli, Jacopo Venturiero o Stefano Guerrieri, tutti, senza esclusione, sorprendenti, emozionanti, vitali, lucidi, innamoranti.
assassinati brutalmente e chiusi dentro buste scure da obitorio che lì campeggiano come una pira indiana, un ammasso a più strati di morbidezza scomparsa. Gli inserti contemporanei (la palla da fitness, la pistola, i telefoni cellulari, le telecamere, l'inflazione, i titoli di Stato, la Corte Suprema, i blog, i profili falsi per spargere veleno online fino alla testata nel petto di RIII a Catesby in versione Zidane) portano in due direzioni: da una parte la guerriglia dialettica della regista verso il potere villano e orbo di casa propria, l'Ungheria (quando Riccardo con un completo verde e la camicia bianca ha al suo fianco il consigliere Buckingham in rosso si forma cromaticamente la bandiera di Budapest e dintorni, ma anche la nostra...), comandata da Orban, dall'altro lo schieramento netto a favore dell'Ucraina (con la richiesta di invio continuo di armi) contro la triade del Male Putin-Cina-Corea del Nord. In quest'atmosfera da talk show, in audio ad affrescare ancora meglio questo Riccardo pierobonesco (superbo, tendente a Jack Nicholson) che istiga e ordisce, calunnia e scredita e infanga, che si lancia in un moonwalk da applausi, ora simile a Nerone adesso a Mussolini, ora potrebbe essere Berlusconi adesso Trump, ora Putin fino ad Hitler nel bunker, quella che pare una manipolazione della “Psycho killer” dei Talking Heads. Tutti i componenti del cast, dalle parti più consistenti e solide, a quelle più scarne, hanno mostrato grande varietà di registri e sfaccettature su un piano di qualità altissimo senza divari, da Elisabetta Mazzullo, potentissima nel ruolo di Elisabetta, convincente, altera e materica, mai sopra le righe, lo scoppiettante Francesco Bolo Rossini e la straordinaria Manuela Kustermann, così come la avvolgente Marta Pizzigallo e Matteo Alì o Nicola Lorusso o l'efficace Alberto Malanchino, l'esplosiva Lisa Lendaro e Nicola Pannelli, Jacopo Venturiero o Stefano Guerrieri, tutti, senza esclusione, sorprendenti, emozionanti, vitali, lucidi, innamoranti.
Tommaso Chimenti 11/05/2023
Foto: Luigi De Palma
“Fine pena ora”: un giudice e un ergastolano a scriversi lettere per quarant'anni
MILANO – Esiste il “fine pena mai”, l'ergastolo per i più irriducibili e intransigenti criminali, e poi questo “Fine Pena Ora” che il regista sensibile Simone Schinocca ha messo in scena dopo una lunga gestazione. Incuriosito e coinvolto, affascinato e innamorato della storia epistolare tra il magistrato che aveva firmato la condanna e il carcerato (storia reale con i due protagonisti ancora in vita) che si sono scritti per trentotto anni prima di incontrarsi. Dal libro omonimo (ed. Sellerio) scritto dal giudice Elvio Fassone prima ne fu tratta una piece, per la regia di Mauro Avogadro, con Paolo Pierobon nelle vesti del detenuto (prod. Piccolo di Milano), poi Luca Zingaretti provò a trarne senza risultato un lungometraggio e infine il regista torinese della compagnia Tedacà è riuscito a riportare questo strano incontro tra due uomini dai valori agli antipodi al centro di un palcoscenico. Recentemente, a tema carcerario, per il grande schermo è stato girato “Aria ferma” e la serie “Il Re”. Da un lato un uomo condannato per oltre quindici omicidi, dall'altra un uomo probo, proprio colui che ha deciso la sentenza (non certo un “giudice” come lo descrisse De Andrè), che un giorno comincia a scrivere al detenuto aprendo il Vaso di Pandora, scoperchiando un rapporto che va avanti tuttora. Salvatore, questo il nome reale dell'ergastolano, non ha mai chiesto sconti di pena, non si è mai pentito, non si è mai dichiarato innocente, non ha chiesto perdono alle famiglie degli uccisi, non ha mai rinnegato Cosa Nostra, anzi è orgoglioso del suo silenzio, della sua omertà, di non aver mai parlato con la giustizia né aver fatto nomi, di non aver fatto la spia o, come si dice in gergo, “l'infame”.
la giustizia né aver fatto nomi, di non aver fatto la spia o, come si dice in gergo, “l'infame”.
E' proprio in questo solco tra due mondi distanti e impossibili da far coesistere nella stessa stanza che è avvenuto il miracolo dell'unione fatta di fogli di carta scritti rigorosamente a mano dove due persone di estrazione, formazione, vita vissuta così diametralmente opposta, si sono ritrovati in un terreno comune, il foglio bianco da riempire per raccontarsi, aprirsi, trovare nuove strade di comunicazione, di empatia. In una cella fatta da sbarre di corde con nodi come fossero tanti rosari appesi alle carrucole, corde che sembrano ragnatele o pentagrammi verticali (e i nodi le note) a creare un'opacità che non permette una visuale libera all'interno, un uomo (Salvatore D'Onofrio è pugnace e d'impatto, muscolare e di presenza solida nell'accogliere su di sé questa figura così “estrema”) rantola su una panchina. Intorno a lui si affolleranno visioni e fantasmi, apparizioni della compagna come dell'uomo di legge, epifanie che verranno a trovarlo, affacciandosi a quel mondo claustrofobico e minimale. Un sogno a tratti d'incubo. Un uomo dei clan, condannato in un maxi processo insieme ad altri 250 imputati, che si scrive di nascosto (se si sapesse all'interno dei corridoi del carcere sarebbe come firmarsi una condanna a morte) come ad un'amante segreta. Non si sa se per tenerezza o per senso di colpa, sarà proprio il magistrato (in scena Giuseppe Nitti in toga, attento e rigoroso, si muove fuori dalla frontiera di funi e cavi) che lo aiuterà con consigli pratici su come compilare le richieste per i permessi. Un senso di colpa non in quanto mano che ha deciso gli anni di punizione da scontare ma per la fortuna che alcuni hanno di nascere in alcune città e luoghi e in alcune condizioni familiari ed economiche, potendo studiare, rispetto ad altre fasce della popolazione che sono più soggette a cadere in mano, per povertà, analfabetismo e scarsa informazione, alla criminalità. La frase è “Se io nascevo dove è nato lui” che è un mettersi nei panni dell'altro, senza giustificare in maniera buonista le azioni ma considerando le attenuanti e anche che nessun uomo nasce cattivo o sbagliato o delinquente ma è un mix di habitat, famiglia, società e privazioni che lo portano sulla cattiva strada.
di colpa, sarà proprio il magistrato (in scena Giuseppe Nitti in toga, attento e rigoroso, si muove fuori dalla frontiera di funi e cavi) che lo aiuterà con consigli pratici su come compilare le richieste per i permessi. Un senso di colpa non in quanto mano che ha deciso gli anni di punizione da scontare ma per la fortuna che alcuni hanno di nascere in alcune città e luoghi e in alcune condizioni familiari ed economiche, potendo studiare, rispetto ad altre fasce della popolazione che sono più soggette a cadere in mano, per povertà, analfabetismo e scarsa informazione, alla criminalità. La frase è “Se io nascevo dove è nato lui” che è un mettersi nei panni dell'altro, senza giustificare in maniera buonista le azioni ma considerando le attenuanti e anche che nessun uomo nasce cattivo o sbagliato o delinquente ma è un mix di habitat, famiglia, società e privazioni che lo portano sulla cattiva strada.
Il giudice muove il primo passo sulla scacchiera delle mosse tra i due regalando al carcerato “Siddharta” di Hermann Hesse  che prima di allora non aveva mai letto un libro e nessuno gli aveva mai donato niente. Scatta qui il rispetto e l'onore tra i due, senza che mai comunque il detenuto scenda a compromessi con l'autorità. Il sempre appassionato, competente e concreto Schinocca (in questa produzione targata Tedacà, Stabile di Torino con Festival delle Colline Torinesi) non fa un elogio del detenuto, non ne fa un'agiografia ma punta la messinscena sugli uomini e i loro sentimenti, su questo incrocio fatto di lettere tra una persona colta e un semianalfabeta che in definitiva sono due facce della stessa medaglia. La gioventù che se ne va, le attese continue, gli spostamenti da una struttura ad un'altra, i rinvii o le cancellazioni dei permessi per fatalità o contingenze, il 41 bis, le visite della compagna (Costanza Maria Frola, in un doppio ruolo, carica di verità scevra da pathos ed enfasi). Quella stessa “moglie” che gli arriva in sogno con l'abito da sposa e che, nella scena più toccante e intima, il tulle soffocherà l'uomo come stretto, asfissiato in un bozzolo ormai inerme, sconfitto. La pena non finisce neanche adesso per Salvatore ma gli uomini cambiano e si può essere “uomini d'onore” anche soltanto scrivendosi lettere.
che prima di allora non aveva mai letto un libro e nessuno gli aveva mai donato niente. Scatta qui il rispetto e l'onore tra i due, senza che mai comunque il detenuto scenda a compromessi con l'autorità. Il sempre appassionato, competente e concreto Schinocca (in questa produzione targata Tedacà, Stabile di Torino con Festival delle Colline Torinesi) non fa un elogio del detenuto, non ne fa un'agiografia ma punta la messinscena sugli uomini e i loro sentimenti, su questo incrocio fatto di lettere tra una persona colta e un semianalfabeta che in definitiva sono due facce della stessa medaglia. La gioventù che se ne va, le attese continue, gli spostamenti da una struttura ad un'altra, i rinvii o le cancellazioni dei permessi per fatalità o contingenze, il 41 bis, le visite della compagna (Costanza Maria Frola, in un doppio ruolo, carica di verità scevra da pathos ed enfasi). Quella stessa “moglie” che gli arriva in sogno con l'abito da sposa e che, nella scena più toccante e intima, il tulle soffocherà l'uomo come stretto, asfissiato in un bozzolo ormai inerme, sconfitto. La pena non finisce neanche adesso per Salvatore ma gli uomini cambiano e si può essere “uomini d'onore” anche soltanto scrivendosi lettere.
Tommaso Chimenti 10/05/2023
Foto: Emanuele Basile
Michele Serra: cultura, ironia, giornalismo, vita, soprattutto parole
PRATO – “Le parole che ho detto e chissà quante ancora devono venire, strette tra i denti, risparmiano i presenti, immaginate, sentite o sognate, spade fendenti, al buio sospirate, perdonate, da un palmo soffiate” (Pacifico, “Le mie parole”).
Negli ultimi anni si sono affacciati nei teatri personaggi che niente avevano a che vedere con la scena, con la messinscena, con il teatro: da Beppe Grillo a Travaglio, da Federico Rampini a Francesco Piccolo, solo per citarne alcuni. Alcuni fanno comizi, altri sono veri e propri affabulatori; Michele Serra invece è un comunicatore, che da anni porta in giro la sua “Amaca di domani” (visto al Politeama Pratese; dalla striscia “corsivo” che quotidianamente campeggia su La Repubblica), è un carismatico timido che arringa le folle sommesso, a bassi decibel con l'intelligenza del sarcasmo e la consapevolezza della sua scrittura, brillante, ficcante, puntuale, precisa. Con la sua “Amaca” ha affrescato tutti i giorni in questi ultimi trent'anni la nostra Storia, quella delle vicende italiche,  politiche soprattutto, ma anche di costume, commentando notizie più o meno grandi, donandoci un punto di vista mai banale o scontato ma sempre pensato, riflessivo, ponderato. Interista convinto, di sinistra, cresciuto a Milano, prima a L'Unità poi a Repubblica, L'Espresso, soprattutto Cuore. Quello che ci mette, con la sua calma e aplomb, leggerezza frugale e profondità mai pesante. Il suo monologo (anzi un dialogo con la mucca in scena; è del '97 il suo libro “Il ragazzo mucca”) è una lezione di giornalismo che diventa ben presto una lezione di vita senza moralismi, senza farsi guru, senza diktat, senza regole. Ci appassiona con il suo disincanto, senza cinismo, ed equilibrio nel rappresentare e tratteggiare le faccende di casa nostra.
politiche soprattutto, ma anche di costume, commentando notizie più o meno grandi, donandoci un punto di vista mai banale o scontato ma sempre pensato, riflessivo, ponderato. Interista convinto, di sinistra, cresciuto a Milano, prima a L'Unità poi a Repubblica, L'Espresso, soprattutto Cuore. Quello che ci mette, con la sua calma e aplomb, leggerezza frugale e profondità mai pesante. Il suo monologo (anzi un dialogo con la mucca in scena; è del '97 il suo libro “Il ragazzo mucca”) è una lezione di giornalismo che diventa ben presto una lezione di vita senza moralismi, senza farsi guru, senza diktat, senza regole. Ci appassiona con il suo disincanto, senza cinismo, ed equilibrio nel rappresentare e tratteggiare le faccende di casa nostra.
Dietro sul fondale passano nuvole pasoliniane prima e cadono parole dopo, come nel videoclip di “Alphabet Street” di Prince. La mucca, con la sua aria sorniona e con il suo modo di stare al mondo che sembra che niente la tocchi né la sfiori, potrebbe stare ore a guardare un punto nell'infinito. La mucca, gli animali, sono il silenzio, mentre l'uomo parla, pure troppo, deve dire, farsi un'idea, comunicarla a voce alta necessariamente. La sua professione è stata ed è avere un'opinione sul mondo, sulla cronaca stringente, sull'attualità concreta e vivida del momento.  E' autorevole senza mai essere né spocchioso né arrogante nell'esprimere la sua visione dell'intorno con un'intelligenza ferma, spigliata, elettrica e saggia mai noiosa né didascalica né accademica. Certamente non si mette sul piedistallo per spiegarci la vita, anzi è proprio un intellettuale che si muove attraverso il dubbio, la domanda, l'incertezza, l'indecisione, senza certezze ma solo supportato dal ragionamento e non da verità dogmatiche strumentalizzate. Non ha pretese di insegnamento né di avere la verità in tasca.
E' autorevole senza mai essere né spocchioso né arrogante nell'esprimere la sua visione dell'intorno con un'intelligenza ferma, spigliata, elettrica e saggia mai noiosa né didascalica né accademica. Certamente non si mette sul piedistallo per spiegarci la vita, anzi è proprio un intellettuale che si muove attraverso il dubbio, la domanda, l'incertezza, l'indecisione, senza certezze ma solo supportato dal ragionamento e non da verità dogmatiche strumentalizzate. Non ha pretese di insegnamento né di avere la verità in tasca.
Ha vissuto di parole e le parole sono state sue amiche (assonanza con amaca) ma le parole possono essere a volte anche pericolose, possono essere un'arma. Il suo pubblico lo conosce per la carta stampata, infatti l'età media è over fifty: fa sorridere, ma anche fa venire nostalgia e tenerezza per gli anni passati e ormai alle spalle, l'elenco delle cose che le giovani generazioni non hanno né visto né conosciuto come i telefoni a gettoni o le cartine stradali per muoversi in auto, i 45 giri. Ci fa sentire un po' meno soli. E ci fa entrare nei giornali degli anni '70-'80, le rotative, il senso tattile del cartaceo caldo appena stampato, il nero dell'inchiostro, la magia della carta scrocchiante sotto le dita, il prodotto realizzato grazie alle intelligenze di tante persone che hanno lavorato insieme. Ci racconta delle sue Amaca e non è mai una mera narrazione privata e personale ma ci fa sorridere perché apre spiragli e squarci dentro la nostra Storia comune, da Berlusconi fino a Rocco Buttiglione  con quella fine ironia che ci fa godere cerebralmente, mai sprezzante neanche dell'avversario politico più odioso, ma sempre intento a sottolineare più i vizi che le virtù della nostra classe dirigente o del nostro popolo perennemente equilibrista tra le stelle e il ridicolo.
con quella fine ironia che ci fa godere cerebralmente, mai sprezzante neanche dell'avversario politico più odioso, ma sempre intento a sottolineare più i vizi che le virtù della nostra classe dirigente o del nostro popolo perennemente equilibrista tra le stelle e il ridicolo.
Le parole sono state il centro della vita, professionale e non, di Serra, “Le parole sono potenti”, perché danno corpo a pensieri e sentimenti. Poi entra nel vivo, sviscera i suoi ricordi, ci apre il baule della sua memoria, la sua famiglia, un padre silenzioso, gli studi, gli incastri della vita, le coincidenze, le fortune, i percorsi e quella “sindrome dell'impostore” che non lo ha ancora abbandonato (lui che ha scritto libri, condotto programmi, fatto teatro, diretto giornali, figuriamoci noi comuni mortali). Cita Marx e Gramsci e poi accenna William Blake e Carmelo Bene fino a Dino Campana senza ergersi sul podio, ci dice che imparare è una fatica e che “le parole identificano chi le usa, raffigurano te stesso”. Un pozzo di scienza senza farla cadere dall'alto. “Le parole ci fanno compagnia”, “Usiamo le parole per farci coraggio”, “Le parole servono per mettere un po' di ordine nel mondo, per dare un nome alle cose che non riusciamo a dominare”. Un gran bel respiro di cultura. Una fortuna averlo ascoltato.
“Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare; sono giocattoli e zanzare, sabbia da ammucchiare, piccoli divieti a cui disobbedire” (Pacifico, “Le mie parole”).
Tommaso Chimenti 09/05/2023
“Gordon Pym” del Teatro Immediato: un viaggio teatrale sensoriale totalizzante
PESCARA – Ci sono momenti da festeggiare o per lo meno da sottolineare, da ricordare certamente. In questi giorni il Teatro Immediato di Pescara brinda un anno da quando ha aperto il suo spazio artistico nel quartiere periferico San Donato, intitolato all'amico scomparso Enzo Spirito. In questo anno se n'è andata un altro pezzo importante della compagnia diretta da Edoardo Oliva, la sorella Giulia, altra anima del gruppo. Nell'Immediato si fondono la vita e la morte, il passato e lo sguardo rivolto verso il futuro. Non ci si ferma, non si sta, non si aspetta ma si prospetta, si progetta, si getta il cuore oltre l'ostacolo. E l'anno prossimo saranno venti gli anni dalla fondazione del Teatro Immediato. Il piccolo e curato e accogliente nuovo spazio (si percepisce netta la stima e la vicinanza del pubblico) sorge all'interno di un palazzo che ha in sé, naturalmente, nella sua intima architettonica originaria, due “palchi naturali”, uno all'esterno con un cerchio contornato da ringhiere  (un parco-giardino dove poter organizzare anche eventi itineranti) e un secondo, ancora più affascinante, nella corte rotonda interna sulla quale si affacciano le volte (ricorda l'impianto della struttura iconica della pellicola “Aria ferma” ma anche le scale dello stadio milanese di San Siro) che salgono fino al quarto piano come dei palchetti di un teatro all'italiana. Un luogo dove certamente si può tentare di solcare nuove strade artistiche e qui Oliva e lo scrittore Roberto Melchiorre sicuramente faranno germogliare nuovi frutti.
(un parco-giardino dove poter organizzare anche eventi itineranti) e un secondo, ancora più affascinante, nella corte rotonda interna sulla quale si affacciano le volte (ricorda l'impianto della struttura iconica della pellicola “Aria ferma” ma anche le scale dello stadio milanese di San Siro) che salgono fino al quarto piano come dei palchetti di un teatro all'italiana. Un luogo dove certamente si può tentare di solcare nuove strade artistiche e qui Oliva e lo scrittore Roberto Melchiorre sicuramente faranno germogliare nuovi frutti.
Pescara terra di mare. E il mare si sa è sempre uno sbocco, l'apertura di una parentesi, un'idea di movimento, una via da percorrere, una possibilità di respiro, di sogno, di vedersi in altri panni, in altre terre. Il mare è il tramite tra l'adesso e il sarò. E questo debutto “Il mio nome è Gordon Pym” (adattamento di Melchiorre, regia di Oliva), tratto dalle pagine cariche di buio e crude di Edgar Allan Poe ha in sé proprio il germe della sperimentazione in un felice miscuglio tra musiche d'ambientazione, performance fisica quasi coreografica e video. Quello che incuriosisce è che i due attori (lo stesso Oliva e Ezio Budini, somiglia fisicamente a Tommaso Ragno) in scena non parlano né dialogano ma agiscono e si muovono sulle parole di una voce fuori campo che narra la vicenda di questi due marinai che attraversano mille peripezie tra salvezza e dannazione, tra sogno e incubo. Siamo dentro un mondo mobile, senza punti di riferimento se non i marosi, con l'orizzonte che fluttua, che ondeggia in alto e in basso, che oscilla e scuote. E all'interno del teatro, piccolo e giustamente intimo (perfetto per uno spettacolo dal vivo come questo Gordon Pym dove bisogna stare dentro la materia, assaporarne il gusto, il respiro, il rantolo, il sangue e sudore), si crea un'atmosfera empatica tra platea e palco e, grazie a luci e musiche enfatiche e metaforiche, toccanti e agitate, per un'ora siamo tutti sulla stessa barca, a lottare con vele e vento, tra squali e salsedine che sembra di sentirla sulla pelle, l'arsura sulle labbra, le reti smagliate, le fiocine arrugginite, il timone di legno e l'ancora pesante. In scena (ideata da Francesco Vitelli) un pezzo di un'imbarcazione che ci ha ricordato l'installazione di Claudio Parmiggiani “Naufragio con spettatore”, una sorta di Arca mangiata e fatta a pezzi, senza perdono, senza Terra Promessa da raggiungere.
E' un  viaggio reale tra gli Oceani e un viaggio dantesco verso gli inferi e l'abisso inquieto che ci portiamo dentro, che ci trasciniamo in fondo allo stomaco dalla nascita come un macigno. I riferimenti possono essere tanti e si aprono continue finestre di senso che vanno ad assommarsi, a sfogliarsi, ad esfoliarsi, a prendere nuova linfa e corpo: i due marinai possono essere benissimo Pinocchio e Geppetto dentro la caverna-intestino del pescecane collodiano, l'aria minacciosa è quella di “Cuore di tenebra”, mentre si possono annusare stralci di “Gulliver” nella scoperta di mondi alternativi, come di “Alice” nella psichedelia che tutto trasforma, deforma e strazia. E' un racconto cinematografico (i video sono a cura di Francesco Calandra e Daniele Campea) agito e adrenalinico che ti scava, ti consuma, ti corrode, ti digerisce, ti prende a morsi, non lascia tranquillo lo spettatore che anzi mette alle corde. Siamo anche noi uomini di fatica tra ammaraggi e ammutinamenti, violenza glaciale e brutale, tra l'impossibilità di fuga, l'impotenza e l'elettricità dentro ogni scelta, ogni bivio dove ti giochi la vita e la morte. Gli attrezzi dei due (bella alchimia fisica e gestuale, incastonati in uno spazio angusto, ci donano ancor più il retrogusto amaro della claustrofobia, dei muscoli, della perdizione, del logorio) sono queste corde spesse e ruvide che diventano legacci e strumento per impiccarsi come cordoni ombelicali salvifici.
viaggio reale tra gli Oceani e un viaggio dantesco verso gli inferi e l'abisso inquieto che ci portiamo dentro, che ci trasciniamo in fondo allo stomaco dalla nascita come un macigno. I riferimenti possono essere tanti e si aprono continue finestre di senso che vanno ad assommarsi, a sfogliarsi, ad esfoliarsi, a prendere nuova linfa e corpo: i due marinai possono essere benissimo Pinocchio e Geppetto dentro la caverna-intestino del pescecane collodiano, l'aria minacciosa è quella di “Cuore di tenebra”, mentre si possono annusare stralci di “Gulliver” nella scoperta di mondi alternativi, come di “Alice” nella psichedelia che tutto trasforma, deforma e strazia. E' un racconto cinematografico (i video sono a cura di Francesco Calandra e Daniele Campea) agito e adrenalinico che ti scava, ti consuma, ti corrode, ti digerisce, ti prende a morsi, non lascia tranquillo lo spettatore che anzi mette alle corde. Siamo anche noi uomini di fatica tra ammaraggi e ammutinamenti, violenza glaciale e brutale, tra l'impossibilità di fuga, l'impotenza e l'elettricità dentro ogni scelta, ogni bivio dove ti giochi la vita e la morte. Gli attrezzi dei due (bella alchimia fisica e gestuale, incastonati in uno spazio angusto, ci donano ancor più il retrogusto amaro della claustrofobia, dei muscoli, della perdizione, del logorio) sono queste corde spesse e ruvide che diventano legacci e strumento per impiccarsi come cordoni ombelicali salvifici.
Corda come limite e frontiera ma anche sbarre da non poter attraversare, e ancora fune alla quale tenersi per non cadere nel buco nero che tutto inghiotte e fagocita. Impossibile non pensare a “Moby Dick” come a “Il vecchio e il mare”, ecco che ci sovviene “Ventimila leghe sotto il mare” ma anche “Novecento” ed è inevitabile non far riaffiorare “La tempesta” shakespeariana e come non pensare ad Ulisse. Ci sono venuti prepotentemente alla memoria anche la compagnia teatrale Cajka di Francesco Origo che aveva ideato i Teatri di Mare, per oltre venti anni hanno portato teatro utilizzando la loro barca a vela come palco attraccando nei porti della Sardegna circumnavigandola. L'ammasso e impasto di sensazioni ci trasportano in altre dimensioni sensoriali a valanga, a cascata, a precipizio immersi in questa performance parimenti dei bicipiti e dell'anima. Qui il “sapore di sale” è ferroso come il sangue e non certo frivolo. E' una narrazione croccante, materica, tattile, dove si sente chiaramente il sole, il rum, gli afrori, la paura dell'andare alla deriva. Sono (siamo) naufraghi o già fantasmi carontiani in questa avventura che non promette redenzione né alcun colpo di spugna a cancellare colpe e ingiustizie. Le corde sono budella aggrovigliate, nodi da sciogliere, suggestioni da estirpare per un'esperienza della platea non vista né subita passivamente ma vissuta sulla nostra pelle.
Tommaso Chimenti 07/05/2023
Foto: Carlo Pavone
F
Maria Cassi e Leonardo Brizzi con il loro “Alè” inno alla vita
FIRENZE – Maria Cassi è tornata e lo ha fatto alla grande, nel suo stile inconfondibile, nella sua cifra unica e inimitabile. Ed è in formissima. Dopo un paio di spettacoli di ripresa e di “alleggerimento”, “Diamine” e “La solita zuppa”, con il nuovo “Alè”, sempre insieme al fidatissimo Leonardo Brizzi al pianoforte e nel ruolo della spalla impostata e compunta contraltare della sua energia e follia scenica, si è tornati ad applaudire a piene mani alla sua fiorentinità, al trionfo di una comicità sincera, che non è passata mai di moda. Le sue battute, la sua gestualità da mimo consumato, le facce esplosive, la bocca usata in mille espressioni, il gergo tutto nostrano (che piace in egual modo ai suoi concittadini come ai tanti stranieri che affollano il Teatro del Sale), i modi di dire forzati ed esagerati sempre efficaci. E “Alè” è un inno alla vita dopo il periodo difficile della chiusura del Covid prima e successivamente della scomparsa del compagno Fabio Picchi, ideatore e fondatore del concetto del Sale, un mix inscindibile tra musica, teatro e buon cibo in un luogo magico. Un “Alè” contro le brutture, contro la sfortuna, contro le negatività, un saluto al domani pieno di sorprese, un andare incontro  alla bellezza, senza lasciarsi schiacciare dai momenti no, un sorriso al nuovo, all'ignoto, un lasciarsi andare incontro al futuro pieno di sorprese, un racconto poetico ed emozionale, un abbraccio senza preclusioni né pregiudizi, un saluto al Sole della risata che rischiari sempre il buio dei nostri tempi.
alla bellezza, senza lasciarsi schiacciare dai momenti no, un sorriso al nuovo, all'ignoto, un lasciarsi andare incontro al futuro pieno di sorprese, un racconto poetico ed emozionale, un abbraccio senza preclusioni né pregiudizi, un saluto al Sole della risata che rischiari sempre il buio dei nostri tempi.
Non possono mancare i suoi classici tormentoni, ai quali il suo pubblico si è fidelizzato e non vorrebbe mai rinunciare: le sue digressioni sul “ragionare” dei fiorentini, il discorrere principalmente sul nulla, lo “scuotere la testa”, segno distintivo di chi abita vicino all'Arno, l'avere il “palletico”, ovvero non stare mai fermo un attimo, le lamentele continue come mantra, quell'“oioi” cantilenato, i “canti” che a queste latitudini sono gli angoli delle strade dantesche. E' una rana dalla bocca larga con una mimica facciale che inevitabilmente fa esplodere il riso, improvvisa un gramelot, giocando con la sensualità intonando un'aria in tedesco (e qui ci ha ricordato Ute Lemper), ora è “fantozziana” piena di tic nervosi e nevrosi, adesso canta a cappella dimostrando alte doti canore.
Con il Maestro di pianoforte Brizzi, il loro rapporto artistico va avanti da trentacinque anni, che fa il serioso e la spalla rigida, opposto della sua imprevedibilità stupefacente, l'alchimia, i ritmi e i tempi ormai sono naturali e spontanei e si muovono come un unico organismo: rappano oppure si cimentano in Stanlio ed Ollio o ancora si lanciano in sfide non-sense cariche di buon umore. Non puoi non sorridere, non puoi non farti venire le  rughe d'espressione agli angoli delle labbra. Non ci si stancherebbe mai neanche di seguire un altro dei suoi cavalli di battaglia più longevi, “La morte del cigno” esilarante, che sempre scatena risate contagiose. Il suo duetto con gli ottantotto tasti ci porta ad un medley dove dal “Don Giovanni” si passa a “Un cuore matto” di Little Tony arrivando ad “Azzurro” di Celentano fino ai Blues Brothers e concludendo con Fred Buscaglione. La gag con la lingua fuori è un pezzo di bravura da
rughe d'espressione agli angoli delle labbra. Non ci si stancherebbe mai neanche di seguire un altro dei suoi cavalli di battaglia più longevi, “La morte del cigno” esilarante, che sempre scatena risate contagiose. Il suo duetto con gli ottantotto tasti ci porta ad un medley dove dal “Don Giovanni” si passa a “Un cuore matto” di Little Tony arrivando ad “Azzurro” di Celentano fino ai Blues Brothers e concludendo con Fred Buscaglione. La gag con la lingua fuori è un pezzo di bravura da  sottolineare, così come quella spassosissima del “Voltapagine”, la persona che durante i concerti di musica classica ha il compito di girare le pagine degli spartiti di un solista, che in questo caso però è distratto, cialtrone, sbadato e disattento creando caos clownesco e confusione indicibile sul palco. Maria Cassi si merita il Fiorino d'Oro, le chiavi della città per essere da tanti anni ambasciatrice di Firenze, per il suo amore per la città di Brunelleschi e Michelangelo, per averla portata sui palcoscenici nel mondo e per aver regalato ed elargito così tanto buonumore. La formidabile Cassi è Firenze, l'una compenetrata nell'altra.
sottolineare, così come quella spassosissima del “Voltapagine”, la persona che durante i concerti di musica classica ha il compito di girare le pagine degli spartiti di un solista, che in questo caso però è distratto, cialtrone, sbadato e disattento creando caos clownesco e confusione indicibile sul palco. Maria Cassi si merita il Fiorino d'Oro, le chiavi della città per essere da tanti anni ambasciatrice di Firenze, per il suo amore per la città di Brunelleschi e Michelangelo, per averla portata sui palcoscenici nel mondo e per aver regalato ed elargito così tanto buonumore. La formidabile Cassi è Firenze, l'una compenetrata nell'altra.
Tommaso Chimenti 01/05/2023
Libro della settimana
-
 "Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…