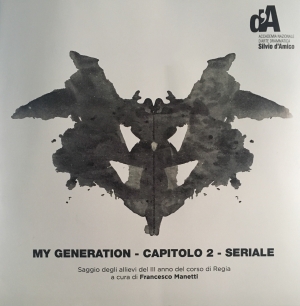My Generation - Capitolo 2 - Seriale: la violenza e il mito contemporaneo del serial killer
La mitologia contemporanea e la psicologia del serial killer sono i temi centrali da cui si sviluppano i tre allestimenti di My Generation, il saggio, a cura del Maestro Francesco Manetti, che gli allievi registi di terzo anno dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica "Silvio D’Amico" hanno realizzato in collaborazione con gli allievi attori del primo anno.
Giunto al secondo capitolo, il progetto My Generation continua a sviscerare le potenzialità sceniche della violenza umana, questa volta con tre drammaturgie originali ispirate a reali assassini seriali: Fritz Harmaann, Edmund Kemper e Andrew Cunanan.
Il primo spettacolo, La luna di Fritz, è scritto e diretto dall’allievo Danilo Capezzani con la collaborazione dell’assistente drammaturgo Alessio Moneta e già nel titolo evoca chiaramente il Licantropo di Hannover, Harmaann. Notevole è in questo caso lo sforzo di regia che riesce a creare l’illusione di una comunicazione fra tempi e spazi differenti: da un lato l’intenso l’io narrante di un folle Harmaan, interpretato da Francesco Brullo, e dall’altro la ricostruzione delle sue terribili gesta. Su due piani diversi, verbale e performativo, viene rappresentato il medesimo il rito morboso fra vittime e carnefice ed è così che lo spettacolo nel suo insieme riesce a trascinare il pubblico nell’abisso mentale dell’omicida.
Il secondo spettacolo, Totem, compie un salto storico di circa mezzo secolo verso l’agghiacciante storia di Ed Kemper come simbolo patologico del "maschio castrato", valida oggi come negli anni Settanta. L’arguzia, la folle consapevolezza e la cinica lucidità di Kemper traspaiono perfettamente nel testo di Matilde D’Accardi e nel personaggio interpretato da Gabriele Pestilli. Anche in questo caso, il regista Federico Orsetti sceglie una sovrapposizione di tempi e spazi, mostrando tuttavia in maniera più netta, attraverso codici illuminotecnici, la distinzione fra il presente e i flashback. Pur se estrema nella sua evocazione, la violenza non colpisce mai direttamente il pubblico e forse anche per questo rimane impressa a un livello più profondo, psicologico, come rimane impresso visivamente l’emblematico totem finale.
Infine, Dopo di me il diluvio, diretto da Caterina Dazzi e scritto da Marco Fasciana, mette in scena un interessante intreccio di monologhi paralleli e indipendenti, idealmente pronunciati in tempi diversi dallo stesso personaggio, Andrew Cunanan, intrepretato da sei diversi attori, al momento dei suoi cinque omicidi e del suo suicidio. È uno spettacolo che si sviluppa per sottrazione, su una scena nuda in cui è solo l’intensità delle parole a evocare sia il contesto della Miami anni Novanta sia le situazioni violente che sono il fulcro dello spettacolo. Il richiamo a Gianni Versace è evidente già nel riferimento al suo assassino, ma costituisce solo l’apice di una riflessione psicologica più complessa sulla spasmodica ricerca di successo e visibilità attraverso gesti eclatanti e irreversibili. Si tratta di un’idea complessa, nel senso che richiede forse allo spettatore una maggiore conoscenza delle vicende biografiche del protagonista e richiede al contempo uno sforzo di interpretazione iniziale che, tuttavia, una volta effettuato permette di apprezzare ancor di più la costruzione asciutta, essenziale e brutale della messa in scena.
Valeria Verbaro, 14/04/2019
“Sulla Riva di un Lago” di Luigi Siracusa, studio da “Il Gabbiano” di Anton Čechov, al Teatro "E.Duse" di Roma il 2 e 3 marzo 2019
“Il problema non sta nelle forme vecchie e nuove, ma nella capacità di esprimere liberamente quello che uno ha dentro”. La libertà dell’artista cos’è se non comunicare tramite un testo, un oggetto o un gesto ciò che si prova? Il Gabbiano di Anton Čechov è un’amara riflessione sulla ricerca di questa libertà.
Luigi Siracusa, allievo regista del II anno dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, con il suo studio Sulla Riva di un Lago – tratto da Il Gabbiano per il "Progetto Čechov", saggio degli allievi a cura di Giorgio Barberio Corsetti – accoglie lo spettatore in un mondo inquieto e surreale. La ricostruzione del molo occupa in lunghezza la sala del Teatro Studio “E.Duse” di Roma ed un fitto banco di nebbia, che ne cela la profondità, alimenta negli occhi di chi guarda l’idea che possa essere infinito. Il giovane regista siciliano ci introduce così in un sogno, alimentato dai suggestivi canti dell’interprete Cecilia Bertozzi e dall’accompagnamento live del musicista e compositore Luca Nostro che, con voce e melodia, riescono a guidare le nostre emozioni, e così la visione, in una sorta di atipica narrazione.
La nota attrice teatrale Arkadina (Zoe Zolferino), con suo figlio Kostja (Lorenzo Ciambrelli), è in visita nella tenuta di campagna del fratello Sorin (Giovanni Scanu). Kostja è un giovane drammaturgo ed approfitta dell’incontro per mettere in scena un suo spettacolo con protagonista Nina (Carlotta Gamba), un’aspirante attrice di cui è invaghito, spingendo così l’amica Maša (Caterina Rossi), innamorata di lui, a sposare un uomo che non apprezza, Medvedenko (Diego Parlanti). La giovane e bella Nina si innamora però di Trigorin (Michele Enrico Montesano), uno scrittore affermato (amante di Arkadina) che, prima di andar via, le promette che si rincontreranno presto. Dopo due anni si ritrovano tutti alla tenuta di campagna: Nina è diventata attrice, lei e Trigorin si sono lasciati e Kostja, sempre più sconfortato e depresso, decide in quell’occasione di togliersi la vita.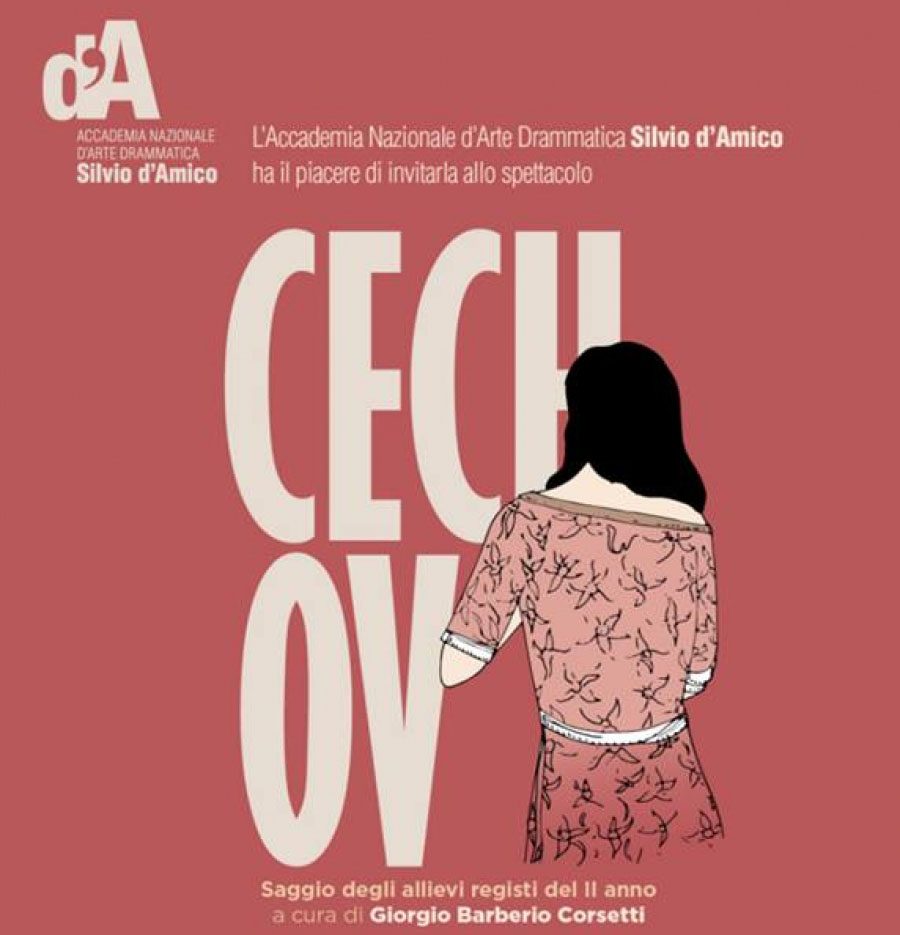
L’intera opera è il racconto di un sogno, quello del successo artistico e di come l’arte e questa bramosia di affermazione influiscano sulla vita. Il lago, sulla riva del quale assistiamo alla vicenda, è la rappresentazione proprio di quel sogno e Nina ne è profondamente attratta “come un gabbiano”. Perché è questo che rappresenta simbolicamente il gabbiano: quella libertà artistica tanto ricercata dai protagonisti, quella che Nina o Arkadina provano quando recitano e Trigorin e Kostja quando scrivono. Ma il giovane e tormentato Kostja, proprio sulla riva di quel lago, porta all’amata Nina la carcassa di un gabbiano che lui stesso ha ucciso. Lo ha ucciso perché essere un artista è più di un mestiere, perché come dice Trigorin “è una vita da cani”: cosa c’è di così meraviglioso nel non riuscire a smettere di scrivere? Nell’esserne ossessionati? Nina non riesce ancora a comprendere come l’arte possa distruggere la loro vita, come possa rendere così insoddisfatti perfino nel successo. Ma quella giovane donna che ha “passato tutta la vita sulle rive di questo lago”, dopo esser scappata di casa per fare l’attrice ed aver scoperto di non essere poi così brava, finirà in quello stesso vortice di ossessione e delusione. E quando il sogno diviene incubo, quando ci si ritrova stretti in questa morsa, le scelte sono solo due: resistere come Nina, che sopporta e va avanti, o arrendersi come Kostja, che sceglie di liberarsi nella resa. L’allievo regista Luigi Siracusa – avvalendosi del brillante cast di allievi del II anno di recitazione dell’Accademia “Silvio d’Amico” – mette meravigliosamente in scena un’interpretazione chiara, suggestiva e potente dell’opera di Čechov: un’analisi del rapporto tra l’amore, l’arte e la vita, rappresentati in quell’atmosfera di sogno, surreale ma tangibile, che solo il Teatro può ancora creare.
Silvia Piccoli 04/03/2019
Libro della settimana
-
 "Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…