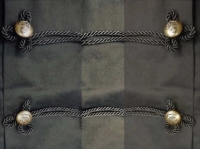Alberto Melone della Compagnia dei Masnadieri indossa l’uniforme e veste per la prima volta la divisa del tenente Giovanni Drogo in "La Fortezza. Momento unico per tre attori soli", adattamento teatrale da Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, in scena dal 19 al 31 marzo allo Spazio 18 b.
Perché la scelta di portare in scena Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati?
Il testo è stato pubblicato nel 1940 ma per Massimo Roberto Beato, che ha curato la drammaturgia e l’adattamento, e la regista, Elisa Rocca, è un testo attuale proprio perché è costruito sulla non definibilità di un contesto storico e geografico preciso in cui si svolge la narrazione. È uno spazio sospeso in cui lo scorrere del tempo ha la forma di un’attesa senza termine, nella quale ci si volge indietro e non in avanti. Invece che un futuro distopico, potrebbe definirsi un passato distopico. La Fortezza nel deserto è come una campana di vetro, il cuore ovattato di un meccanismo inceppato e incontrollabile che gira su se stesso. A questo proposito, il capitano Ortiz è il personaggio “anziano”, nel senso di disilluso e disincantato, che più di tutti rappresenta La Fortezza, perché all’interno della Fortezza Bastiani ci ha passato e consumato tutta la vita.
Avete avuto dei punti di riferimento per la costruzione dello spettacolo? Penso, per esempio, al film del 1976 di Valerio Zurlini.
Nessun riferimento al film. Il lavoro di Elisa Rocca è stato un lavoro di rilettura del testo drammaturgico scritto da Massimo Roberto Beato, che a sua volta lo è stato dell’originale di Buzzati. Se c’è un qualche riferimento è al teatro di Tadashi Suzuki, fra le personalità più importanti della scena teatrale giapponese contemporanea. La regia di Elisa si basa proprio sul metodo Suzuki, che unisce nō e kabuki moderni e che prevede un lavoro specifico sul corpo e sulla fisicità dell’attore, la cui scelta determina la rappresentazione e la resa scenica. Tutti quei paesaggi rocciosi fatti di strade deserte, della durezza desolante della pietra, che si leggono nel libro e si vedono nei disegni e bozzetti di Buzzati, si fanno corpo nella scena vuota attraverso noi, appunto, “attori soli”. Lo spettacolo è una scrittura visuale dove sono i corpi a farsi immagini e paesaggio nello spazio scenico.
Cosa viene sacrificato e cosa resta nel testo drammaturgico, La Fortezza. Momento per tre attori soli, del testo di Buzzati?
Lo spettacolo è per lo più incentrato sul personaggio di Giovanni Drogo, il mio personaggio. Il sottotitolo Momento per tre attori soli indica che il lavoro teatrale non è diviso in atti, ma si concentra su un unico momento scelto, un dettaglio, un brandello di tempo. Nel libro, la storia di Drogo alla Fortezza Bastiani dura tutta una vita. Quel che viene sacrificato è il racconto di una narrazione lineare nella forma teatrale tradizionale degli atti, quel che resta è una sintesi evocata per immagini e allegorie.
Qual è la fatica che hai fatto nell’affrontare il tuo personaggio?
Ho dovuto immaginare il corpo di un uomo confinato in una fortezza ai limiti del deserto e avere coscienza che quell’uomo consuma la sua esistenza nell’inutile attesa dell’invasione dei Tartari, o chissà cosa, che non arriveranno mai. In questo sono stato seguito dalla regista che mi ha guidato, durante la lettura della drammaturgia e le prove, alla creazione della partitura fisica del personaggio. Il personaggio di Drogo, già a una prima lettura, porta alla struttura fisica del testo: battuto dal ritmo interno che hanno tra loro le parole, scandito dalle pause e dai silenzi di un tempo immobile, viene tradotto in azione. Come ho detto, sia Drogo sia l’intero testo drammaturgico sono pensati sul metodo Suzuki giapponese.
Cosa rappresenta per te l’infinita attesa dei Tartari?
I Tartari sono il confine, la frontiera, il limite dell’inimmaginabile, la fuga del tempo. L’idea dell’arrivo dei Tartari genera azione e adrenalina tra i soldati che fremono, allo stesso tempo, dalla paura e dalla voglia di combattere nella speranza che la routine di una quotidianità alienante si spezzi. Dire routine o immaginare, come ha fatto Buzzati, una fantastica militarizzazione della vita è la stessa cosa.
Parlando di routine, come scorre il tempo nella tua vita artistica di attore e qual è il rapporto tra il tempo sulla scena e il tempo della vita reale?
Quello dell’attore è un mestiere che ti cambia e soprattutto che ti apre al nuovo con sempre nuovi stimoli a dispetto della routine. Per me, almeno, è così in scena e nella vita. Prima di fare l’attore, invece, ricordo di essere sempre stato timido e certamente più chiuso.
Nel comunicato stampa si legge che attraverso il personaggio di Drogo si riflette sul destino degli “anti-soggetti”, gli sconfitti. La Fortezza è infatti il primo capitolo della “Trilogia degli sconfitti”. Puoi parlarci di questo progetto di ricerca e di come si è sviluppato nel corso dei tre anni di Accademia?
La Fortezza è il primo capitolo della “Trilogia degli sconfitti”, progetto di ricerca triennale di indagine sulla generazione nata tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento, attraverso gli echi e gli spunti offerti sia dalla letteratura classica che dalla drammaturgia contemporanea. La battaglia degli sconfitti è interiore, Drogo combatte contro se stesso nell’attesa dei Tartari, nell’attesa cioè che nella sua vita qualcosa cambi, e quello verso la fortezza nel deserto è un viaggio senza ritorno. Ma l’idea di trasformare Il deserto dei Tartari in un lavoro teatrale nasce anni fa, nel 2015, quando la Compagnia dei Masnadieri ha portato in scena Il castello di K, adattamento di Massimo Roberto Beato da Il castello di Franz Kafka e regia di Jacopo Bezzi. Kafka è considerato il Buzzati italiano, non c’è racconto, romanzo o commedia dove i critici non abbiano trovato somiglianze e analogie tra l’autore italiano e lo scrittore boemo.

Com’è stato lavorare con Massimo Roberto Beato che ha curato l’adattamento?
Mi sono diplomato cinque anni fa e quello con la Compagnia dei Masnadieri è stato il primo contratto dopo la fine dell’Accademia. Ammetto che inizialmente è stato per sostituzione, ma alla fine, oggi, sono ancora qui.
Chi vorresti vedere seduto in platea a vederti la sera della prima?
Massimo Popolizio, che ho conosciuto negli anni di studio all’Accademia e con cui ho avuto modo di lavorare durante alcuni stage. Sono rimasto affascinato dalla sua capacità straordinaria di essere un attore di parola, dal suo modo di stare in scena e di essere corpo nella voce. Senza alcun movimento riesce a farti vedere tutto, a fare incontrare attore e spettatore.
Elvia Lepore, 21.03.2019