
Da qualche anno a questa parte, ormai, una delle espressioni d’ordine legate al mondo del cibo e della gastronomia è quella di street food, letteralmente cibo da strada. Per chi ancora non si fosse imbattuto in questa nuova locuzione gastronomica, lo street food si riferisce a tutti quegli alimenti, bevande incluse, pronti per essere consumati all’ombra refrigerante di un albero o comodamente seduti su una panchina, per strada o in qualsiasi luogo pubblico in cui siano presenti furgoncini, ape car e carretti ambulanti, attrezzati di tutto punto. Non è certamente la modalità di consumo del cibo, per strada, ad aver conferito il carattere di novità allo street food ma l’aspetto che più degli altri ha portato questa tendenza gastronomica così in voga negli ultimi anni è quello della qualità del cibo proposto, oltre all’innegabile economicità. Cosa non da poco, se si considera l’enorme differenza di prezzi e costi alla quale si va incontro, se si decide di cedere al confort di  una sedia e un tavolo di un ristorante, muniti di forchetta e coltello e coperti da un tovagliolo intorno al collo, per evitare di sporcare i vestiti. Certamente una comodità cui è difficile rinunciare, in certi casi ma un rischio che si è disposti a correre se la posta in gioco è doppia: qualità e risparmio.
una sedia e un tavolo di un ristorante, muniti di forchetta e coltello e coperti da un tovagliolo intorno al collo, per evitare di sporcare i vestiti. Certamente una comodità cui è difficile rinunciare, in certi casi ma un rischio che si è disposti a correre se la posta in gioco è doppia: qualità e risparmio.
Ecco, allora, che intorno a questa straordinaria food tend si è sviluppato un vero e proprio business, a volte legato a quello dello show, con la creazione di programmi televisivi dedicati esclusivamente ai migliori strett food d’Italia, e non solo che informano e guidano lo spettatore all’interno di una dimensione gastronomica che vede accrescere, anno dopo anno, puntata dopo puntata, i propri accaniti sostenitori.
Molteplici, infine, sono anche gli eventi promozionali legati al cibo di strada. Proprio in questi giorni, infatti, hanno avuto luogo alcuni importanti Festival di street food come Street Food Village, a Castiglion Fiorentino, e lo StrEat European Food Truck Festival a Udine, entrambe conclusi il 1 maggio Dal 13 al 15 maggio, invece, sarà la volta di Street Food Platea Cibis, nel verdeggiante contesto del Parco Ravizza di Milano.
Una sola raccomandazione: dimenticate posate e tovaglioli al collo, lo street food è una questione di carattere!
Chiara Paladini 01/05/2016
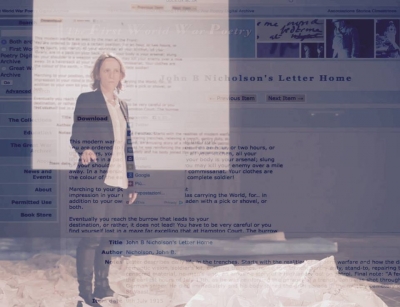
Raccontare per frammenti rendendo nuova la storia. Usare un linguaggio contemporaneo per tradurre un passato lontano. Situarsi all’incrocio di punti di vista diversi, per offrire una lettura inedita di un fatto estremamente conosciuto.
“Friendly Feuer: una polifonia europea” è un miscuglio ordinato di storie singole, di lotte personali, di confusioni che si incrociano e che si nascondo sotto il grande nome di “prima guerra mondiale”.
La regista e drammaturga Marta Gilmore ci accompagna alla scoperta di uno spettacolo che è capace di far emergere, dalle macerie di un passato glorioso e collettivo, la solitudine della disperazione.
Iniziando banalmente dal principio, come nasce l’idea di quest’opera?
"L’idea di partenza risiede nel mio personale interesse rispetto al tema della grande guerra e della vastità di questo evento, interesse che mi ha poi condotta verso argomenti specifici che man mano mi hanno colpito sempre più. Essendo io una persona che si è formata molto sull’idea di un‘identità nazionale, della storia dalla resistenza, della lotta antifascista, e del riconoscimento in alcune istanze collettive novecentesche, sono rimasta molto colpita dalla solitudine estrema che, invece, ha caratterizzato la guerra di trincea.
Atti singoli scollegati da movimenti ideologici: una mancanza di coscienza collettiva che sembrerebbe un tema molto legato al presente.
"Quello su cui mi sono interrogata è stato questo trovarsi a esprimere un rifiuto profondo verso la macchina bellica; e non parliamo di soggetti in grado di esprimere rivendicazioni di carattere politico o ideologico, ma di persone che si sono trovate a fare i conti con la loro assoluta fragilità, la solitudine di una persona che non si riconosce in un mondo da cui, però, non può scappare. Questo mi ha molto colpito e mi ha riportato al nostro presente, dove la resa viene interpretata esclusivamente come fallimento".
Stiamo parlando di un contesto, quello della guerra, in cui non è contemplata la possibilità di resa: l’utilizzo di questo titolo – friendly feuer, fuoco amico – ha un significato letterale o metaforico?
"Ci riferiamo a tutti i casi letterali e non in cui il fuoco amico non concede spazio di ritirata, di sottrazione. L’Italia è la nazione che ha punito con maggiore severità i propri soldati, la codardia in faccia al nemico era un reato vago che obbligava gli ufficiali a fucilare chiunque si rifiutasse di avanzare. Ma il fuoco amico può essere anche l’estremo autolesionismo, praticato ovviamente in connessione ad uno stato ultimo di disperazione".
Forse faccio un paragone per nulla originale, ma è quello che bisognerebbe pensare oggi rispetto a tutte quelle persone che abbandonano il proprio paese a rischio della propria vita.
"Ma infatti un altro collegamento col presente è proprio che cosa si fa per scappare la guerra: ci può essere un limite? Un’onnipresenza della grande guerra che oggi torna dentro l’Europa: il filo spinato. Posso io opporre un filo spinato a qualcuno  che tenta di scappare la guerra? In quale posizione impossibile metto io questa persona? Il diritto di andare ovunque io possa mettere me stesso al sicuro è un tema che riguarda l’Europa. E allora questo centenario che cos’è? È una bella festa dove noi piangiamo i nostri gloriosi soldati che hanno fieramente combattuto, ma contro chi? Contro altri soldati come loro e perché? E allora anche l’immagine del nemico cambia".
che tenta di scappare la guerra? In quale posizione impossibile metto io questa persona? Il diritto di andare ovunque io possa mettere me stesso al sicuro è un tema che riguarda l’Europa. E allora questo centenario che cos’è? È una bella festa dove noi piangiamo i nostri gloriosi soldati che hanno fieramente combattuto, ma contro chi? Contro altri soldati come loro e perché? E allora anche l’immagine del nemico cambia".
È strano come nel tempo ci siamo concentrati sulla negativa estremizzazione della figura del nemico, se si pensa che in opere antichissime (sto pensando alla Chanson de Roland), invece, l’altro era trattato con pari dignità.
"I tedeschi e i francesi che oggi per noi sono fratelli, come venivano dipinti? In che modo veniva costruita l’immagine dell’altro? È evidente che oggi in Europa dobbiamo porci delle domande. Non possiamo semplicemente immaginare un futuro che parte dalla lettura monofocale che noi abbiamo di questi eventi, perché poi le contraddizioni esplodono e noi rischiamo di non capirle".
La scenografia, un grande block notes. E poi quattro lingue che si fondono: è uno spettacolo che parla anche dell’ambivalenza del linguaggio, del suo potere liberatorio ma anche della sua possibilità di essere frainteso.
"Certo il fatto di capirsi o non capirsi determina la possibilità di superare degli stereotipi rispetto all’altro, è un tema questo delle lingue e dei linguaggi differenti che esisteva anche all’interno dello stesso esercito italiano. Ci interessava proprio questo aspetto irrisolto della comunicazione, con la lingua che dovrebbe farti sentire parte integrante di uno schieramento. Dovrebbe".
Uno spettacolo che si presta a cambiamenti e adattamenti e che, da quanto ho letto, gioca molto sulla relazione con il pubblico. Come reagisce lo spettatore a questa chiamata in causa?
"Il pubblico è interessato, dunque partecipa in maniera curiosa, volentieri si presta alla costruzione dello spettacolo che fa anche uso di tecnologia. In questo modo coinvolgiamo anche i giovani, raccontando una storia passata in maniera contemporanea. Lavorare sul linguaggio contemporaneo e la frammentazione della narrazione non deve e non vuole significare spettacolo di nicchia: vogliamo la relazione profonda col pubblico, soprattutto con i giovani, perché sono sempre loro a pagare a caro prezzo le conseguenze dei conflitti".
A un certo punto, i corpi vengono occultati da un grande foglio bianco.
"La carta è diventata la nostra scenografia. Siamo partiti dalle storie di coloro i quali, scioccati, non volevano e non potevano più parlare: ma scrivere sì. E poi abbiamo trasformato la scrittura in azione scenica, partendo da improvvisazioni in cui stendevamo i nostri percorsi drammaturgici su questo grande foglio ancora bianco; il bianco che poi è anche neve, poiché la guerra italiana è stata combattuta quasi esclusivamente in montagna. La carta è quindi diventata neve, ma anche immagine di oblio, di velo che copre. La carta che è anche la materia di cui è fatta quella memoria, memoria che è diventata, purtroppo, carta straccia".
La carta che da strumento di lavoro diventa il centro di riconoscimento dello spettacolo.
"Sì, e rappresenta anche l’ancoraggio alla scrittura e alla letteratura di guerra, su cui molto abbiamo lavorato. “La follia e la fuga” di Bruna Bianchi è uno dei testi cardini della nostra ricerca".
Quanto tempo avete impiegato per portare questo spettacolo ad avere una struttura compiuta?
"Abbiamo fatto un viaggio enorme: ci stiamo lavorando da due anni, ma in maniera non continuata. La drammaturgia di scena su cui abbiamo lavorato insieme è diventata testo, e poi abbiamo continuato a misurarci con l’opera anche quando era compiuto, seguitando a esplorare, cambiare, limare. Un viaggio di lavoro sulle fonti, un lavoro di scrittura, di riflessioni personale, di libri letti e di impegno, lungo, in sala prove".
Il vostro, in conclusione, è un grande lavoro collettivo che però si basa sulla crisi del singolo.
"Sì, ognuno di noi ha un suo filo sul piano drammaturgico; ognuno di noi ha una figura, una figura che lo ha portato alla crisi e, dunque, alla connessione profonda col personaggio. Le figure sono quelle del caduto, del reduce, dell’eroe, del graduato, del testimone e del nemico, ma non sono presenze dichiarate. Ognuno di noi non è un disertore vero e proprio, ma uno che scappa la guerra in maniera propria. Fili non dichiarati ma drammaturgicamente evidenti".
Anastasia Griffini 30/04/2016
Per la recensione dello spettacolo: https://www.recensito.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=14785:friendly-feuer-arti-memorie-e-lingue-tre-visioni-dello-spettacolo&Itemid=121

Il piccolo e confortevole Teatro alla Guilla, situato a pochi passi dalla Cattedrale di Palermo, in occasione dello spettacolo “Io sono mia madre”, accoglie il suo pubblico mostrando pareti agghindate da sette grandi fotografie in cui prevale un elegante chiaroscuro, raffiguranti un uomo/bambino che, in modo più o meno amorevole, tenta di prendersi cura di sé.
È così, con una mostra fotografica ad opera di Fulvio Bellanca, che prende il via lo spettacolo di Giuseppe Muscarello, prima ancora che lui si affacci a rivelare la sua coreografia.
E quando appare, lo fa dal fondo di una tenda nera, venendo quasi partorito sulle assi del palcoscenico. In uno stato larvale e a occhi chiusi, inizia a prendere confidenza con lo spazio circostante. Farà assai fatica ad elevarsi ma, a suon di carillon e battiti di cuore, la posizione bipede appena conquistata, gli permetterà di aprire gli occhi e indossare un abito femminile, fino a quel momento rimasto appeso sul fondo della scena, profeticamente senza alcun corpo al suo interno.
Man mano svanisce l’atmosfera poetica creatasi per fare posto a un racconto più didascalico: è lui madre e figlio; madre che accompagna, madre che rimprovera, madre che sorride e si rabbuia.
Una madre del tutto immaginata.
Scrive Giuseppe Muscarello: “Conservo nel cuore il ricordo di mia madre: bello, forte, intenso. È il ricordo della sua assenza. Grazie a esso è stato possibile costruire molti ricordi mai vissuti. Quante favole (non) mi ha letto. Momenti nostri che ancora (non) ricordo, quei momenti erano ogni momento e quei libri erano ogni libro. Nell’assenza generale io ero la fiaba, io ero la filastrocca, io ero mia madre. Il figlio più importante, l’unico. Ero io! Al centro delle sue attenzioni, danzavo al suono della sua voce”.
Infine, davanti a uno specchio su cui è scritto un fitto testo, l’autore principia una lettura di se stesso per bocca di sua madre: una riflessione reale e simbolica al contempo che narra di un popolo sensibile in grado di riconoscersi e di rivolgere cure amorevoli e piccole attenzioni; in fondo, “veniamo da noi stessi”.
Il progetto “Io sono mia madre”, nato dapprima come mostra fotografica, trasformatasi poi in performance danzante per divenire, infine, romanzo breve edito da Leima con illustrazioni di Nicola Console, non raggiunge l’intimo dei nostri precordi. Tra fotografie, danza e romanzo la nostra immaginazione non riesce a liberarsi, i (non) ricordi, le (non) favole risultano fin troppo evidenti, il dolore dell’assenza perde di intensità in un tentativo di ricostruzione.
Seppur si apprezzi l’esigenza creativa e l’eleganza stilistica, ci permettiamo di dire bonariamente che il progetto posto in essere dalla Compagnia Muxarte, fa pensare a quel vecchio adagio che recitava: “il troppo stroppia”.
Forse a volte fare meno aiuta.
Miriam Larocca 29/04/2016
Altri Articoli
Libro della settimana
-
 "Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto
"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…


